La letteratura tra fisica e patafisica
In un’epoca dominata dagli algoritmi e dalle pseudo certezze statistiche, ricordarsi che esistono anche le etimologie patafisiche fa bene alla mente e al corpo: alla mente perché sollecitano a pensare in modo divergente, al corpo perché se non altro fanno ridere, il che è attività anche fisica di non poco conto. Maestra in questo genere di scoperte oblique sulle parole è stata Maria Sebregondi, quando nel 1988, per Longanesi, pubblicò Etimologiario (riedito da Quodlibet nel 2015). Qui si legge che «Avvitare», vuol dire «far aderire saldamente alla vita»; «Asola» con l’a privativo, sta per «mai sola», perché è «sempre accompagnata da un bottone»; «Bisogno» invece è insieme «un sogno e il suo doppio». Come le ciliegie, un etimo patafisico tira l’altro e non si vorrebbe mai finire. Ogni parola è in potenza un evento etimologico. (Tra parentesi: «Evento – ci fa sapere Sebregondi – è emanato dal vento. Il carattere ventoso conferisce al termine un che d’incerto e vacillante, ma al tempo stesso nobile e fiero. Tutto dipende dal vento in questione»). Un buon etimologiario patafisico ci aiuta se non a sciogliere, almeno ad allentare le catene che ci costringono nel quotidiano a usare la lingua in modo sclerotizzato, a ripetere le parole senza mai chiederci che cosa c’è o potrebbe esserci dentro o accanto, e alla fine ci permette di sorprenderci di quanto le parole, se lasciate brillare, siano imprevedibili e potenti cariche esplosive.
Anche i poeti spesso lo fanno in modo implicito e velato. Tutti siamo rimasti stupiti, credo, quando l’insegnante sui banchi di scuola ci ha fatto notare che anche Petrarca, il serio e integerrimo poeta laureato, giocava con le parole e nascondeva il nome dell’amata Laura in «Erano i capei d’oro a l’aura sparsi /che ’n mille dolci nodi l’avolgea». È il senhal, attestato come figura retorica nella solida tradizione dei trovatori che Petrarca riprende e con cui gioca, come hanno fatto tanti altri poeti prima e dopo di lui.
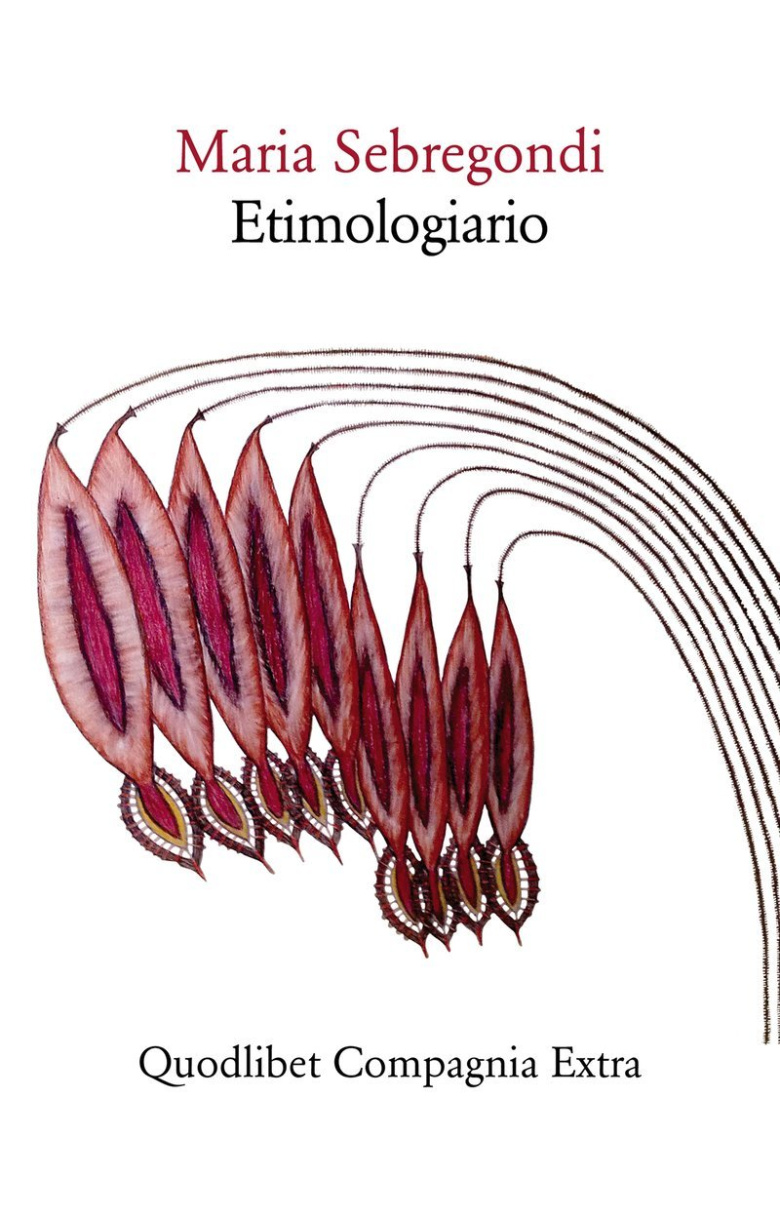
E i modi per giocare con le parole, alludendo ad altri significati oltre la prima apparenza condivisa, si moltiplicano nella tradizione letteraria fino ad arrivare a costruzioni davvero inaspettate e cervellotiche come negli isopsefi. Ne parla Paolo Cherchi in un curioso capitolo del suo recente Le ‘meraviglie’ di Eco (Milella, Lecce 2024). Isopsefo, etimologicamente, significa uguaglianza di calcolo. Secondo una tradizione consolidata sia nell’antico mondo greco, sia in quello ebraico e poi latino, ad ogni lettera corrisponde un valore numerico codificato. Così, nell’alfabeto latino, alla lettera A corrisponde il valore 1, alla B 2, alla C 3, e via di seguito, con varianti inattese rispetto alla mera successione (la lettera L, ad esempio, vale 20, la M 30 ecc.). Definita la tabella di corrispondenze, un isopsefo, scrive Cherchi, «considera equivalenti due nomi la cui somma del valore delle loro lettere dia totali uguali. Così, ad esempio, il nome Paolo e la parola sapienza in ebraico hanno lo stesso valore numerico di 781, e gli esegeti scritturali potevano sfruttare questa uguaglianza per ricavarne interpretazioni allegoriche o anagogiche» (p. 202).
Sono modi obliqui e insoliti di leggere un testo, ma diventano necessari se i testi che leggiamo nascondono, intenzionalmente o meno, qualcosa che va al di là del primo significato superficiale, qualcosa che è spesso frutto di creatività, non irreggimentata, dell’autore o dell’autrice e della sua arguzia, intesa nel senso alto del termine, come l’agudeza verbal del gesuita del Siglo de oro Baldasar Gracián o il Wit delle poetiche metafisiche del barocco inglese. Per loro il linguaggio ingegnoso non è un semplice artificio o un gioco fine a sé stesso, ma un modo per esaltare la misteriosa e nascosta relazione fra le cose e a rappresentarle nel loro più intimo essere in quanto relazione.
Un modo per leggere libri misteriosi e arguti come Finnegans Wake di Joyce può essere proprio quello di accettare le regole del gioco che l’autore irlandese aveva assunto, e cercare di cogliere rimandi esoterici o significati nascosti in termini anche apparentemente semplici e quotidiani. È quello che fa Enrico Terrinoni quando nel suo ultimo libro, La letteratura come materia oscura (Treccani, 2024), parla del libro di Joyce come il libro dei nomi che si trasformano. Questi, in modo simile alle immagini riflesse negli specchi deformanti del luna park, si prestano, anzi sollecitano una loro «sottile decostruzione». Così Patrick non è per Joyce soltanto Patrizio, cioè il nome del santo protettore dell’Irlanda, ma diventa, con una piccola scomposizione, Pa+trick, cioè “il trucco del padre”, permettendo così indirettamente a Joyce, di criticare la Trinità e di «dare ragione, tra l’altro, allo sfortunato eresiarca Ario che cita, sulla scorta di Bruno il Nolano, nelle prime pagine dell’Ulisse» (p. 30). E il filosofo Nolano stesso viene ribattezzato nel Finnegans «immensipater», che come pronuncia rimanda a “emancipator” (ovvero “emancipatore”, “affrancatore”) ma che porta anche in sé il significato di immensi pater, cioè padre o autore del De immenso (p. 36). E si potrebbe proseguire con altri succosi esempi, come con le ciliegie di cui si parlava prima a proposito delle etimologie fantastiche.
Ma il libro di Terrinoni non è tanto una raccolta di arguti giochi verbali presenti o presunti nel libro di Joyce, letti da uno dei massimi studiosi dell’autore irlandese. Mi pare che sia piuttosto l’approdo alla dichiarazione di un modo aperto e dinamico di fare critica letteraria e che chiama in causa il lettore con tutta la sua creatività ermeneutica. Un modo lontano dalle operazioni da Distant reader, basate sulla elaborazione dei Big Data, che mettono in secondo piano la lettura diretta dei testi, o anche dalle vivisezioni scientiste a cui ci hanno abituato certe derive del Close reading. È un modo che potremmo forse definire, per restare nel vezzo deprecabile degli anglismi imperanti, Words deep reading, un modo che lavora a fondo sui testi, smantellandoli, nel doppio senso di decostruirli, ma anche di togliergli il mantello, come scrive Terrinoni (p.132): «un rinnovato approccio misterico alla letteratura, e non uno riduzionista e deterministico» che possa ricondurre i testi «allo spazio ineludibile dell’esistenza, all’incorporeità della preziosa materia sognante di cui siamo fatti tutti quanti” (p.143).

Questo invito a guardare la letteratura e la critica letteraria da un punto di vista più dinamico è l’esito di una lunga e accorta riflessione sulla esperienza concreta, radicale, che Terrinoni ha fatto di traduttore di testi quasi impossibili o estremi e che ha avuto un momento, forse di felice e quasi paranoica intensità, nella decisione di portare a termine con Fabio Pedone la traduzione dell’opera joyciana intrapresa negli anni ottanta da Luigi Schenoni per l’editore Mondadori. Di Terrinoni e Pedone sono le versioni del libro III e del libro IV uscite nel 2017 e 2019 accompagnate da un accurato apparato di note e da ricche postfazioni dei due curatori. Nel tradurre un testo come Finnegans Wake è necessario qualcosa di più di quanto possa assicurare non solo un ottimo traduttore automatico di ultimissima generazione, ma anche un espertissimo traduttore editoriale. Il traduttore è chiamato a un’operazione ermeneutica e ricreativa difficilmente standardizzabile. Deve decostruire il testo e poi cercare di ricostruirlo con una buona dose di arbitrarietà e sensibilità, ma sempre accompagnate dal rigore deontologico dell’arte della traduzione. Si è continuamente chiamati ad affrontare situazioni linguistiche in cui il fraintendimento la fa da padrone e le incomprensioni sono dietro ad ogni angolo. D’altronde anche la stessa parola, per Terrinoni, sollecita una sua scomposizione, che può diventare un modo più profondo per comprenderla: «“Fra+intendimenti” – ad esempio nella frase “viviamo fra intendimenti” – suggerisce che, comunicando, ci troviamo sempre in compagnia di diversi intendimenti, di diverse motivazioni, di diverse strategie intese ad ottenere un qualche obiettivo» (p. 30).
Se la questione dell’ambiguità, del fraintendimento e delle molteplici ipotetiche intenzioni del testo è centrale nell’atto del tradurre, lo è anche, e questo è il vero nucleo del libro di Terrinoni, nell’atto critico. La letteratura come materia oscura ci sembra dunque prima di tutto una riflessione sulla critica letteraria, su un modo di fare critica che, senza misconoscere l’importanza degli altri metodi presenti su quello che Remo Ceserani aveva chiamato «il supermercato della critica» letteraria, vuole richiamare l’attenzione sull’atto ermeneutico compiuto dal lettore. Un atto che è indispensabile perché il testo non sia letto come un corpo morto da vivisezionare, come in un’autopsia, né da studiare solamente per vedere come ha funzionato quando è stato concepito. È un atto che permette, di tenere in vita il testo, di dargli la possibilità di avere altre vite future. Scrive Terrinoni: «A differenza di un corpo, un testo non può davvero morire. Siamo noi, i lettori-medici, a fare la parte dello scienziato Dr. Frankenstein. Il testo è la creatura che abbiamo sempre modo di riportare in vita. Ma la sua nuova vita non sarà più quella di prima. Può essere interessante ricondurre il testo al suo funzionare in relazione a teste che non ci sono più, ovvero di cui, nei casi più fortunati, restano solo dei teschi ma che più spesso sono ridotti a grigia cenere. […]. Il nostro mestiere di lettori – e qui includo ovviamente anche i critici – non è quello di dare il colpo di grazia a un corpo testuale moribondo per poterlo impagliare e mostrare agli altri come trofeo. La lettura, anche quella specialistica, non è una forma testuale di tassidermia. I testi dobbiamo aiutarli a vivere e a circolare, a far sì, ovvero, che il sangue delle loro vene torni a irrorare gli organi affinché quel loro calore potenziale si espanda, fino a essere poi captato da chi gli consentirà di spandersi per il mondo» (p. 22).
Che sia il lettore a rimettere in circolo il testo e addirittura a crearlo è la nota tesi elaborata decenni fa quando Stanley Fish pubblicò il suo provocatorio Is there a Text in This Class? Lì si trova, fra gli altri aneddoti degni di un etimologiario patafisico, la storiella della interpretazione di una falsa poesia. Al termine della sua lezione universitaria di linguistica e teoria letteraria tenuta nell’estate del 1971 alla SUNY di Buffalo, Fish scrisse alla lavagna i nomi degli autori di saggi che gli studenti avrebbero dovuto leggere come compito. I nomi risultarono scritti in questo modo:
Jacobs-Rosenbaum
Levin
Thorne
Hayes
Ohman (?)

Sono nomi di linguisti noti; l’ultimo è scritto con un punto interrogativo perché Fish non riusciva a ricordare se dovesse essere scritto con una o due n. Prima dell’ingresso dei nuovi studenti in aula, che seguivano un corso sulla poesia religiosa inglese del XVII secolo, il professore tracciò una riga che incorniciava l’elenco, a formare una sorta di croce a Tau o di Sant’Antonio Abate, e disse agli studenti che si trattava di una poesia religiosa del genere che stavano studiando. Seguono nel libro di Fish tre pagine esilaranti in cui sono descritte le varie interpretazioni suggerite dagli argutissimi studenti che alla fine riuscirono a creare con quei nomi un testo “poetico” altamente simbolico. Una prima considerazione di Fish, e certo tuttavia non la conclusiva del suo libro, è la seguente: «L’interpretazione non è l’arte di analizzare i significati bensì l’arte di costruirli. Gli interpreti non decodificano le poesie: le fanno» (C’è un libro in questa classe?, Einaudi, 1987, p. 167).
Se Terrinoni si limitasse a dire questo non farebbe altro che inserirsi in un filone della critica post-strutturalista già piuttosto consolidata. Quello che risulta originale nell’approccio di Terrinoni è l’accostamento del suo modo di leggere i testi alle acquisizioni della cosmologia e della fisica quantistica come strategia di comprensione del mondo. Non a caso il primo capitolo del libro si intitola Interpretazione simil quantistica del letterario. «La meccanica quantistica – scrive Terrinoni – presuppone il principio di indeterminazione, secondo cui la posizione e la quantità di moto di una particella, come ad esempio un elettrone, non possono essere contemporaneamente ben definite nella stessa misurazione. […] In una simile indeterminatezza di fondo si sono predisposte tabelle che incrociano tutti i possibili risultati, e in questo modo ogni predizione diviene di tipo probabilistico e non più deterministico. Qualcosa di simile avviene anche nell’interpretazione letteraria» (pp. 61-62). Sostituire la fisica tradizionale con la fisica quantistica, porta Terrinoni a parlare di onde interpretative, di dinamiche miscroscopiche, di entanglement, di simultaneità, di relazionalità costitutiva e ad accettare che, così come nel mondo, l’incertezza è «insita in ogni prodotto artistico, che più ci avviciniamo, più si allontana. L’apparenza di averlo “compreso” è un’illusone di breve respiro. Come sanno i critici davvero “critici”» (p. 65).
Se il libro indica nuovi possibili orizzonti di riflessione per il rapporto scienza e arte, ma anche un modo militante per vedere la critica letteraria proiettata nel futuro, è di sicuro anche un’interessante e godibilissima lettura di uno stile che parla di arguzia esegetica offrendosi esso stesso come scrittura arguta, barocca nel senso di creativamente sorprendente, dettata da un originale e brillante wit, nella doppia accezione secentesca di saggezza e follia. Eccone un assaggio: «Quanto è sottile il rumore della prosa che conduce qui le danze? Quanto è ineffabile il parlare, quando dobbiamo esitare ad esistere prima di produrre una sentenza? “Esistare” è forse il nuovo verbo per definire la nostra condizione senziente. E forse dovremmo anche aggiungere che vivere è una forma di “esitenza”, che ci impone di attendere alle azioni altrui, e non attenderle. Tendere gli orecchi alle tesi degli altri, tesi nello sforzo di captarne risultati sempre inesorabilmente non attesi. Ossia non a tesi” (p. 15).









