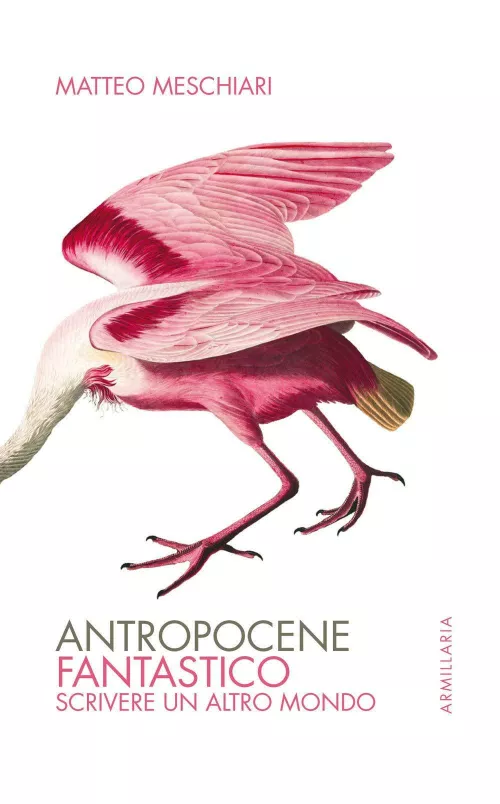Antropocene fantastico / Scrivere un altro mondo
Come la psicoanalisi si prefigge di ricostruire la situazione traumatica originaria al fine di provocare la liberazione del materiale rimosso, così ora noi stiamo precipitando nel nostro passato archeopsichico, riscoprendo gli antichi tabù e gli istinti primordiali rimasti sopiti per migliaia di anni. Il pensiero della brevità della singola vita umana è fuorviante. Ognuno di noi ha la stessa età dell’intero regno biologico e il nostro flusso sanguigno è immissario dell’immenso oceano della sua memoria collettiva.
Questa citazione è tratta da Il mondo sommerso, il romanzo del 1962 in cui J.G. Ballard immagina la più famosa delle sue quattro apocalissi, quella della morte per acqua (le altre tre avvengono per siccità, vento e – la mia preferita – cristallizzazione). Collasso del mondo esterno sul mondo interiore, luogo del trauma e sua esternalizzazione per mezzo della creazione artistica sono le coordinate della poetica ballardiana almeno fino alla grande frattura composta dalla Mostra delle atrocità, il punto dove il Ballard surrealista comincia a lasciare il posto al Ballard profeta del presente.
La citazione potrebbe tuttavia parlare del mondo durante la pandemia di Covid-19: anche noi, di fronte alla minaccia ancestrale del contagio, «stiamo precipitando nel nostro passato archeopsichico»; mentre la civiltà, prostrata da eventi climatici inauditi e da quelle che sembrano le prime avvisaglie di una guerra civile mondiale permanente, minaccia di lasciar posto alla barbarie, anche noi stiamo «riscoprendo gli antichi tabù e gli istinti primordiali rimasti sopiti per migliaia di anni»; c’è un’aura ballardiana innegabile nelle immagini filmate dai droni delle città deserte, nei sogni pandemici con cui stiamo elaborando il trauma collettivo, nei ricchi del mondo che si chiudono in gated comminities di lusso per prepararsi all’arrivo dell’apocalisse.
Ciò che ha reso Ballard uno scrittore tanto adatto a raccontare il presente è una sorta di cortocircuito spaziotemporale: da un lato sprofondando nel proprio spazio interiore, nel luogo del trauma individuale, Ballard entrava in contatto con l’inconscio collettivo dell’Occidente; dall’altro, regredendo fino al «passato archeopsichico», acquisiva la capacità di vedere il futuro che ci attendeva alla fine della strada. Per questo le sue apocalissi sono insieme senza tempo e contemporanee, psichiche e archetipiche.
Ballard non compare mai nel canone letterario («personale, arbitrario») del collasso psico-ecologico proposto da Matteo Meschiari in Antropocene fantastico (Armillaria, 2020), ma i temi affrontati da questo pamphlet scritto durante il picco della pandemia sono eminentemente ballardiani: la discesa nel tempo profondo, il ruolo giocato dal mondo onirico nella ridefinizione del reale, la parola letteraria come strumento capace di creare mondi, l’esplorazione della mostruosità, il paesaggio come luogo del trauma collettivo. Ci sono scene eminentemente ballardiane, come quella in cui Meschiari (o meglio “Meschiari”, come “Ballard” si chiamava il protagonista di Crash) osserva il panorama solo apparentemente quotidiano dell’Appennino emiliano per vederci il luogo di una futura, ma imminente, catastrofe:
Dopo aver guardato laggiù, nelle pianure, il mio Appennino è un’altra cosa. Gli essiccatoi per le castagne sono piccoli bunker dove immagazzinare provviste. I laghi sono riserve idriche contro le prossime epoche di siccità. I sentieri in fondovalle sono luoghi per tendere imboscate. Il Crinale è una linea di rudimentali pale eoliche e di reti per la raccolta di vapore acqueo da nuvole e nebbia. Non ci sono più le vecchie matriarche a cuocere crescentine tra tigelle e foglie di castagno, ma bambine magre a mescolare gamelle di zuppa liofilizzata. Non c’è più il cacciatore di cinghiali dal naso rubizzo, ma il filo di ferro del bracconiere, del trapper che torna a casa a mani vuote. E non ci sono più le passeggiate della domenica, ma la guerriglia ultima, tra sopravvissuti che portano il fuoco e bande di predatori affamati.
Vedere la «guerriglia ultima», le «bambine magre a mescolare gamelle di zuppa liofilizzata» al posto dei luoghi rassicuranti delle «passeggiate della domenica» è un’operazione simile a quella che Ballard compiva guardando Leicester Square e immaginandola come una giungla neo-preistorica, lo scenario di una catastrofe prossima ventura. È un’operazione delirante, naturalmente, nel caso di Meschiari informata da blockbuster catastrofisti e da saghe fantasy, ma non per questo (nonostante questo, grazie a questo, la distinzione è diventata sottile) meno importante: non c’è peggior delirio che voler trattare come normale una realtà delirante, ricondurre l’inaudito della crisi ecologica alla banalità del tardocapitalismo.
Sarebbe fare come Claire, la sorella borghese di Justine che in Melancholia guarda la fine del mondo con un calice di buon vino in mano, senza comprendere la catastrofe, senza lasciarsene trasformare. Si muore due volte: nel corpo e nel significato.
Letteratura del dopo
Come un altro libro di cui ho parlato qui su Doppiozero, Fenomenologia della fine di «Bifo» Berardi (Nero, 2020), Antropocene fantastico fa parte dei tentativi (incredibilmente rari, considerato che il virus colonizza il nostro inconscio da mesi e lo farà ancora per anni) di situarsi sul versante del dopo, fornire le categorie concettuali per comprendere il mondo che verrà. Anche questo significa guardare l’Appennino emiliano e vederlo come il luogo di una distopia: osservare il presente con gli occhi del futuro, o almeno di uno dei futuri possibili. «Bifo» lo fa da quarant’anni e ora il futuro l’ha raggiunto. Negli ultimi tempi Meschiari, che tra il 2016 e il 2020 ha firmato ben quindici libri, tre solo nel 2020, è diventato una delle voci più attive in quest’opera di ridefinizione, muovendosi in uno spazio che si situa tra la geografia, l’antropologia e la narrativa e dunque, se vogliamo, nel settore nascente della theory-fiction italiana.
In questi primi mesi di letteratura post-pandemica abbiamo visto due reazioni opposte agli eventi che hanno cambiato forse per sempre il mondo: da un lato il tentativo di assorbire lo shock, elaborandolo, e dall’altro quello di enfatizzarne il carattere inaudito, facendo della pandemia la soglia d’ingresso in un mondo completamente nuovo. I sostenitori di questa seconda scuola hanno insistito molto sul carattere “profondo” del cambiamento in atto: per sopravvivere non basta riadattare le forme stanche della nostra cultura crepuscolare, è necessario un completo ribaltamento di paradigma. Inutile forse dire che questa è la parte che sento più vicina al mio sentire.
Da questo punto di vista, ciò che rende Antropocene fantastico particolarmente interessate è il suo tentativo di riflettere su uno degli aspetti più profondi possibili, quello del racconto: il problema è quello di «scrivere un altro mondo», come dice il sottotitolo del pamphlet. Leggendolo mi è tornato in mente il Manganelli del Discorso dell’ombra e dello stemma che immagina un passato in cui non c’era letteratura. Prima della letteratura, dice Manganelli, non esistevano fiori o farfalle, perché non c’erano poeti a cantarli. Oggi siamo in una situazione simile: il mondo di domani non esiste, perché non abbiamo le parole per scriverlo.
Devo citare di nuovo «Bifo» il quale nella sua Fenomenologia sostiene, riguardo alla necessità di provare a immaginare il dopo, che «chi immagina per primo vince», e aggiunge «questa è la legge universale della Storia». Può darsi che sia la legge universale della Storia; certamente è una necessità in un’epoca che ha perso le categorie per pensarsi in un turbine di eventi incontrollabili e ancora non ne ha inventate di nuove, con il risultato che continuiamo a raccontarci storie che non hanno più niente a che vedere con la realtà. Fedeli a un’idea ormai insostenibile di ciò che è “vero” e “reale”, ci troviamo imprigionati in un racconto che non rispecchia più niente e nessuno mentre il mondo che dovremmo raccontare continua a esistere, selvaggio e incompreso.
Ho esagerato per fini drammatici, ma volevo rendere l’idea del genere di sfida che ci troviamo davanti. Poiché siamo le storie che raccontiamo, la forma e il contenuto dei nostri racconti individuali e collettivi è ciò che plasma il presente. Se raccontiamo una storia i cui personaggi sono tutti maschi bianchi siamo preda a un’allucinazione, stiamo parlando di un mondo di cui sopravvive solo il cadavere spettrale. Se raccontiamo una storia i cui personaggi sono solo esseri umani stiamo già abdicando alla comprensione di un presente che è estremamente più complesso dello svilente diorama in cui la cosiddetta natura è un «fondale» e il cosiddetto essere umano è un «proscenio» (l’esempio è di Timothy Morton). Saremmo – siamo – ciechi: incapaci di vedere, come racconta Amitav Ghosh all’inizio di La grande cecità, forse il libro che ha iniziato questo dibattito nel mainstream editoriale, che la liana messa nel nostro romanzo per fini decorativi è in realtà un serpente.
Saremmo anche morti, perché il serpente morde ed è velenoso, e ce lo saremmo meritato.
Romanzo collettivo
Antropocene fantastico intende porsi come una guida alla scrittura del futuro, una cassetta degli attrezzi per attraversare la Terra di Mezzo dello storytelling nell’epoca problematica, “troubled” come direbbe Donna Haraway, nella quale siamo entrati («Lo scrittore nell’Antropocene deve costruirsi un kit di sopravvivenza leggero, uno zaino pieno di piccole cose utili, da usare quando serve, da rileggere nel bisogno»). È una cassetta degli attrezzi personale fino all’idiosincrasia, che spazia da Jeff VanderMeer al Beowulf e da Paul Shepard a Tolkien. Non la cassetta degli attrezzi che metterei insieme io, ad esempio, se non marginalmente, ma il punto è proprio questo.
Meschiari, anzi “Meschiari”, rischia di presentarsi come un profeta. È il rischio di tutti coloro che al centro della loro letteratura mettono la retorica dello shock del futuro: i McLuhan, i Pierre Lévy, i «Bifo»: viandanti carismatici e visionari che attraversano le ceneri di questo pianeta. Non bisogna cadere nella tentazione di personalizzare il discorso, perché ciò che Meschiari ci mostra in Antropocene fantastico è in realtà un metodo, più che una visione personale. Ciò che deve cambiare, ci dice, è il modo in cui pensiamo alle storie, e deve essere un cambiamento radicale. Anche per questo alcuni dei momenti più riusciti del pamphlet argomentano con forza la necessità di muoversi verso una forma collettiva di autorialità lontana dalle «microtradizioni editoriali» che dominano ancora, anacronisticamente, il presente:
L’idea-chiave che sembra emergere è il ‘romanzo diffuso’, un evento narrativo immerso nell’immaginario collettivo, aperto a esperienze multiple di genere, stile e medium, che si dà nella pluralità autoriale e vive in situazioni aperte, che esiste in modalità crowdsourcing e mash-up.
[…]
Bisogna diffidare di chiunque sostenga che scrivere sia un affare per soli scrittori. Scrivere è come accarezzare un siamese, non devi leggerti Il comportamento dei gatti di Paul Leyhausen per farlo, e se qualcuno sostiene il contrario è solo perché vuole venderti il libro. L’idea di letteratura/scrittura che diamo per scontata in questo Tardo Occidente ha poco più di un secolo di vita. Confonderla con ciò che per 50.000 anni è stato inventare storie e fare poesia è come scambiare la fotografia di un cane con la sensazione che si ha quando si scorrono le dita sulle sue costole.
[…]
Per garantire a tutti il diritto di inventare storie, di associare parole in modo inedito e imprevisto, di essere scrittori del proprio qui e adesso, è indispensabile tornare a riflettere su animali, mostri, paesaggi e popoli. Il loro potere narratologico, il loro essere storie in potenza alla portata di chiunque, anche di un narratore improvvisato e ingenuo, è indispensabile per scrivere collettivamente un altro mondo.
Come si può vedere siamo di fronte al tentativo di una ridefinizione ampia e stratificata dell’uso che facciamo della narrazione. È una proposta profondamente spaesante: cosa vuol dire realmente includere il paesaggio come personaggio letterario? Come si fa a mostrare il mondo dagli occhi dei non-umani se non addirittura dei non-viventi (le rocce e il silicio, o la “demonologia inorganica” di un grande autore di theory-fiction come Reza Negarestani)? Che forma ha oggi un testo capace di raccontare l’epica di un popolo? Come possiamo integrare davvero la potenza archetipica, sovra-individuale della vita onirica nella nostra fiction? Quali sono i «romanzi con un’idea di tempo che sostituisca al trimestre economico i millenni, romanzi con un’idea di spazio che sostituisca al tinello e al paese della Bassa le zolle continentali e il vuoto interplanetario»?
Abbiamo alcuni esempi: il post-esotico di Volodin, il massimalismo della fantascienza di Cixin Liu, la «cosmogonia di mostri» dell’ultimo VanderMeer. Se questa non è l’unica strada possibile per il futuro della letteratura certo è una via possibile, un percorso che merita di essere esplorato perché le domande che solleva sono oggi imprescindibili per chiunque scriva in ogni forma.

Autofiction dell’Antropocene
È interessante notare che questo «romanzo diffuso» dell’Antropocene Meschiari non si è limitato a ipotizzarlo nel suo pamphlet, ma ha provato a realizzarlo attraverso il sito La grande estinzione da lui curato insieme ad Antonio Vena: alla fine di ottobre uscirà per Aguaplano TINA, il risultato di quel progetto, un testo ibrido di 492 pagine che spazia attraverso migliaia di anni di storia umana, diversi continenti e altrettante forme (è un romanzo? Un saggio? Contiene delle illustrazioni, dunque è un libro illustrato? È un poema? Un diario?). TINA è diviso in sette giornate, come la Genesi; l’epigrafe è tratta dal Decameron, la pietra angolare della letteratura pandemica italiana; nella forma ricorda soprattutto i testi di Nick Land e della CCRU, o il Vollman più anarchico.
Dunque cos’è TINA? Secondo l’introduzione «una storia di demoni e spettri», ma poi, una riga dopo, «un’autofiction dell’Antropocene». Sfogliandolo mentre tracimo dal compito datomi dalla rivista di scrivere la recensione che state leggendo ad Antropocene fantastico, che non è più una recensione a un solo libro ma a una rete di libri (mi sono fatto influenzare da “Meschiari”, evidentemente), mentre ne sfoglio le pagine che sto leggendo in anteprima ci trovo dentro una disquisizione sulle colpe di Edipo, la frase «la sindrome neurologica di Minamata, in Giappone, fu causata dal rilascio tra il 1932 e il 1968 di metilmercurio da parte dell’industria chimica Chisso Corporation», il racconto narrativo di una guaritrice che esorcizza il virus dell’Ebola in Sierra Leone, un’illustrazione di Montezuma, una lettera ad Anna tratta «dalle lettere di Edvard Jorvis» (Edvard Jorvis è esistito davvero? Sì, scopro su Wikipedia, dove però è scritto con la “w”, Edward Jorvis; la lettera ad Anna è reale o è fiction? La lettera sbagliata è un refuso o una scelta? Non ne ho idea) e una serie di poesie dedicate alla caccia.
Poi mi fermo e sono a pagina 103, praticamente a un quinto del libro, ho saltato a caso e vampirizzato citazioni; mi fermo a pagina 103 perché anche se il redattore della rivista che state leggendo ha detto che va bene parlare anche di altri libri ho promesso una recensione ad Antropocene fantastico, va bene non essere troppo verticale sul libro ma devo tornare nei binari, volevo mostrare al lettore la potenza dell’autofiction e dunque –
TINA è evidentemente un mostro. Un mostro letterario, un libro in forma di mostro, ogni storia che racconta un dente con cui ti divora, ogni salto avanti e indietro nei millenni una cavità o una protuberanza del suo corpo-tunnel, un tentacolo viscido con cui ti afferra e non ti lascia andare. Non leggerò mai TINA dall’inizio alla fine come non ho mai letto L’esegesi di Dick dall’inizio alla fine, o gli scritti di Land, o Cyclonopedia, o il Ciclo dei sette sogni di Vollman, o i Passages di Benjamin o l’I Ching, tutti libri a cui però continuo a tornare.
Non voglio implicare che TINA sia abbia lo stesso valore letterario di quei libri (magari ce l’ha, non l’ho letto, in fondo) ma è libro che appartiene a quella categoria, quella del libro-mostro. Anche questo, scrivere di mostri, scrivere libri-mostri, è un passo verso la letteratura del domani.
Scrivere di mostri
La mostruosità, il ruolo giocato dal mostro, è uno dei temi che attraversano Antropocene fantastico, forse uno dei temi fondamentali (insieme all’imprescindibile, almeno per me, capitolo sui sogni, sul nostro “Onirocene”). L’importanza del ruolo giocato dai mostri nella nostra epoca è già stata sottolineata da Donna Haraway, che in Cthuluchene ha messo in chiaro che viviamo in una Terra popolata di potenze ancestrali e non per forza amichevoli. Ma in che senso scrivere di mostri significa posizionarsi dalla parte del dopo?
Ancora nel 2001 un grande studioso di fantascienza come Antonio Caronia poteva scrivere che «a poco a poco, il mostro è destinato a scomparire dal nostro orizzonte cognitivo, affettivo, immaginario», le sue asperità, la sua ribellione, assorbita dalle dinamiche del fisheriano realismo capitalista. Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere, con Meschiari, che «il mostro […] non è un personaggio o una funzione narrativa, ma è l’agglutinazione dell’evento tragico in tutta la sua carica di non-senso», cioè che l’emersione del mostro sulla scena narrativa è la via d’uscita dalle secche del tardo capitalismo, che attraverso il mostro si entra nel territorio dell’incommensurabile e dell’inumano che spazza via la “normalità” di quest’epoca agonizzante.
Caronia (il cui saggio, intitolato non per caso «L’impotenza del mostro», si può leggere nella raccolta Dal Cyborg al Postumano pubblicata lo scorso mese da Meltemi) parlava dei mostri della modernità in questi termini:
Mostri dolenti, mutanti pseudo-umani in cui l’uomo “normale” si specchia per ritrarsene inorridito, ma che gli segnalano l’esistenza terribile dell’Altro. Anche questo mostro, però, si specchia in noi, e solo così può scoprire una verità di se stesso. […] E perciò può riequilibrare la situazione solo con un gesto di ribellione, che realizzi una copia malsana e blasfema di quella società da cui è escluso.
Cos’è cambiato negli ultimi vent’anni? È cambiato essenzialmente il fatto che il punto di vista non è più il nostro, o quantomeno non solo il nostro: l’idea che il mostro volesse essere accolto dalla società umana era anch’essa una finzione antropocentrica. Non c’è specchio che rifletta i valori umani nelle cose inanimate, semmai stiamo riconoscendo l’inanimato dentro di noi, l’arcaico dentro di noi, e dunque il mostro non è più una metafora di ciò che nell’umano rimane nascosto e invisibile ma al contrario è ciò che ci precede e nel corpo del quale viviamo simbioticamente. Il mostro è, esiste, indipendentemente da noi. «Gli dei vanno e vengono», scrive Meschiari citando Tolkien, «ma i mostri rimangono». È questo situarsi dalla parte dell’inumano, dell’archetipico che fa dire a Meschiari che «se scrivete di mostri […] siete già nella Resistenza».
Divenire invertebrati
Ho citato il libro di «Bifo», Donna Haraway, il libro di Meschiari e TINA come esempi di una riflessione sulla letteratura del dopo. Si tratta di libri diversi tra di loro ma accomunati da due fattori: il tentativo di elaborare categorie nuove per comprendere il presente e un utilizzo fluido dei generi letterari, che tracimano continuamente gli uni negli altri (siamo ben oltre il territorio dell’autofiction, siamo al collasso totale di ogni genere su tutti gli altri, dell’arcaico sul futuristico, del teorico sul popolare).
Un altro libro recente che merita un posto in questa disamina della scrittura futura è, a sua volta, un libro di mostri: Divenire invertebrato (Ombre Corte, 2020), un’antologia sul tema dell’«antispecismo viscido» curata da Massimo Filippi ed Enrico Monacelli. Anche questa raccolta di saggi (saggi?) fa dell’ibridazione dei generi un’idea cardine, perché – ormai dovremmo averlo capito – la necessità di sfuggire dalle gabbie editoriali tradizionali è uno dei presupposti perché possa esistere una scrittura del dopo. Filippi e Monacelli lo chiariscono bene nella loro introduzione:
Tutti i testi con cui abbiamo provato a disegnare una prima traccia del “reale/simbolico/immaginario” dell’antispecismo viscido sono strutturalmente ibridi. Piuttosto che scegliere se presentarsi nella forma vertebrata di un saggio scientifico, un racconto pop, un elzeviro erudito o una fiction, questi testi hanno scelto di disertare le categorie dei canoni tradizionali (papà, mamma e bambino) e di essere, e di non essere, un po’ tutte queste cose insieme, degli invertebrati insomma, con tutta la loro proverbiale flessibilità metamorfica e tra(n)sformativa.
Il perché non si possa (più) limitare la letteratura alle rigide categorizzazioni degli esseri dotati di uno scheletro lo spiega molto bene uno degli ultimi saggi della raccolta, «Come scopare con un* kraken» di Dagmar Van Engen, dedicato a «sessualità cefalopode e generi nonbinari negli ebook erotici». Se il tema vi sembra interessante solo per una nicchia dei queer studies dovrete ricredervi quando Van Engen ci mette di fronte al fatto che, nella storia dell’«erotica mostruosa»,
mentre i mostri basati sui vertebrati, e specialmente sui mammiferi, favoriscono narrazioni di fantasie razzializzate di stampo eterosessuale circa mascolinità dominanti e bestiali e femminilità fragili e bianche, le creature che alludono agli invertebrati dischiudono un regno totalmente altro di relazioni carnali fra corpi animali, fantasie e desideri.
Se la letteratura è, come credo, una delle forme che diamo al desiderio, come possiamo pensare di scrivere il mondo che verrà utilizzando generi (sia nel senso di genre che in quello di gender) modellati da una società patriarcale, antropocentrica, etnocentrica, elitaria? Come possiamo ostinarci a difendere divisioni arbitrarie tra saggi e romanzi, teoria e fiction, reale e immaginario, paesaggio e mondo interiore, quando in quest’epoca strana tutto ci parla di ibridazione, discese vertiginose nell’inorganico, collisioni di micro e macrocosmi? Come possiamo anche solo pensare che sia una posizione sostenibile se tutto oggi è soglia, trasformazione, oscena prossimità, simbiosi, mischia?
Comporre la biblioteca del domani
Questo articolo ha già superato le 20.000 battute, quindi è fuoriuscito dalla griglia tradizionale di ciò che chiamiamo “articolo” ed è diventato un “longform”, forse addirittura un “saggio”: qualsiasi cosa sia a questo punto possiamo immaginare di avere pochi lettori. È un articolo (saggio, saggio con innesti di autofiction, dunque in fondo fiction) non particolarmente ordinato nonostante i titoli dei paragrafi: volevo portare il lettore in un tour di una letteratura altra, instillandogli la curiosità di leggere alcuni dei libri di cui ho parlato.
Questi libri sono il primo, forse imperfetto, tentativo di fornire una risposta al problema centrale della scrittura, il primo imperfetto tentativo di immaginare una biblioteca di domani. Ce ne sono altri che meriterebbero di essere inclusi e, guarda caso, sono sempre libri di mostri: Le promesse dei mostri di Donna Haraway (DeriveApprodi, 2019), forse anche Leggere la terra e il cielo (Laterza, 2020) di Francesco Guglieri, che prima della pandemia utilizzava il genere letterario della divulgazione scientifica per parlare della meraviglia e dello stupore che ci impone quest’epoca di fenomeni inauditi (e i buchi neri, i virus, i fossili di esseri impossibili che compaiono nel suo libro, che altro sono se non mostri dell’oggi?). Nel suo saggio pubblicato in Divenire invertebrati, intitolato appunto «Tesi sui mostri», China Miéville scrive che «i mostri non sono patologie, ma sintomi, diagnosi, meraviglie, giochi e terrori». Ogni epoca ha i suoi e deve trovare le lingue e le forme adatte per raccontarli.
Il punto però non è quello di stilare un canone: quello arriverà, forse, con il passare del tempo, e se non arriva va bene lo stesso perché come dimostra Antropocene fantastico ognuno può metterci quel che vuole nel suo «kit di sopravvivenza» purché gli permetta di guardare il futuro e non lo tenga con lo sguardo rivolto al passato. L’importante è possedere questo kit, perché quello che stiamo attraversando è un trauma di proporzioni inaudite e abbiamo bisogno (anche) di libri che ci aiutino a dare un senso alla ferita, a trasformarci.
Sarà che ho guardato il mondo sprofondare nella pandemia da un sobborgo londinese, anche se non ricco o periferico come la Shepperton in cui J.G. si faceva ritrarre davanti alle sue riproduzioni di Delvaux, ma nel mio kit il Ballard della tetralogia troverebbe sempre posto. Anche perché pochi come lui sapevano, già cinquant’anni fa, che siamo ancora le nostre menti arcaiche, che nelle nostre ossa si ricapitola la storia della vita sulla Terra. Siamo la memoria impersonale (trans-personale, ultra-personale) del mondo, come spiega bene Claudio Kulesko nel saggio forse più profondo di Divenire invertebrati: siamo «come animali che continuano a condurre una vita notturna, sebbene il predatore che costrinse i loro antenati a rifuggire la luce del giorno si sia estinto da migliaia di anni».
Il nostro corpo non finisce nei confini tracciati dalla nostra pelle, viviamo su scale temporali immani; siamo sempre anche altro, mai riducibili alla nostra presenza immediatamente percepibile, sempre a contatto con la nostra mostruosità. Come nel romanzo di Ballard, il mondo sommerso (quest’istantanea del futuro delle nostre città, quasi nemmeno fiction, praticamente cronaca del domani) è ormai tutto intorno a noi; inceppando la macchina maniacale del capitalismo, la pandemia ci ha sottratti dagli imperativi del qui e ora per sprofondarci nel tempo profondo della memoria collettiva. E questa memoria transpersonale, non necessariamente umana del futuro richiede parole nuove per essere descritta.
Kerans, il protagonista del Mondo sommerso, cede al richiamo della catastrofe, come tutti i personaggi della tetralogia. Dobbiamo fare come lui: cedere al richiamo della catastrofe. Dobbiamo diventare deliranti, vedere il mondo che non c’è ancora ma ci sarà, il mondo possibile, il mondo impossibile, dobbiamo vedere il collasso del paesaggio, allucinare inferni e farli esistere attraverso la poesia. Dobbiamo creare, o ricreare, fiori e farfalle. È un’impresa immane, dovremmo sentirci fortunati nel sapere che la sfida tocca a noi.