Ransmayr: il confine invisibile
La professione di letterato comporta un discreto numero di prestazioni accessorie. Chi scrive romanzi sa bene che gli verrà chiesto di prodursi in pezzi d’occasione, stesi (e spesso declamati) per una commemorazione, un’inaugurazione, una Festschrift, il conferimento di un premio. Sa anche di doversi prestare, se non altro per una questione di rispetti umani; e vi si piega più o meno di buon grado. Lo scrittore austriaco Christoph Ransmayr sembra invece intraprendere con entusiasmo schietto quelle che molti considererebbero inevitabili corvée. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia (L’inchino del gigante, trad. Marco Federici Solari, L’Orma) è la somma di ben cinque volumetti perlopiù composti di questo genere di scritti occasionali. Non si tratta però di un volume esso stesso occasionale. Ha una sua fondatissima ragion d’essere. Mette in risalto quella che è indubbiamente una forma profonda della scrittura di Ransmayr: il discorso pubblico, l’orazione.
Forse la forma-discorso è particolarmente intonata alla cultura letteraria di lingua tedesca. Vengono subito in mente la Relazione davanti a un’accademia di Kafka, o i numerosi discorsi di Mann. Lo stesso Bernhard – il conterraneo a cui Ransmayr in queste pagine rifila alcune allusioni puntute – sia nella sua elaborazione del monologo sia in libri come I miei premi sembra ribadire questa centralità dell’allocuzione pubblica nell’atto stesso di prenderla a bersaglio. Ransmayr no, lui è entusiasta di potersi rivolgere a una platea. Costruisce discorsi con la padronanza architettonica, il controllo sulle risorse retoriche, e anche con una certa autoironica trombonaggine atta a rendere digeribile il pasto. (Tutti stilemi che ricordano, oltre ai già detti autori tedeschi, certe pagine di Hawthorne o Twain o Auster o Chabon: esiste un versante della cultura letteraria americana, e anche dei suoi affiliati nostrani, che è affascinato da questa modalità di scrittura.) Sembra trarre un giocoso, intenso godimento dall’uso di questa lingua solenne. Viene in mente un episodio della sua infanzia. Quando il padre si recava in quello stanzino appartato che (secondo Auden) gli arabi chiamano “la casa dove ognuno va”, il piccolo Christoph si appostava in ascolto. Tra qualche romorìo corporale, infatti, il padre borbottava tra sé e sé in una lingua sconosciuta. O almeno sconosciuta al figlio. Si trattava in realtà di frasi in russo. Ma il bambino non aveva dubbi: suo padre stava parlando “la lingua dei grandi”; e anche lui, crescendo, avrebbe spontaneamente, biologicamente iniziato a usarla.
Ecco, in questi interventi pubblici Ransmayr sembra volerci mostrare di essere approdato finalmente alla lingua dei grandi, per farla propria, piegarla ai suoi fini: se non infantili, perlomeno originari. Dà prova di una spontanea vocazione teatrale (ancora una traccia della tradizione tedesca?). Uno dei primi pezzi è dedicato a un imprevedibile spazio dedicato a Melpomene e alle sue sorelle: il palco di Glaisin Alainn. Proprio così, non un teatro, ma un semplice palcoscenico. Una nuda piattaforma collocata in un punto remoto e selvaggio del West Cork, a pochi passi dalle scogliere del mar d’Irlanda. Eppure un luogo che in passato si animava di un pubblico appassionato, tra canzoni d’amore, canti politici, valzer, monologhi, battute, rievocazioni dei tanti drammi (naufragi, battaglie, migrazioni) che il mare ha donato a quell’isola. Ransmayr, narratore di luoghi lontani nello spazio e nel tempo (Gli orrori dei ghiacci e delle tenebre, Il mondo estremo, La montagna volante, Atlante di un uomo irrequieto), è tanto più attento al fondale storico quanto più vi ambienta una narrazione trasfigurata. Ma gli basta un teatro senza sipario e senza dorature, anzi “privo di tetto” e senza “neppure un muro… Si sollevava appena dal terreno da pascolo che lo circondava, e un artista poteva salirci con facilità oltrepassando qualche ciuffo d’erba e di ginestrone”.
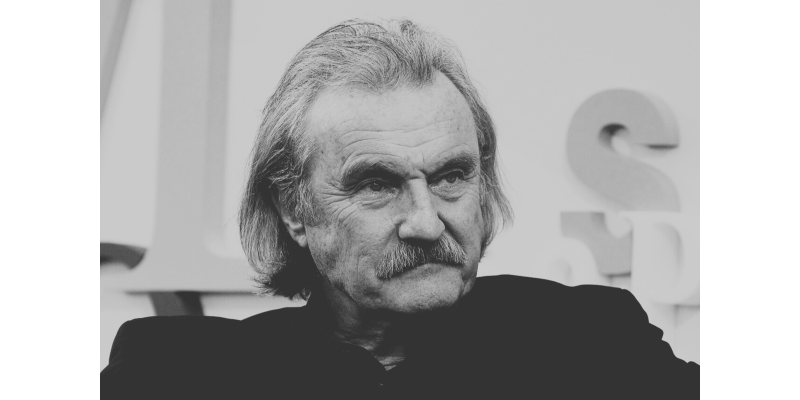
Glaisin Alainn incoraggia una teatralità spontanea; ma altrove Ransmayr si fa beffe della teatralità come rito collettivo esteriore, e dell’annessa funzione sociale della prolusione. Una delle pagine più riuscite, per l’efficacia del suo semplice effetto anacronistico, ci mostra il narratore come un uomo delle caverne, un ominide coperto di cicatrici che “da quando è caduto in un crepaccio tra i rovi inseguendo un’antilope e si è rotto entrambe le gambe in più punti… ha iniziato a raccontare”: in questo modo si rende ancora utile al clan, che “ha deciso di non bandirlo” e gli offre anzi… un’esecuzione del Quintetto per archi in do maggiore di Schubert, “una medaglia d’argento chiusa in un astuccio di velluto blu”, e soprattutto un assegno, che il premiato accetta “senza il minimo accenno a un inchino”: anche perché gli dolgono ancora le ossa.
Attenzione, Ransmayr non nega affatto la dimensione sociale e anche politica del suo scrivere. L’inchino del gigante contiene efficaci e dettagliate denunce dell’imperialismo coloniale e postcoloniale, e ritratti partecipi di intellettuali impegnati come Ernst Toller e Heinrich Böll. Ma come Böll, Ransmayr ha preferito trasferirsi per molti anni in Irlanda pur di non venire identificato come la coscienza morale del suo tempo e della sua nazione. Vuole essere (anche) un soggetto politico, ed esserlo (anche) in quanto scrittore, ma non vuole assolutamente esserlo per conto d’altri. Ciò che rifiuta è dunque il mandato sociale: e si può capirlo, giacché il mandato comporta la presenza di qualcuno che ti manda avanti per delega, restandosene comodamente inerte a casa propria. Lo scrittore austriaco ci ricorda che uno scrittore, anzi “il libero scrittore”, può anche essere un individuo “egoista, avido, immorale, ingiusto e spietato” – temo che non occorrano esempi. E arriva addirittura a sottolineare che se, hegelianamente, “il corso della Storia deve davvero essere un ‘progresso nella coscienza della libertà’”, un’opera di poesia può “rappresentare uno strumento adatto a illuminare, ma anche a oscurare tale coscienza”. Non so quanti sottoscriverebbero davvero questa posizione. Molti, forse, cercherebbero di salvare capra e cavoli sostenendo che anche l’opera d’arte dal passo più retrogrado e dalla luce più oscura ci permette comunque, per sua propria natura, di prendere la rincorsa per scattare in avanti, o tornare giù nella caverna per liberare gli schiavi. E può darsi che sia così. Ma certamente quella che Ransmayr propone è una formulazione coraggiosa in questi tempi di letteratura nobile, moraleggiante – poeticamente corretta. Il teatro in cui L’inchino del gigante ci invita è un puro templum, uno spazio sacro in cui la parola si attua liberamente.
Vedo che l’aggettivo “libero” e i suoi derivati si sono ripetuti spesso nelle ultime righe, cosa non sorprendente poiché si parla di un artista-viaggiatore che nei suoi romanzi spazia per l’orbe terracqueo. Eppure alcune delle cose più interessanti che Ransmayr ha da raccontare riguardano proprio l’idea di confine. Lo stesso palcoscenico di Glaisin Alainn, del resto, gode della sua straordinaria libertà solo grazie a quel minimo gradino che qualsiasi bardo di paese può ascendere con un passo – e che tuttavia va scalato, né più né meno di una montagna. Un altro e più toccante esempio di questi confini decisivi lo si incontra quando l’autore torna a parlarci del padre. In apparenza lo descrive come un personaggio impaziente di fronte a qualsiasi barriera. È l’uomo libero per antonomasia, sempre pronto a scartare rispetto alle aspettative conformiste del suo piccolo mondo provinciale. Da ragazzo rifiuta il sostegno delle autorità naziste; dopo il matrimonio si inventa una seconda vita in Crimea (senza abbandonare la sua famiglia nell’Alta Austria); poi addirittura, pur continuando a fare l’insegnante, si improvvisa direttore di banca. Ma la sua energia proteica si esplica pienamente solo nel momento in cui esige il rispetto di un limite: cioè quando (simile al Michael Kohlhaas di Kleist) conduce una lunghissima, logorante battaglia per riuscire a farsi cancellare una condanna per malversazione che pure non aveva alcun effetto concreto sulla sua vita. È lecito oltrepassare ogni linea, tranne quella della giustizia. Ed è questo limite che dà un senso al suo eventuale, drammatico superamento.
C’è, nella vita di questo padre (e dunque del figlio), un curioso antecedente di tale ferrea distinzione degli spazi. Nel villaggio di Roitham am Traunfall (duemila abitanti) Karl Richard Ransmayr era anche maestro di scuola del piccolo Christoph. Ogni mattina padre e figlio attraversavano mano nella mano il cortile del collegio, che separava l’alloggio dell’insegnante dalle aule scolastiche. A metà del tragitto, però, passavano quello che lo scrittore definisce – con un sussulto che possiamo solamente immaginare – un “confine invisibile”. Qui Christoph cessava di dare del tu al padre e passava al lei. Le mani, suppongo, si staccavano. Avrebbe continuato a chiamarlo signor maestro per il resto della mattinata, finché tornando verso casa non avessero traversato di nuovo quel mimetico Checkpoint Charlie.
Si tratta di un altro esempio del confine tra il personale e il sociale che Ransmayr tutela con il massimo rigore. Lo spazio irrinunciabile – quello che in un’altra pagina è designato come il “centro del mondo” di ogni scrittore – è, in fin dei conti, semplicemente lo spazio della creazione. Appare circondato da un caos di voci “interroganti, ammirate, tristi, entusiaste, sprovvedute o piene d’odio”. Tuttavia sono proprio queste le voci a cui lo scrittore si rivolge, quelle con cui deve avere a che fare. Tornare nel mondo, affrontarle e sentirle, gli è necessario; ma “mentre le altre voci si fanno più forti lui perde la propria”. Così deve ripartire e viaggiare e perdersi nella distanza. Finché, proprio in quell’estrema distanza, gli si apre come un vortice di polvere un’altra storia in cui entrare, un altro centro del mondo – del suo mondo, e più tardi – solamente più tardi – del nostro.









