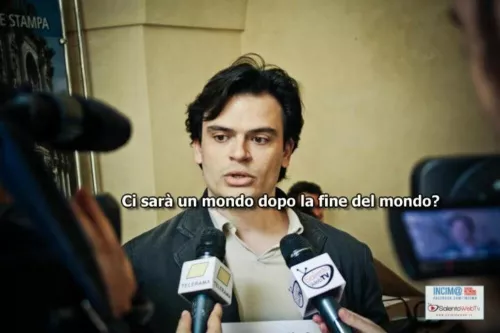Tommaso Ariemma. Il mondo dopo la fine del mondo
La fine del mondo è giunta. Questa affermazione, solo apparentemente paradossale o provocatoria, ha condensato e fatto gravitare attorno a sé le fondamentali riflessioni di sempre più numerosi pensatori, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Le questioni spalancate dalla presa in carico di un simile assunto sono a tal punto radicate che sarebbe probabilmente più chiaro e prezioso formularlo altrimenti: la fine del mondo era giunta. Dal preciso istante in cui si assume il mondo come finito, emerge prepotente l’interrogativo su cosa resti, su cosa sia del mondo dopo la fine, oltre la fine.
Da questo affaccio iniziale si profila il panorama tratteggiato da Tommaso Ariemma, un orizzonte che fa il suo esordio con la realizzazione che affermare la fine del mondo non significa e non può significare che esso sia cessato: cosa sia diventato Il mondo dopo la fine del mondo (Et al. edizioni, 2012, pp. 116, € 11,00), cioè dopo il “momento in cui si è raggiunta un’equivalenza tra mondo e informazioni sul mondo”, è questione di cui Ariemma ricerca le tracce in questo agile testo. E le dispone su due piani esplicitati già dal sottotitolo: l’arte contemporanea e Facebook.
Il primo scandaglio affonda in una magmatica e indefinibile distesa, un nome universalmente riconosciuto e, tuttavia, in grado di sollevare più interrogativi di quanti non ne sappia sciogliere. La denominazione di arte contemporanea è un contenitore che tuttavia non racchiude, semmai schiude innumerevoli sentieri, parzialmente illuminati, interrotti, avvolti e così interminabili. La sua condizione è, nell’immaginario collettivo, in qualche maniera compromessa con l’ubiquità e, di conseguenza, col non avere affatto una collocazione riconosciuta, ragione sufficiente a farla scivolare fino a ribattezzarla arte inesistente, “quell’arte che ha un grado talmente basso di esistenza, da farci sospettare che non si tratti di arte”.
L’arte inesistente, sottraendosi all’esistenza della definizione, stabilisce di non poter essere stabilita e si pone di fronte alla fine del mondo specchiandovisi e, pure, non riconoscendosi in essa: la fine del mondo non è, per essa, il ritratto del termine quanto, piuttosto, una moltiplicazione caleidoscopica, come se quello specchio che la osserva fosse stato mandato in frantumi dalla fine stessa. Occorre prestare attenzione a ogni singola immagine prodotta dal pur incalcolabile gioco così generato, altro non si può che dubitarne, esitarvi all’incontro e sostare nella penombra del quesito su “cosa percepiamo [...] nell’opera d’arte inesistente se non in primo luogo, una cosa sospetta, una cosa non ben identificata”.
L’arte inesistente in quanto maestra del sospetto, dunque, salvo che si rifiuta di farsi trovare anche laddove ne sia un indice, un insegnamento; il capovolgimento dei rapporti, che essa mette in scena, tra ciò che è arte e ciò che non lo è non si limita a una rivoluzione puntuale ma, piuttosto, non ha tempo cronologico, si alimenta del suo stesso capovolgersi. In questo reiterato spostamento, ciò che essa continua a differenziare è il punto di vista, il modo di guardare l’arte e le cose, mentre ciò cui sfugge e che disarticola è il linguaggio mediatico, la logica dell’informazione: “le cose abituali perdono l’identità che il flusso contemporaneo di informazioni conferisce loro” e diremo perciò che è l’arte inesistente stessa, “prendendo di petto la questione dei media e della loro avanzata”, a rispondere alla fine del mondo. Creando, a tutti gli effetti, un mondo nuovo.
La strategia anti-identificante dell’“opacità mediatica” trova la propria antitesi nell’operazione inaugurata dal secondo piano che Ariemma dispone all’indagine: Facebook. Il social network più frequentato al mondo è portatore di un legame decisivo con la fine, nella misura in cui il suo avvento ha deciso il tramonto di un mondo, quello del Web, che aveva trionfato sorgendo proprio dalle ceneri del mondo precedente. Prima fu il Web, poi fu Facebook. L’illusione di uno spazio senza confini e senza peso, laddove la scomparsa delle identità e del corpo avrebbe lasciato campo libero al trionfo della creatività e dell’incontro, si era sgonfiata fino ad adagiarsi in aderenza a due capisaldi, due colonne politiche tradizionali che sembravano in precedenza neutralizzate, sulla Rete: il nome e il giudizio.
Il secondo, figlio naturale del primo e sua diretta emanazione, è il principio fondante di Facebook, al punto che l’immagine del pollice alzato – associata alla funzione Like, al Mi piace – ne è divenuta il simbolo; dispositivo del luogo dello spettacolo, della messa in scena di sé innanzitutto attraverso l’esposizione del proprio gusto, in due parole: dell’identità.
L’estetica di Facebook illude riguardo all’opportunità di produrre “l’espressione autentica di un’interiorità” senza, tuttavia, il bisogno di riassumere su di sé il proprio corpo, le sue incoerenze, l’impossibilità di gestirne la percezione e di cancellarne la mortalità. Si tratta di una messa in scena senza paure, senza freni, senza l’opacità di cui l’arte inesistente s’è invece fatta tessitrice. Facebook è il luogo dell’eliminazione del sospetto.
Due strategie, quelle prese in esame da Tommaso Ariemma, affini nella funzione di creazione di mondi, inconciliabili nella modalità di tale creazione. L’arte contemporanea/inesistente vuole avere un mondo per farlo brulicare, per generare infiniti mondi da lasciar sfuggire all’identificazione. Facebook vuole invece avere un mondo, appunto, vuole possederlo, fermarlo più di quanto già non avesse cessato di vibrare, farlo identico e, nell’unificarlo, neutralizzarlo. All’affermazione iniziale, la tesi attuale di questo testo risponde che “forse il mondo dell’arte è ora l’unico mondo dopo la fine del mondo”.