
Traverso, Gaza davanti alla storia
Enzo Traverso è uno storico e intellettuale tra i più autorevoli, con un profilo internazionale di alto rilievo. Ha insegnato in Francia, dove si è trasferito dal 1985, a Paris VIII, all’Ecole des hautes études en Sciences sociales, come full professor all’Université de Picardie e infine negli Stati Uniti, alla prestigiosa Cornell University. Nella sua ampia bibliografia (una quindicina di testi, in gran parte pubblicati in francese e in inglese, oltre che in italiano) figurano i grandi temi della violenza nel XX secolo (in particolare il fondamentale testo su La violenza nazista. Una genealogia, del 2002); della cultura ebraica nella diaspora e del suo ruolo nell’autocoscienza della modernità; del senso e del significato di Auschwitz e della Shoah nella vicenda intellettuale postbellica. È uno dei quattro curatori, insieme a Marina Cattaruzza, Marcello Flores e Simon Levis Sullam, della monumentale Storia della Shoah pubblicata dalla UTET nel 2019. Ha dunque le carte perfettamente in regola per affrontare l’impervio tema cui è dedicato questo suo ultimo lacerante testo.
Gaza davanti alla storia non è un libro di storia, per il banale fatto che – l’autore lo dichiara fin dall’incipit – si occupa di un’attualità tuttora in corso. È piuttosto un libro sul presente visto alla luce della storia. Un’operazione in esplicita controtendenza, e quindi in sé coraggiosa, in tempi in cui il vezzo prevalente, e non privo di malizia, è la de-storicizzazione sistematica di ciò che accade, con una visione puntiforme degli eventi – siano essi il 24 febbraio per l’Ucraina, il 7 ottobre per Israele, o prima ancora l’11 settembre per gli Stati Uniti –, quasi che l’orrore scaturisca dall’istante, da una qualche “perversione morale”, senza nulla alle radici, né sul piano evenemenziale né su quello culturale. E come se i dispositivi argomentativi a vantaggio dei “nostri” e viceversa a condanna degli “altri” fossero innocenti nel loro carattere inedito e non invece riproposizioni di consolidati e già condannati stereotipi valoriali. Qui invece, al contrario, ogni fatto – e si tratta soprattutto di fatti violenti, della violenza estrema con cui la guerra identitaria contemporanea si esprime –, e soprattutto ogni “discorso”, è visto sullo sfondo di ciò che si è compiuto e pensato “prima”, nel processo temporale lungo il quale i protagonisti in conflitto si sono formati e hanno elaborato (e insieme trasfigurato e/o snaturato) le proprie rispettive identità e pratiche.
Grazie a questo approccio – come ha scritto Iain Chambers in una densa recensione sul Manifesto – Enzo Traverso “ha il coraggio di fare delle connessioni che in questi giorni e settimane sono invariabilmente bloccate, rifiutate e censurate per difendere l’indifendibile”. Come ad esempio “l’intreccio tra la modernità occidentale e la Shoah” nel cuore di tenebra del secolo scorso, da una parte, e “l’attuale spostamento della responsabilità europea per la Shoah sul mondo arabo, attraverso il sostegno incondizionato allo stato di Israele e l’imposizione ai palestinesi del peso di portare la colpa occidentale” dall’altra (si pensi all’atteggiamento della Germania). Un ordine del discorso, questo, che mostra quanto il punto di vista di Traverso – come dichiara lui stesso nell’Introduzione – si situi “fuori dal coro”, nel senso che “non coincide con gli assiomi di quella piccola parte del mondo che chiamiamo Occidente, la quale pretende di detenere il monopolio, oltre che del potere, della morale”. Non coincide con l’assioma che vede i palestinesi nella parte dei carnefici e gli israeliani in quella delle vittime; che esclude la qualifica di genocidio nell’operato di Tsahal nella Striscia; che definisce Israele come uno Stato limpidamente democratico e Hamas come un’entità esclusivamente terroristica; che identifica antisionismo e antisemitismo; che condanna come inequivocabilmente stragista lo slogan From the river to the Sea… Come si vede ce n’è abbastanza per condannare al rogo, per eresia, l’intero pamphlet, nel clima uniformato del nostro sistema mediatico, se non fosse che ognuna di queste affermazioni – su cui ovviamente si può dissentire – non è proposta apoditticamente, ma fondata, sia pur sinteticamente, su elaborazioni e riflessioni scientificamente accreditate, e filiere di studi ben radicate.

Prendiamo, ad esempio, la prima delle connessioni di cui parla Chambers, ovvero l’assonanza, stabilita da Traverso nel primo capitolo, tra i tentativi di rovesciare oggi il rapporto di colpa per la carneficina in corso nella Striscia a favore di un’Israele legittimata dal diritto-dovere all’autodifesa, e le retoriche che nel secondo dopoguerra nella Germania vinta tentarono di ribaltare la Schuldfrage – la questione della colpa – presentando l’operato tedesco come reazione (comprensibile) a una sofferenza e a una sfida prevalente. Una sorta di vittimizzazione del carnefice. Lo so che il paragone farà trasalire d’indignazione più di un lettore. Come assimilare i fautori postumi dell’assoluzione del nazismo ai sostenitori della legittima difesa da parte degli eredi delle vittime di allora di fronte a una nuova mortale minaccia? Traverso qui si riferisce al tentativo fatto da Heidegger nel 1948 di utilizzare le enormi sofferenze subite dalla popolazione tedesca durante e dopo la guerra mondiale per presentare la Germania come vittima. Operazione che Herbert Marcuse stigmatizzò duramente scrivendo al collega filosofo che così si poneva “fuori dal Logos”. E che fallì nella stessa Germania perché “i tedeschi sapevano che, quando il fuoco divorava le loro città e nuvole di fumo si alzavano in cielo dalle macerie, la Wehrmacht, la polizia e le SS stavano commettendo crimini ben più gravi di quelli che loro stessi avevano subito”. Ma che tuttavia sarebbe stata riproposta, in forma meno brutale, una trentina di anni più tardi, da un grande storico tedesco, Ernst Nolte, all’ origine dell’Historikerstreit – il grande dibattito sul passato hitleriano –, in cui i crimini nazisti erano descritti come “reattivi”, “biasimevoli certo, ma nati nella lotta contro una minaccia molto reale incarnata dal bolscevismo, il ‘prius logico e fattuale’ dei totalitarismi del XX secolo e della guerra sul fronte orientale”.
Ora, si chiede l’autore, non è forse Hamas, l’autore del massacro del 7 ottobre, il prius logico di tutto ciò che è seguito, sui corpi dei palestinesi di Gaza? Non è il richiamo alla sua “presenza”, il fattore utilizzato retoricamente dai difensori dell’operato di Israele nella Striscia per invocarne l’assoluzione? E presentare appunto quella carneficina che dura ormai da otto mesi come la difesa legittima di un aggredito contro l’aggressore? Tanto più che gli ambienti conservatori tedeschi che negli anni ’80 fecero proprie le posizioni di Nolte sono gli stessi che oggi mandano assolto Netanyhau e il suo governo stragista con argomentazioni sostanzialmente simili. Certo, per quelli come me, e in buona misura tutta la mia generazione, che ha posto i fondamenti della propria morale storica e politica sull’orrore assoluto di quella persecuzione, un simile accostamento appare come un pensiero quasi impensabile. Presuppone il superamento di una linea rossa che si credeva invalicabile. E tuttavia il carattere tragico del tempo che viviamo sta nel fatto che quella linea, inviolabile nel pensiero, viene quotidianamente offuscata nei fatti. E ben vengano scritti come questo, che ci impongono di confrontarsi con ciò.
Analogo ragionamento può essere fatto a proposito dell’“Orientalismo”, che costituisce il tema del secondo capitolo. L’Orientalismo, come l’ha definito Edward Said in un noto saggio del 1978, è il modo in cui l’Occidente ha rappresentato se stesso come superiore moralmente rispetto a un Oriente relegato nella dimensione dell’arretratezza e della barbarie. Esso ha costituito la base antropologico-culturale in forza della quale sono state giustificate in termini di civiltà le violenze e i massacri con cui si sono costituiti i rapporti di dominio coloniale, e si sono definite le gerarchie razziali, incarnando l’incapacità dell’Occidente “di definire sé stesso se non in opposizione all’alterità radicale di un’umanità coloniale, non bianca e gerarchicamente inferiore”. Ora, il luogo comune che “descrive Israele come un’isola democratica in mezzo all’oceano oscurantista del mondo arabo e Hamas come un esercito di belve assetate di sangue”, suggerisce Traverso, ne è una inquietante riproposizione. Tanto più inquietante in quanto proviene da quella stessa cultura ebraica che, un secolo fa, ne era stata ferocemente colpita.
Si tratta di una materia che lui ben conosce, questa della discriminazione degli ebrei nell’Europa dei nascenti colonialismi e nazionalismi, per averla studiata nei suoi testi su Gli ebrei e la Germania o sul cosmopolitismo ebraico, quando la “linea del colore”, quella che all’interno dell’Orientalismo dominante segnava il confine tra uomini e no in base alla pelle bianca, ne poneva gli ebrei al di fuori, tra gli Untermenschen, i sotto-uomini. E faceva, per contrappunto, della loro intellighentzjia un fattore di progresso straordinario (“Esclusi dal potere, gli ebrei incarnavano la coscienza critica dell’Europa. Il loro pensiero, faceva da ‘contrappunto’ al discorso dominante”). “Ospiti indesiderati” dell’Occidente, ne costituivano la risorsa culturale più dinamica. Oggi che invece sono passati dalla parte giusta della “linea del colore”, e sono diventati del tutto “bianchi”, perfettamente a loro agio nella grande famiglia dell’eccellenza occidentale grazie alla potenza del proprio Stato e alla fedeltà alle alleanze giuste, le loro dirigenze politiche (uomini, non dimentichiamolo, come Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich, Israel Katz…) possono replicare nei confronti dei loro più immediati vicini arabi le stesse argomentazioni che un secolo fa li avevano condannati e segregati, senza tracce di disagio. E può apparire come evoluzione naturale anziché come sconvolgente paradosso, “la singolare alleanza tra i suprematisti ebrei di Israele e i suprematisti bianchi degli Stati Uniti, che sono tra i più entusiasti difensori delle colonie in Cisgiordania, così come l’abbraccio tra i falchi della destra filoisraeliana e i leader del Rassemblement National di Marine Le Pen nel parlamento francese”. In fondo – ci ricorda Traverso – gli Übermenschen di Tsahal manovrano con perizia da razza superiore i sofisticati strumenti dell’Intelligenza artificiale per pianificare la distruzione sistematica di Gaza, strade, ospedali, case, chiese, biblioteche, università, musei, cimiteri…, per non parlare della caccia mirata agli abitanti, braccati da un capo all’altro della striscia. Operano “scientificamente”, la barbarie appartiene agli altri. Perché mai non dovrebbero essere considerati degni di entrare nella schiera eletta dei dominatori dai suprematisti di ultima generazione di tutto il mondo?
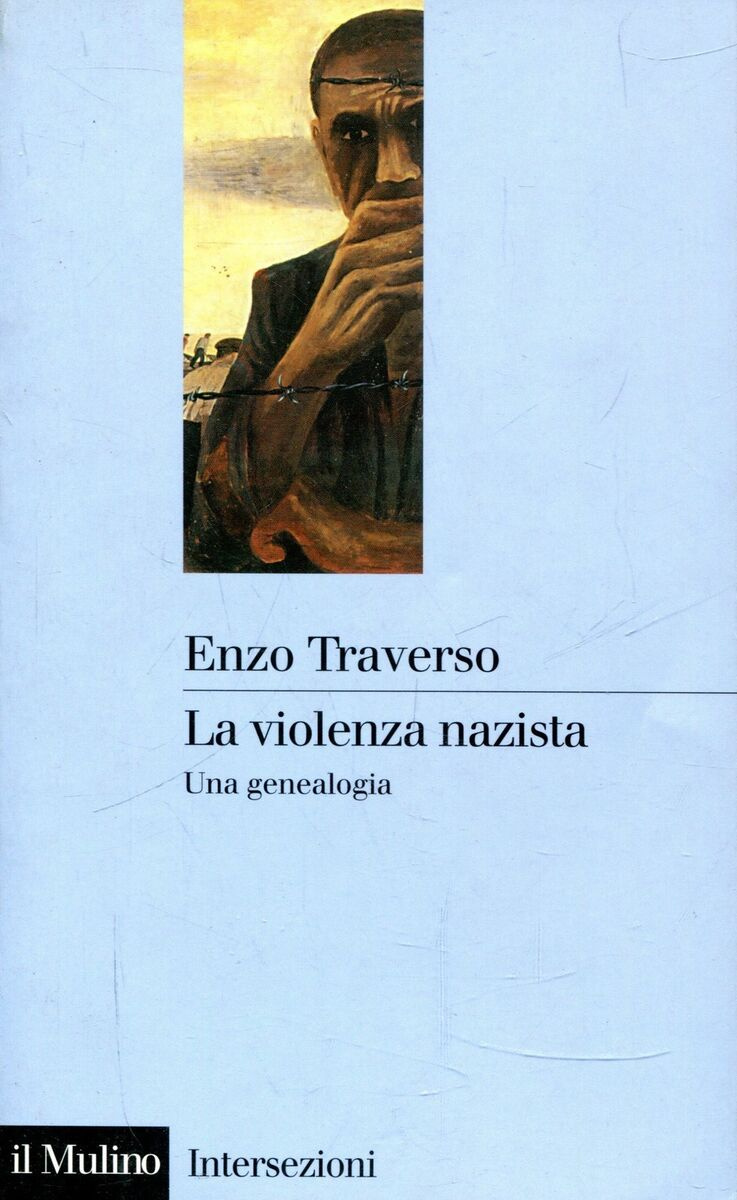
Si può definire tutto ciò “genocidio”? Una parola, inutile ripeterselo, di per sé mortale, perché se accettata per definire ciò che Israele fa nella Striscia, potrebbe prestarsi alla blasfema assimilazione dell’operato delle vittime di ieri a quello dei loro carnefici. Minaccerebbe la caduta della qualifica di vittime per antonomasia degli ebrei, consumata per loro stessa mano. Traverso conosce bene il problema. È stato sua materia di studio quando ha lavorato sul tema caldo Comparare la Shoah e sulle “Questioni etiche, storiografiche, educative della deportazione e dello sterminio” per Insegnare Auschwitz. Qui, citando lo storico Omer Bartow, ci avverte che la Convenzione delle Nazioni Unite “ha posto l’asticella molto in alto” nella definizione del concetto, suscitando così la propensione a “identificare il genocidio come un evento di portata, chiarezza ideologica ed efficienza burocratica analoghe” allo sterminio degli ebrei, creando una sorta di “divario” tra l’immaginario popolare che ne presuppone l’identificazione totale con la Shoah e il significato legale del termine che in realtà è a maglie assai più ampie. Si giustifica così il monito della Corte internazionale di Giustizia sul rischio che sia in corso un genocidio nella striscia di Gaza, e si spiega anche perché alcuni studiosi d’indubbia autorità in materia, come il professore di Genocide and Holocaust Studies Raz Segal (confortato dal parere di Dirk Moses, entrambi non certo sospettabili di sentimenti “antisemiti”), abbia potuto dichiarare che Gaza costituisce un “textbook case of genocide” (“un caso da manuale di genocidio”). Se infatti, come recita la norma, si deve affermare che il genocidio si configura quando vengono commessi atti “con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale (atti quali “l’uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo”), è difficile negare che l’uccisione indiscriminata di decine di migliaia di civili, tra cui in prevalenza donne e bambini, la distruzione di ospedali, fonti idriche ed energetiche, infrastrutture essenziali come fognature e depuratori, non ultimo l’impedimento manu militari all’afflusso di alimenti, medicine, generi di assoluta necessità, si avvicinino molto alla fattispecie in questione. Molti di noi, io tra questi, si sono finora avvicinati all’uso di questo termine con molta reticenza, in qualche modo con pudore, più che altro per la consapevolezza di quanto dolore possa procurare nelle vittime della deportazione o nei loro famigliari se riferito allo “Stato degli ebrei”, quasi uno svalutare l’assolutezza della loro sofferenza. Ma resta il fatto che non c’è parola che possa resistere a lungo al peso dei fatti che essa “nomina”. Non c’è significante che possa sottrarsi a lungo alle pretese del proprio significato. E il testo di Traverso ci richiama a questa impietosa realtà.
Gaza davanti alla storia affronta poi un gran numero di altri temi, ognuno dei quali meriterebbe uno spazio incompatibile con quello di una semplice recensione: la questione delle fake news per esempio, costruite e diffuse per rendere ancor più atroce la già orrenda realtà del 7 ottobre; la trasformazione antropologica dei soldati israeliani, nati e cresciuti nella logica di guerra contro un nemico assoluto; la vexata quaestio delle memorie incrociate, ovvero dell’uso virtuoso o vizioso della memoria già affrontato da Primo Levi quando mise in guardia contro il rischio di credere che la Shoah procuri a Israele “uno status di innocenza ontologica”, ecc. Ci sarà il modo e l’opportunità di ritornarvi se, come è auspicabile, il dibattito (anziché l’anatema) su questo libro sarà scelto come occasione per una riflessione per quanto possibile serena sul nostro stato di civiltà. Qui però vorrei ancora soffermarmi, sia pur brevemente, su un aspetto del libro che mi ha ispirato un sostanziale dubbio e una nota di dissenso. Ed è la parte in cui si affronta il tema della violenza. Della violenza degli oppressi, per dirla con Sartre. Diciamolo pure senza fronzoli: dei metodi di lotta di Hamas come espressione della resistenza palestinese.
Intendiamoci. Traverso non è affatto indulgente nei confronti del 7 ottobre. Non ne nega né attenua l’orrore e la necessaria condanna. Esso – scrive – “è un crimine che nulla può giustificare e che deve essere condannato”. E poco prima aveva precisato: “L’attacco del 7 ottobre fu atroce. Pianificato con cura, fu ben più letale del massacro di Der Yassin o di altri simili commessi dall’Irgun nel 1948. Il suo scopo era quello di diffondere il terrore e non è giustificabile”. Ma – aggiunge – “deve essere analizzato e non solo condannato”. E costruisce questa analisi a partire dalla constatazione che “questi mezzi incongrui e riprovevoli sono stati utilizzati in una lotta legittima contro un’occupazione illegale, disumana e inaccettabile”. Sforzandosi di guardare gli eventi per una volta non con gli occhi di noi occidentali, americani o europei che siamo, ma con quelli dei palestinesi. E utilizzando l’ampio strumentario argomentativo della letteratura simpatetica con le lotte di liberazione anticoloniali (“L’uomo colonizzato si libera nella e attraverso la violenza” – Franz Fanon). In quest’ottica inscrive l’azione di Hamas nella categoria e nel più ampio repertorio delle azioni di un classico “movimento di liberazione nazionale”, in quanto espressione, anche se non unica, della Resistenza palestinese. Ne definisce la pratica terroristica (non certo negata) come “risvolto dialettico del terrorismo dello stato israeliano” la cui legittimazione non è equiparabile: “Il crimine del primo sta nell’uso di mezzi illeciti; quello del secondo sta nel suo stesso scopo, da cui deriva”. Ed è qui che, per quanto mi riguarda, sorge un’obiezione.

Non credo che il 7 di ottobre possa essere assimilato ai tanti precedenti atti, anch’essi indubbiamente terroristici, compiuti dai tradizionali movimenti di liberazione nazionale Gli attentati nei bar di Algeri da parte del FLN, quelli nei bordelli di Saigon per opera dei Vietcong, le stesse azioni dei nostri Gap nelle città occupate… Qui c’è qualcosa di più terribile, non solo nelle modalità del massacro, ma nei suoi obiettivi. Credo infatti che nei piani di chi ha programmato per mesi e mesi, e organizzato quella vera e propria “azione di guerra” non ci fosse solo l’obiettivo di terrorizzare il nemico, di colpirlo oltre che nella sua componente militare pure tra i civili, ma che fosse anche messa in conto, e consapevolmente ricercata, la rappresaglia indiscriminata di Israele contro la stessa gente di Gaza. Che i capi di Hamas cercassero quel martirio di massa, come strumento di propaganda e di proselitismo. Obiettivo pienamente raggiunto data l’ottusità criminale con cui il governo di Netanyhau si è gettato nella trappola e ha firmato la propria condanna globale. Questo colloca tuttavia Hamas in un comparto diverso dai tradizionali movimenti di resistenza. La sua vocazione martiriologica, questa ricerca accanita del sacrificio della propria stessa popolazione per il trionfo della causa, rinvia a radici altre, più torbide, affondate nella sfera inquinata di una sacralità perversa, che rende difficile l’applicazione dei tradizionali cliché.
Detto questo, appare invece molto convincente la denuncia che Traverso fa delle conseguenze regressive di tutto quanto accade, e soprattutto del dispositivo narrativo e argomentativo messo in campo dal sistema mediatico e politico occidentale per neutralizzare o quantomeno contenere l’ondata di indignazione nell’opinione pubblica. In particolare della dissennata equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, e più in generale della ricodificazione di ogni critica all’operato del governo di Israele come forma più o meno velata di antisemitismo. È in forza di questa operazione che siamo costretti quotidianamente a essere spettatori dell’apparente aberrazione per cui gli antisemiti di ieri si attribuiscono oggi il ruolo di giudici addetti ad assegnare l’infamante qualifica di antisemitismo a chi da sempre si era battuto contro il loro razzismo. Spettacolo particolarmente sconvolgente qui da noi, dove i post-fascisti di Meloni – gli “eredi delle leggi razziali del 1938 oggi al governo”, quelli che celebrano come padre fondatore quel Giorgio Almirante che come capo-redattore di “La difesa della razza” predicava il “razzismo del sangue” –, dispensando patenti di antisemitismo a chi si azzarda a criticare Israele “possono affermare la loro appartenenza al campo occidentale, stigmatizzare la sinistra e condurre politiche xenofobe contro i migranti”.
Come dar torto a Traverso quando constata che “combattere l’antisemitismo diventerà sempre più difficile dopo averne sfigurato e distorto la natura così sfacciatamente.” Se “in nome della lotta all’antisemitismo è possibile condurre una guerra genocida, molte persone oneste inizieranno a pensare che sarebbe meglio abbandonare una causa così dubbia. Nessuno potrà evocare l’Olocausto senza suscitare sospetti e incredulità; molti arriveranno a credere che si tratti di un mito inventato per difendere gli interessi di Israele e dei suoi alleati”. E sarebbe una perdita secca per tutti noi, che nel lunghissimo dopoguerra seguito al ’45 abbiamo coltivato la memoria della Shoah come “religione civile”. “La sacralizzazione rituale dei diritti umani attraverso il ricordo delle vittime”, come scrive Traverso, perderebbe “tutte le sue virtù pedagogiche. I nostri orientamenti morali, epistemologici e politici sarebbero irrimediabilmente annebbiati”.
Ci aiutano, e contribuiscono a salvare la grandezza della cultura ebraica nel mondo, i tanti ebrei che, minoranza in Israele ma presenti e attivi nel contesto internazionale, a cominciare dagli Stati Uniti, manifestano apertamente il proprio dissenso per l’operato del governo israeliano, unendo al cordoglio per il massacro del 7 ottobre la deprecazione per la carneficina di questi mesi nella Striscia. Sono gli eredi di quella straordinaria cultura diasporica – cosmopolitica, umanistica, illuministicamente razionalista – che tanto ha contribuito a dare all’Occidente un’autocoscienza critica e un’anima progressista (e a cui Traverso ha dedicato molti suoi studi: si pensi al suo Cosmopoli. Figure dell’esilio ebraico-tedesco). Sono un antidoto importante contro l’ondata di antisemitismo che prendendo origine dalle residue radici della destra radicale globale, e virulentizzandole con le sostanze tossiche della guerra, rischia di contaminare con gli spettri del passato il nostro già precario presente.









