Speciale
Campioni # 1. Gian Maria Annovi
La Signora # 1
me la mettono in casa per forza
ad aspettare che muoia
una non italiana
una troia
io che insegnavo il latino
che traducevo il greco
e ora una cosa che sbatte le ciglia
che appena mugugna
un sacco di ossa e respiro
e lenzuola
[…]
La Scolta # 2
mattina lava Signora con carozina.
lava tutta. con saponetta. con spunia.
lava capelli anche.
lava là in fondo che Signora non vuole
e mi grida.
ma io volio profuma di buono
non quello suo odore
di donna che more.
da Id., La scolta (Roma, nottetempo, novembre 2013, pp. 33, € 4), p. 11 e p. 13
Già col primo dei nostri «Campioni» poetici tocca contravvenire a una delle regole che ci siamo dati per questo gioco: la scelta cioè – per ciascun libro a sua volta eletto a «campione» della «vera contemporanea poesia» – di un solo componimento che appunto faccia da «campione» della sua lingua e del suo immaginario. Il fatto è che sempre più, nella poesia di Gian Maria Annovi, si assiste al significativo passaggio da un «iniziale sperimentalismo astratto», nel quale i testi figuravano «in sé stessi immobili come oggetti o fotogrammi», a «un’articolazione più prettamente narrativa, dove la serie è intesa come messa in movimento dell’immagine-testo» e «dove il racconto è volontà di agganciare non solo la realtà di una concezione problematizzata dell’io, ma il tempo presente, la problematica realtà di questo paese e dei suoi nuovi soggetti» (così Annovi nella nota consegnata a Poeti degli Anni Zero, a cura di Vincenzo Ostuni, Ponte Sisto 2011). È appunto questo il caso della Scolta: che, sin dalla sua prima apparizione (sul numero 39 del «verri», febbraio 2009), si fa dunque leggere alla stregua d’un poemetto anziché come suite, per quanto compatta, di addendi similari (come poteva ancora apparire, invece, il magnifico Kamikaze (e altre persone) edito nel 2010 da Transeuropa).
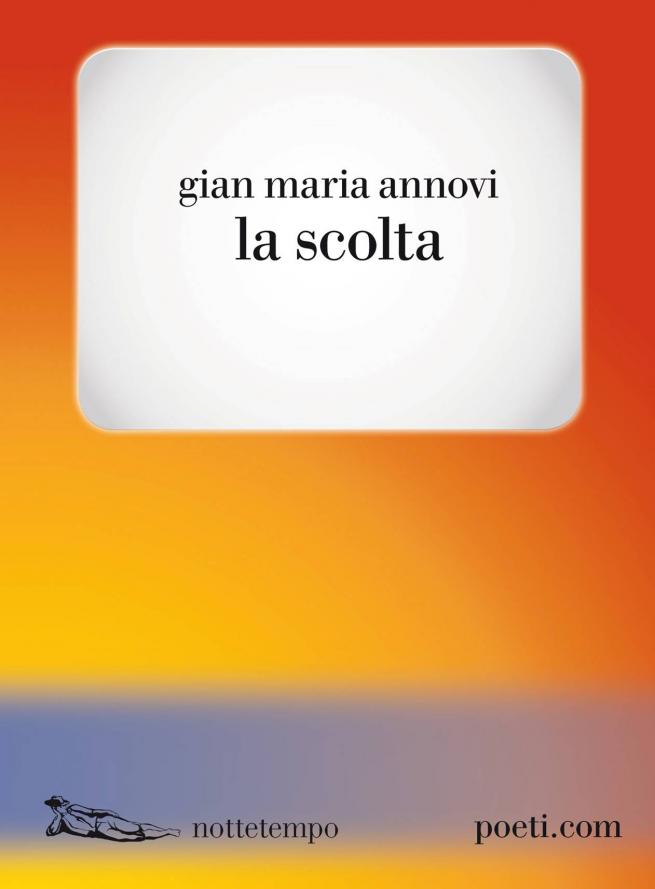
Beninteso l’interpretazione annoviana della forma-poemetto, e della sua stessa istanza «narrativa» (istanza che accomuna tanta parte della poesia Anni Zero), nulla concede alla linearità diegetica e all’uniformità tonale cui troppo spesso il concetto di narratività, in poesia, viene associato. Se di narrazione si tratta è, questa, una storia franta e spezzata, esplosa e «bombata» – come i corpi-kamikaze che, tormentosi, figurano nel libro precedente. A partire appunto dalla partizione della voce: dal suo dislocarsi (che nell’esecuzione, come si può qui ascoltare, l’autore di volta in volta estremizza o attenua) a due estremi opposti i quali istituiscono dunque, piuttosto che una narrazione, una drammaturgia. Ci sono in effetti le parole di Eschilo, il «Prologo della scolta» dell’Agamennone, nell’esergo di Annovi; subito seguite da quelle dal suo film-feticcio, Persona di Ingmar Bergman del ’66 («Penso che potrei diventare te, se ci provassi. Dentro, intendo»).

La Scolta è figura appunto della tragedia classica, e anzi in assoluto la prima voce che del suo repertorio ci sia pervenuta, come spiega Annovi nella brevissima nota posta in coda al suo libro: «L’Orestea di Eschilo inizia con il monologo di un personaggio destinato a non comparire mai più nell’intera trilogia. È la scolta, o guardia, che racconta del suo anno passato in attesa del segno – il fuoco di Troia che brucia – che lo libererà del suo compito. Giunto il segnale, il suo personaggio scompare per sempre. La sua funzione, il senso della sua esistenza di personaggio, è unicamente nell’attendere». La riscrittura che il poemetto di Annovi compie di questa prossemica, più che di questa trama, traumaticamente fa collidere la lingua della poesia, davvero, con la problematica realtà di questo paese e dei suoi nuovi soggetti: oggi la Scolta altri non è, infatti, che la “badante”, la donna non italiana posta a sorveglianza della vita muta, se non ancora del tutto nuda, di una signora vecchia e malata, ormai ridotta a una cosa, un sacco di ossa e respiro. Il confronto fra le due persone – ma si legga il termine, come nei libri precedenti di Annovi e come già appunto nel maestro svedese, nell’accezione latina delle maschere teatrali – ripete quello del film di Bergman (così la Scolta nel suo quinto monologo: «in tele fanno / film interessante. / bianco anche / e nero. // con due signora / che sono come solo / una persona. // donna malata / una. // altra / donna infermiera»), magari con un survoltaggio sadomasochistico tale da far pensare, piuttosto, al terribile dittico tratto da Henry Farrell da Robert Aldrich, con la presenza persecutoria di Bette Davis: Che fine ha fatto Baby Jane del ’62 e Piano… piano, dolce Carlotta del ’65.
Il vero e proprio duello che s’inscena, allora, è la traduzione in termini prossemici, s’è detto, di un conflitto culturale e sociale ma, ancor prima, biologico e creaturale (la Signora mastica acido: ‘scolta: tu quasi mi anneghi / nella vasca con l’acqua troppo calda… la sento che striscia / nella notte che non dorme / la segue il rumore delle ciabatte… mi conta i fiati // e non sa se vuole che li fermi; la Scolta morde il freno: se Signora mi morde / io dice // facciamo la brava bambinaa… di notte aspetto vedere la luce. / che giorno viene / e vedere Signora se respira. // se no respira è mio segno. / che devo partire… penso di togliere / il soffio / a la donna. // con cuscino con / borsa da plastica. / forse.). L’impotente aggressività della Signora è incrudelita dalla privazione della parola – le sue battute, scritte in corsivo, sono pronunciate solo col pensiero –: contrappasso crudele per chi proprio dalla padronanza della lingua trarrebbe un’evidente superiorità – lei che insegnava il latino / che traduceva il greco – su chi invece si esprime in modo elementare e gutturale («parli una lingua che pare / calcata da un grosso bove», si rivolge alla Scolta la Signora nel suo secondo monologo).

Proprio la voce della Scolta rappresenta l’invenzione più mirabile, nonché retoricamente rischiosa (nella nota apparsa sul «verri» Annovi evocava lo spettro della parodia insultante che infastidisce nel «doppiaggio dei personaggi afroamericani nei film degli anni ’40», l’effetto Miss Rossella insomma), ad annunciare sin da subito la memorabilità di questo piccolo libro geniale. Il cui unico precedente, in questo senso, mi pare evocabile in un curioso libro narrativo di Cetta Petrollo (Senza permesso. Avventure di una badante rumena, prefazione di Walter Pedullà, Stampa alternativa 2007), che inanellava una serie di scene urbane quotidiane affidandone lo straniamento appunto alla trascrizione quasi-scientifica di un semi-italiano imbastardito e divertitamene creativo (un volto linguistico, quello della giovane rumena Silvia in cerca di lavoro, che non stupiva troppo potesse essere evocato da chi per tanto tempo ha condiviso l’esistenza col maggiore inventore di voci del nostro secondo Novecento, Elio Pagliarani…). Quella della badante di Annovi è «una lingua appesantita dallo sforzo e dallo spaesamento», ha scritto Antonella Anedda, «una lingua modificata dalla fatica, modulata dalla pazienza tradotta da un altro alfabeto, un’altra grammatica in cui non esiste l’articolo, con segni diversi in cui entrano vento, gelo e suoni gutturali, suoni sciti, ritmi lontani».
Il bove è evocato dallo stesso Eschilo («Un grosso bove calca la mia lingua»), ma a un lettore di poesia ricorda piuttosto la presentazione in chiave di paradosso del «miglior fabbro», Arnaut Daniel («Io sono Arnaldo […] e col bue vado a caccia della lepre»); o il supplizio del toro bronzeo di Falaride, tiranno di Agrigento, come lo racconta Dante nel XXVII dell’Inferno («Come ’l bue cicilian che mugghiò prima / col pianto di colui, e ciò fu dritto, / che l’avea temperato con sua lima»: citazione già posta in esergo a una sezione della sua raccolta d’esordio, Rame del 1984, da Gabriele Frasca; e del resto alla poesia più famosa di Frasca, Fumetto dalla sua raccolta successiva, Lime, se non vado errato allude il terzo monologo della «Signora» di Annovi…); se non addirittura quello che è forse in assoluto il primo incunabolo del volgare europeo, il cosiddetto Indovinello veronese (VIII-IX secolo), che come si ricorderà suona «Se pareba boves, alba pratàlia aràba et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba».
Tutti questi possibili precedenti sono ben calzanti al rischio che, si diceva, s’è assunto Annovi: il paradosso, l’impossibilità evocata da Arnaut coi suoi adynata in serie; la condizione autopersecutoria dell’artefice nel mito ricordato da Dante (perché fu ovviamente per primo lo scultore Perillo, colui che l’avea temperato con sua lima, a soffrire il supplizio del toro posticcio in cui venivano cotti a fuoco lento i prigionieri del tiranno, in modo che dalla sua bocca i loro lamenti uscissero in forma di “artistico” muggito); e soprattutto la situazione inaugurale dell’indovinello.
Come quest’ultimo rappresenta l’atto stesso della scrittura, infatti, la lingua della Scolta di Annovi rappresenta la primissima presa di parola, quanto meno nel nostro repertorio poetico, di quelle minoranze linguistiche che stanno cominciando a imprimere anche alla nostra lingua quella torsione, quella minorazione creativa che Gilles Deleuze – a partire dal celebre saggio su Kafka – chiamava liminare o, appunto, minore: «non si tratta di parlare una lingua come se si fosse uno straniero, ma di essere uno straniero nella propria lingua, nel senso in cui l’americano appunto è la lingua dei Neri». Quella che Deleuze provocatoriamente chiamava «superiorità della letteratura anglo-americana» (nelle Conversazioni del ’77 con Claire Parnet) consisteva appunto nella capacità della sua lingua (a differenza del francese, assimilazionista e fusionale) di «torcersi, di rompersi, di mettersi al servizio segreto di minoranze che la lavorano dal di dentro, involontariamente, ufficiosamente, rodendo quell’egemonia man mano che essa si estende: l’inverso del potere» (una condizione che, almeno una volta, Deleuze ha tradotto con la stessa metafora dell’Indovinello veronese: «lo scrittore», si legge nell’introduzione a Critica e clinica, «trascina la lingua fuori dai suoi solchi abituali, la fa delirare»).
Come si arrende a dire la Signora, definitivamente cedendo le armi della propria egemonia, nell’ultimo dei suoi monologhi:
sento la voce di Dante
quando ascolto che parla
lingua la sua che s’innova e che
scalcia
che s’esalta tra i denti
che scalza dal nostro domani
questo paralizzato italiano
Dante, certo: quello che nella sua Conversazione su Dante Osip Mandel’štam chiamava il suo «congenito dadaismo», la «stupenda infantilità» della sua lingua che fa pensare al «cinguettio dei bambini». È lo stesso spirito-guida che nel precedente Italics (Aragno 2013) conduceva per mano al canto dei migranti ispirato al Pascoli di Italy: laddove il vettore dell’esilio, lì capovolto rispetto a questo della Scolta, ricalcava quello vissuto davvero, biograficamente, dall’Annovi ormai da tanti anni trapiantato negli States.

E così quello che inscena la problematica realtà di questo paese e dei suoi nuovi soggetti è lo stesso libro che torna, ossessivo, alla concezione problematizzata – ma piuttosto, direi, scissa sino al rito sacrificale – dell’io. Non c’è bisogno di attendere la “voce di sintesi” del conclusivo Canto d’uscita – in cui le personæ della Scolta («è il momento credo che scompaio / che scompare il motivo dell’attesa») e della Signora («poi è un sonno violento che si alza / una pace che invade le narici // la go // la») si fondono, linguisticamente e insieme psichicamente – per capire come le due maschere che hanno tenuto la scena siano le due facce di una stessa condizione, e il teatro cui abbiamo finora assistito nient’altro che la crudele psicomachia di un monodramma (facciamo la brava bambina, dice la Scolta alla Signora nel suo quarto monologo: nella finzione drammatica per ammansire i suoi furori, ma sulla scena della psiche per tentare di ricomporre in un unico soggetto – la brava bambina appunto – la Spaltung che fra loro ha separato le due “voci”).
È appunto nella partizione delle voci, secondo Jean-Luc Nancy (questo il titolo d’un suo saggio del 1982 sul dialogo platonico sulla poesia, lo Ione, da noi curato da Alberto Folin nel ’93 per Il Poligafo), che si rivela la natura composita di qualsiasi soggetto (quello che chiamerà poi, lo stesso filosofo, Essere singolare-plurale). Per cui ogni monologo non può che rivelarsi, a un qualche livello, in realtà un dialogo; il che vuol dire poi, a livello politico, che nessuna comunità si renderà possibile se non a partire dalla presa d’atto di questa suddivisione costitutiva. La scomposizione del volto in due metà, alla fine del film di Bergman, rivela come alla voce spezzata del soggetto non sia mai dato, in realtà, ricongiungersi davvero. Ma se un dialogo, fra noi, si renderà un giorno possibile, allora potremo dire – finalmente – di essere nati.
Gian Maria Annovi (Reggio Emilia, 1978) vive a Los Angeles, dove insegna letteratura italiana presso la USC-University of Southern California. Laureato in filosofia, ha conseguito un dottorato di ricerca in italianistica presso l’Università di Bologna e un Ph.D. in Italian Studies alla Columbia University. Ha esordito con Denkmal (l’Obliquo 1998), seguito da Terza persona cortese (d’if 2007), Self-eaters (CRM 2007, finalista al Premio Antonio Delfini), Kamikaze e altre persone (con prefazione di Antonella Anedda, Transeuropa 2010, finalista al Premio Lorenzo Montano), Italics (Aragno 2013), La scolta (nottetempo 2013). Le sue poesie sono state tradotte in inglese e spagnolo e incluse, tra le altre, nelle antologie L’opera comune (Atelier 2001), Parco Poesia (Guaraldi 2003), Nodo sottile 4 (Crocetti 2004), Poesie dell’inizio del mondo (DeriveApprodi 2007), Calpestare l’oblio (Cattedrale 2010), Poeti italiani in America (In forma di parole 2011), Poeti degli anni Zero (Ponte Sisto 2012). Nel 2006 ha vinto il Premio Mazzacurati-Russo per l’opera inedita. Ha tradotto diversi poeti nordamericani e scrive per «il manifesto» e «alfabeta2».









