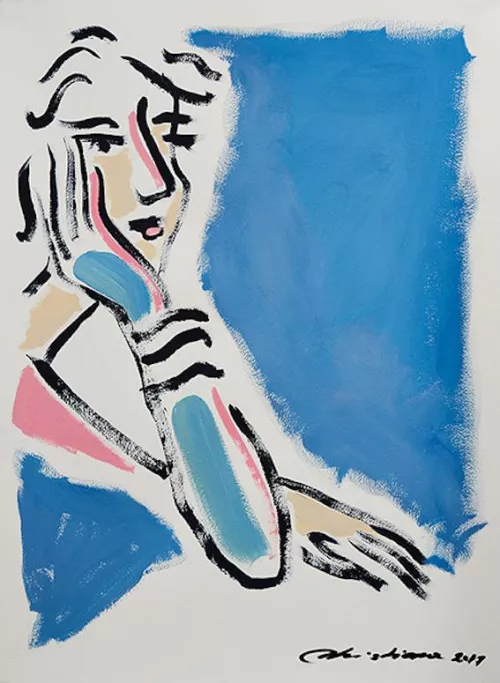Speciale
Parole per il futuro / Coraggio
Per quanto ho potuto mi sono tenuta alla larga dalle relazioni di potere, in primo luogo per la loro stupidità. Ma ogni tanto, mio malgrado, mi è capitato di inciamparci e di accorgermi di quanto, paradossalmente, il potere si nutra di… pavidità. Il piccolo potente, soprattutto quando il suo regno è infimo e periferico, è spesso pavido, altrimenti non avrebbe bisogno di adepti, paggetti, maschere, scuse, manovre e bugie per esercitarlo. (E non parlo degli ovvi e doverosi compromessi e negoziazioni che fanno parte del vivere politico e che hanno una loro etica.) Il pavido potente – il potente perché pavido – non guarda negli occhi, sfugge e manda avanti i sottoposti, cercando di agganciare la parte dipendente che ognuno ha. E se questa è molto estesa, la pavida impresa riesce.
Il dis-incontro col potere pavido e arrogante perlopiù fa perdere tempo, rallenta i passaggi innovativi di tutti. E ostacola il coraggio.
Il conformismo è il nemico numero uno del coraggio ma non gli si oppone in maniera diretta, lo fiacca per così dire dall’interno, lo attacca da dentro, lo svuota. Nettare del potente, assassino di ispirazioni e cambiamenti, il conformismo è portatore di un virus dal contagio rapido che provoca una forma assai diffusa – purtroppo anche tra i giovani – di accidia mentale, di paralisi progettuale, di caduta di interesse. Una neghittosità indifferente, connessa a una colpevole debolezza della curiosità, una viltà morale (la definizione è di Lacan) che perde l’umanità dell’uomo. Tommaso D’Aquino ne dà una fine e moderna analisi: “L’accidia è una tristezza in cui l’uomo diventa disinteressato ai beni dell’anima” che, in senso moderno, stanno per i suoi stessi beni, quelli della propria soggettività e umanità. Intorpiditi al fuoco tiepido del potente, che gli vende cara ogni singola fascina, non sono né vivi né morti e nell’Apocalisse si dice: “poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca”. L’alacre accidioso, l’indaffarato portaborse servo del capo, gira a vuoto, senza vita ma incapace di morire.
Il coraggio non decade mai per opposizione diretta, operazione che lo rafforzerebbe, ma può avvenire solo di sbieco. Spesso viene confuso con chi si lancia senza pensiero, con chi passa all’atto, in modo irriflesso e aggressivo, ponendosi così e fuori dal linguaggio e dall’assetto simbolico che ogni comunità si dà per vivere e prosperare: la parola si atrofizza, rimbalza, come se non potesse far breccia e penetrare lo scudo della mancanza di curiosità intellettuale. Dall’altro lato, il coraggio viene anche confuso con l’ambizione narcisistica, dove il linguaggio è conosciuto ma viene torto al proprio tornaconto, attivando la sua parte più convenzionale, finendo per esaltare ogni posizione mainstream, magari venduta spudoratamente per nuova.
Quando avvertiamo una certa mancanza di coraggio, prestiamo orecchio, non sorvoliamo, non prendiamolo per una semplice tratto del carattere o tatto della personalità (più che tatto è tattica). È lì che si nasconde il lato più offensivo del potere, sia da parte di chi lo esercita, sia da parte di chi lo idolatra. Perché una cosa è certa: se il capo manipola il linguaggio, l’adepto non ha mai una parola propria, la sua bocca gorgoglia fango, come gli accidiosi di Dante, ripetendo formule non proprie. Il potere crea alacri accidiosi, insensatamente attivi a lavorare per il capo in cambio di un favoruccio, piccolo o grande, che pesa come una catena. Un miraggio li lega: pensare di raggiungere tutto ciò che vogliono (quante mafie si reggono su questo meccanismo?).
E qui si capisce perché il potere è alieno alla vita: per vivere degnamente è necessario perdere qualcosa, ma la “viltà morale” che lega il suddito al capo mal sopporta di rinunciare a qualcosa. Al contrario, soggettivare la perdita è autorizzarsi a lavorare per il proprio desiderio, cosa che sarebbe già un atto di coraggio.
Chi è ancora coraggioso? Chi può esserlo? E come?
I più coraggiosi sono i bambini, perché ci vuole coraggio ad essere bambini, questo da sempre ma soprattutto oggi. I bambini devono sopravvivere agli adulti, a questi adulti contemporanei che li pensano più come oggetti propri che soggetti del mondo. La dimensione del coraggio implica quella di futuro e l'inconscio, più che il passato, è per Lacan l'avvenire del soggetto, il suo nascere, il suo emergere con una voce singolare che si oppone alla ripetizione.
È nell’infanzia che ci si allena a sopravvivere alla perdita – la perdita del caldo luogo uterino, del seno, della presenza costante della madre – e che si fa training del coraggio. In un’epoca in cui le persone sono piene di pretese, segnaliamo qualche gesto di coraggio che si disegna nella perdita, tanto necessaria quanto inattuale.

1. Il coraggio del genitore di deludere il bambino.
Il Freud bambino s’indignò davanti alla debolezza del padre che un giorno gli apparve vile lasciando passare il gentile maleducato che chiedeva largo all’ebreo. Nel suo immaginario infantile gli opponeva il padre di Annibale che fece giurare a suo figlio di combattere contro i Romani per vendicarlo. Il bambino Freud scopre i limiti del padre, scopre che non era l’eroe che lui ammirava: ed è esattamente così che il padre lo libera di sé. Ciò che capisce è che il padre non è onnipotente, che non è come il padre di Annibale, il quale in realtà forse non rese un gran servizio al figlio annettendosi la vita del giovane con quel lascito ingombrante. Il ricordo che il padre di Freud ha offerto a suo figlio, e lui offre a noi, mette in luce che la liberazione del figlio rispetto all’onnipotenza dei genitori deve venire da loro: essi devono avere il coraggio – e la grandezza – di deludere il proprio figlio per liberarlo di sé. E oggi che il genitore considerato sapiente non è più il padre ma la madre, questo passaggio dipende da queste ultime che dovranno essere all’altezza di giocare sul filo di una liberazione del figlio che non abbia il sapore di un abbandono.
2. Un esempio di coraggio politico.
L’ora più buia è quella della crisi. L’ora più buia è l’ora della crisi, quella in cui ogni premier cerca le parole da dire ai suoi concittadini, è il momento in cui storia e cultura diventano risorse di governo. Churchill mandò al fronte le sue parole, oltre che il suo esercito: ebbe ragione di Hitler anche grazie ai suoi discorsi alla radio che funzionarono da cintura simbolica per il suo popolo, minacciato di invasione e assoggettamento. Durante la guerra, la sua forza non poggiò unicamente sulle strategie militari e sulle alleanze, ma anche sulle sue argomentazioni coraggiose e sulle sue idee originali: la Marina inglese annaspava e Churchill ideò l’operazione Dynamo, apparentemente bislacca, e invece destinata al successo. L’invenzione, culla del coraggio, appare sovente come stravagante. L’invenzione è sempre il contrario del conforme.
Churchill raggiunse il risultato insperato di far rientrare in Inghilterra, salvandoli da morte certa, oltre trecentotrentamila soldati, imbarcandoli su una flottiglia composta di barche da diporto appartenenti a privati cittadini inglesi. La forza argomentativa delle parole del primo ministro britannico – che i suoi detrattori riducevano a orpello di un personaggio istrionico – riuscì persino a mantenere i britannici in guerra anche quando, nel 1940, erano rimasti gli unici a opporsi al nazismo. A Halifax, che voleva trattare con Hitler, Churchill rispose con una di quelle metafore che si imprime nella mente di chi l’ascolta e che può invertire la storia: «Ma quando apprenderete la lezione? Dio santo! Quanti dittatori dovremo ancora vezzeggiare, blandire, favorire con immensi privilegi per capire che non si può ragionare con una tigre quando si ha la testa nelle sue fauci?».
3. La mancanza di coraggio della scuola
Nella scuola c’è un eccesso di plusmaterno soccorrevole. Sul piano didattico tutto è semplificato, facile, ma anche senza appeal, un sapere a bassa eccitazione: così, la scuola diventa una culla che prolunga quella familiare e in cui si continua a dormire, invece che una fucina, un laboratorio di vita e di pensieri nuovi. Dalla culla alla tomba il percorso si accorcia.
Molti disagi giovanili sono patologie del controllo, quello che si instaura quando il coraggio salta: l’anoressica controlla ogni grammo del suo cibo e del suo corpo, l’hikikomori controlla che ogni centimetro del suo spazio sia libero dall’altro, la cutter dice di tagliarsi per controllare i suoi impulsi peggiori. La triste invenzione dei registri elettronici impedisce ai ragazzi di saltare le lezioni o di omettere la notizia dei brutti voti a casa: questo è un annuncio di morte della responsabilità e dell’arguzia, perché i ragazzi non possono neppure più immaginare un piano di salvataggio da raccontare ai genitori e di recupero, in una sfida intima, di un’insufficienza scolastica. Con questo sostituto del braccialetto elettronico sediamo il nostro bisogno di controllo e la loro inventiva. Li priviamo della possibilità di assumersi le loro personali trasgressioni dimenticando che, se non trasgrediscono contro di noi, trasgrediscono contro se stessi; se non trasgrediscono un po’, trasgrediscono del tutto; se non lo fanno nell’età della disobbedienza, lo faranno più tardi. Quante analisi riguardano pazienti cresciuti in famiglie convenzionali incapaci di tollerare il loro essere divergenti!
4. Il coraggio di desiderare la non-maternità
Il primo passaggio per un neofemminismo coraggioso potrebbe essere ripensare un posto assolutamente dignitoso anche per chi desidera essere non-madre: è importante riconoscere il desiderio di non-maternità, oltre a quello di maternità, senza pensare che chi è non-madre abbia avuto sempre un qualche impedimento fisico, affettivo, psichico, economico o professionale. In un tempo di non-binarismo e di ipervalutazione del gender, cioè in un’epoca in cui l’anatomia sessuale non è considerata determinante, perché si continua a pensare che chi ha un utero è normale che procrei?
Non si può neppure continuare a pensare che chi desidera la non-maternità sia per forza narcisista, visto lo status altamente narcisistico di molti genitori contemporanei. La non-maternità può essere un desiderio, non un deficit. Attenzione alla formulazione: desiderio di non-maternità è diverso che dire non desiderio di maternità perché nella seconda enunciazione sembra decadere la dimensione democratica, fondativa di un essere umano, del desiderio, cosa che non è, se non altro per il coraggio sociale e personale che questa scelta oggi implica per una donna.
Non arretrare di fronte all’ultimo tabù, quello del valore della non-maternità, è il minimo che ci si aspetti da un movimento femminista che sembra averlo dimenticato. Ci sono donne che considerano traumatico e infelice l’essere divenute madri. Abbiamo il coraggio di tenerne conto?
L’ultima cosa di cui ha bisogno il legame umano è la pavidità.