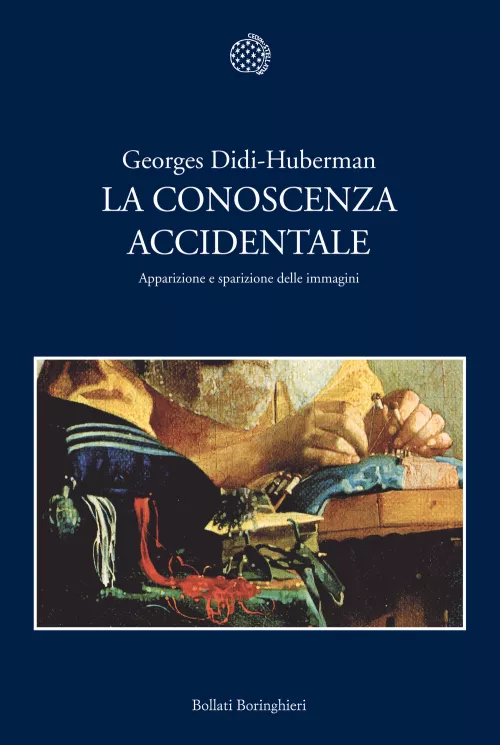Didi-Huberman. La conoscenza accidentale
Ogni volta che ci capita di guardare un film come l’ultimo di Sorrentino o di leggere un romanzo di Murakami Haruki, facciamo la singolare esperienza di sentirci come se ci fossimo concessi una pausa, una parentesi lieve, il tempo per predisporci all’attesa. Attesa che solo più tardi avrà a che fare con la parola, ma che ora qui nell’istante in cui siamo rapiti dalla visione o dalla lettura assume la forma patetica del predisporsi all’incontro mancato con noi stessi. Esperienza perturbante che solo le immagini ci permettono di fare, motivo per cui il cinema, l’arte e un certo tipo di letteratura sono luoghi privilegiati per quella che Didi-Huberman chiama conoscenza accidentale. Una conoscenza che più che ad avvicinarci all’oggetto della nostra ricerca ci permette piuttosto di aprirci alla trama segreta delle parole e delle immagini di cui disponiamo, là dove affondano le radici della nostra scrittura, di quel gesto a cui un giorno, del quale non abbiamo memoria, ci siamo irrevocabilmente votati.
Non ci sorprende allora che, dopo più di seicento pagine del suo ultimo romanzo, 1Q84, Murakami Haruki confessi per bocca di uno dei suoi personaggi che la vita, così come - aggiungiamo noi - la scrittura, prendano slancio dall’insegnamento che alcune immagini fondamentali impresse nella memoria sembrano voler impartire: “Perché un uomo possa vivere – afferma Tamaru pensando all’immagine di un suo amico d’infanzia che tenta di tirar fuori, intagliandolo, un topo da un blocco di legno - ha bisogno di queste immagini. Immagini che possiedono un significato che non si può spiegare a parole. Ecco, ognuno di noi vive per dare una spiegazione a quel qualcosa che le immagini tentano di insegnare”. Nella semplicità di queste parole ci sembra di scorgere il senso dell’intero romanzo, così come quello di un’intera ricerca attorno il problema dell’immagine come ce la propone sin dai suoi esordi l’opera di George Didi-Huberman.
A partire, infatti, dai suoi lavori più lontani nel tempo come L’invenzione dell’isteria, sino ad arrivare a quelli più recenti che troviamo tradotti in italiano, penso ai testi Come le lucciole. Una politica della sopravvivenza (2010)e La conoscenza accidentale. In Apparizione e sparizione delle immagini (2011), lo storico dell’arte e filosofo francese ci invita a riflettere sul rapporto complesso e irrisolto tra immagine e conoscenza. Cosa ci insegnano le immagini? Che tipo di episteme possiamo trarne dallo loro interrogazione? Ma soprattutto chi interroga chi: è il soggetto nella trascendenza del suo ego a porsi in maniera interrogativa di fronte all’immagine oppure, come sembra suggerirci Didi-Huberman che titola il suo libro in originale Phasmes (trad. it La conoscenza accidentale, Bollati Boringhieri, Torino 2011),sono invece le immagini nella loro autonomia di revenantes a venire a porci la loro domanda? Quella del filosofo francese diviene allora anche, sulla scorta di Benjamin, una proposta di metodo, un avanzare nella ricerca fatto di interruzioni, di contrattempi in cui lo studioso, scrive Didi-Huberman nella prefazione a La conoscenza accidentale, si prende il tempo per “saldare il debito con la generosità delle cose apparenti”. Mentre ciò che per un istante ci è sembrato di aver visto, nella sua dissomiglianza - scrive Didi-Huberman - dal mondo del visibile sino a quel momento percepito, si dissolve in un alone di incertezza epistemologica, la parola e con essa la scrittura comincia a prendere forma, in un corpo a corpo con il visto che si traduce nell’aforisma, nel frammento di testo, il cui stile non potrà che a sua volta riprodurre quello di un’apparizione.
Capiamo così la logica, se così possiamo definirla, con cui ne La conoscenza accidentale vengono pubblicati nello stesso volume saggi e brevi racconti, scritti in epoche differenti, a ricoprire un arco ventennale (anni 80 e 90) della produzione del filosofo francese. Ciò che sembrano avere in comune gli scritti proposti in questo testo, inizialmente raccolti dall’autore sotto la voce Fasmidi, non sono tanto dei temi o delle questioni di fondo, che volendo sarebbe anche possibile rintracciare, quanto piuttosto il fatto di far trasparire un’immagine fondamentale come rovescio della loro trama. Il lettore che si accosta a queste pagine sarà inutile che si affanni a cercare nella successione dei capitoli una progressione lineare del discorso o del pensiero. Dovrà piuttosto lasciarsi trascinare dal vortice in cui ogni singolo testo, nella sua autonomia rispetto agli altri, avrà saputo gettarlo, nella speranza di poter intravedere anche solo per un attimo una forma, un’apparizione, un phasme, a cui – possiamo affermare – Didi-Huberman ha saputo dedicare il suo sogno di studioso. Ed è alla tecnica freudiana dell’interpretazione dei sogni, infatti, che il filosofo ci rimanda nel suo accostarsi al visibile e al dicibile attraverso la presa in carico del dettaglio, che non dobbiamo confondere – avverte l’autore – con la “messa in dettaglio del mondo visibile” tipica di una certa critica dell’arte che si perde nella caccia agli indizi.
Quel che vale per i quadri di Tiziano o Chardin per cui “quando ci avviciniamo alle opere di questi pittori, il dettaglio scompare, “tutto si confonde”; e quando ce ne allontaniamo tutto si ricostituisce” assume tutto il suo senso all’interno di un tentativo di scrittura, che è anche quello dell’analisi freudiana, in cui il particolare non svolge il ruolo di elemento da identificare e da collocare all’interno di un sistema di riferimento più ampio. Ma si configura piuttosto come un luogo di incertezza epistemica in cui sprofondare, per fare esperienza della sua formazione, della sua plasticità composita, stratificata, del suo carattere di “esca per lo sguardo”, ossia di feticcio.
Sognare un dettaglio si traduce allora nell’opera di Didi-Huberman nel compito etico di dar luogo ad un pensiero e ad una scrittura in cui le parole più che destarci ci dispongono ad un dormiveglia favorevole all’insorgere delle immagini fondamentali. Immagini che hanno visto e che per questo ci mettono in contatto con quello che Pierre Fédida, a cui Didi-Huberman non smette di riferirsi, chiama il morto che c’è in noi. Il morto, o immagine perduta, riapparsa e di nuovo scomparsa, che ci fa scrivere, pensare, vivere. O che nel caso di Giacometti costringe ad una scultura che corrisponde ad una lotta lunga tutta una vita “contro l’impossibilità di afferrare l’esatta dimensione di ciò che diceva di vedere”. Un fantasma di perdita quello di Giacometti con cui il pensiero psicoanalitico da sempre ha fatto i suoi conti e che per quello filosofico – suggerisce Didi-Huberman - può rappresentare un’opportunità di confronto con cui cominciare a misurarsi.