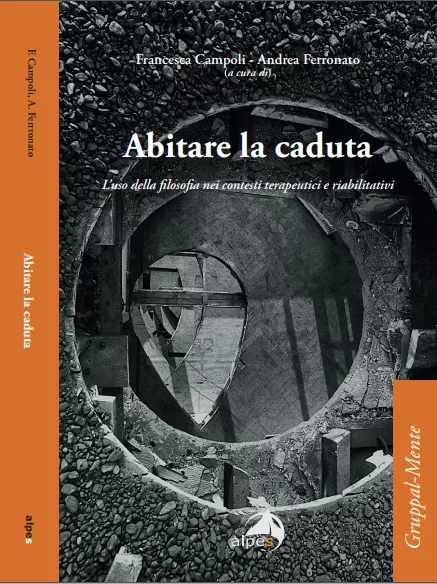Vedere il trauma / Abitare la caduta: una passeggiata tra le immagini
Con gli occhi, l’udito, i pensieri ancora tramortiti dall’eccesso che l’ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, porta con inaudita leggerezza sullo schermo, mi immergo nella lettura di un libro che già nel titolo, Abitare la caduta, fa da eco a un’urgenza che avverto immediatamente simile: quella di provare ad approssimarsi al trauma fuori da ogni retorica drammaturgica. In risonanza con un capolavoro filmico che sa fare della profondità un’arte delle superfici, dell’illusionismo che apre alla magia, ma anche del mostrare il rovescio grottesco del sacro, il libro che mi trovo innanzitutto a sfogliare assume la consistenza di un oggetto-baule, un’immagine-scatola la chiamerebbe Federico Leoni prendendo spunto dall’opera di Joseph Cornell, ossia da quella serie di oggetti raccattati e incorniciati l’uno accanto all’altro secondo una logica di volta in volta tutta da ricostruire après coup.
E gli oggetti contenuti in quello che è a sua volta un oggetto, un oggetto-libro, sono stralci di citazioni di riflessioni colte in presa viva, saggi di filosofi, psichiatri, psicoterapeuti, riflessioni teoriche e considerazioni tecniche, ma soprattutto immagini visive, sonore, reali e virtuali che provengono da un percorso laboratoriale che dei filosofi accompagnati da dei clinici hanno condotto all’interno di un centro diurno.
Come la memoria del film di Sorrentino ci obbliga a trattenere un’atmosfera composita che non è mai la stessa se anche solo uno degli elementi che la costituiscono viene meno – e così ci troviamo a sognare il corpo suadente di zia Patrizia senza poterlo distinguere dal monaciello, dal “tuff” intermittente dello scafo che solca immaginariamente il mare nelle parole trasognate di un contrabbandiere-marinaio, dal passo privo di incertezze di un Maradona inarrestabile persino dalla mano di Dio – allo stesso modo l’oggetto che mi sono poi ritrovata tra le mani chiedeva di essere attraversato tutto, in tutte le sue eterogenee voci e immagini, chiedeva tempo, quello di un ascolto e di uno sguardo disposti non tanto ad apprendere qualcosa ma a lasciarsi sommergere dall’eccesso di un’esperienza.
Esperienza che ha la grazia e la forza del gesto che, sebbene non sia cronologicamente il primo, a nostro avviso diventa quello inaugurale di questo percorso laboratoriale, ossia una passeggiata tra le immagini. Seguire la cronologia dei fatti, si sa che non consente di fare un buon servizio a quella che con un gergo analitico, ormai purtroppo consunto, chiamiamo elaborazione del trauma. Su questo Freud è molto chiaro, serve una seconda scena, un nuovo incontro perché se ne possa dire qualcosa di ciò che ne sarà stato del primo. E forse nel nostro caso è avvenuto che la visione del film sia arrivata soltanto dopo aver letto questo libro: una visione al futuro anteriore.
Un gesto allora, dicevamo, inaugura e illumina la scena su cui si consuma l’esperienza narrata. Un gesto molto affascinante. Il nostro accesso al libro si incunea lì, nell’immagine di un gruppo di individui, i pazienti frequentatori di un centro diurno, che resisi disponibili a fare un lavoro comune sul tema della caduta si aggirano in una stanza i cui tavoli sono cosparsi da immagini riprodotte su cartoncini. Camminano tra le immagini. Immagini che non hanno scelto, e che si trovano lì disposte da altri, selezionate da persone che non conoscono.

Passeggiano così con in testa un’unica consegna, che apparentemente potrebbe sembrare complessa da esaudire: scegliere un’immagine che in qualche misura rievochi una propria ‘caduta’. Ed è così che scopriamo che tempo dieci minuti ciascuno ha tra le mani la sua immagine. Immagine che da quel momento in poi diventerà il veicolo di un vero e proprio ruzzolare, un precipitare che a momenti appare rovinoso per poi ricostituirsi in una danza, in un balletto. Buster Keaton fa capolino da tutte le parti.
Come scrivono Andrea Ferronato e Francesca Campoli, i curatori del libro e del progetto, nonché i conduttori del laboratorio “le immagini usate richiedevano che lo sguardo aprisse un campo, piuttosto che focalizzarsi sugli specifici oggetti e contenuti rappresentati. Ciascuna fotografia ha permesso di ritrovare, rievocando la propria caduta, la presenza di un paesaggio in cui ogni evento, anche il più traumatico e intollerabile, ha luogo”. Aprire l’orizzonte e creare un panorama dell’evento: psicoanalisi e filosofia sembrano trovare qui il loro punto di incontro. La cifra di un discorso che sovverte le categorie del pensiero comune, per andare alla deriva del senso verso la costituzione di un paesaggio abitabile, dove il trauma viene scolpito dal didentro, dalle forme che imprime nello sguardo e nella parola.
Nella stanza in cui ciascuno tiene stretta la propria immagine, che per il senso comune dovrebbe parlare a lui e soltanto a lui della propria caduta, tutte le immagini invece cominciano a risuonare le une con le altre e le parole che da queste si strappano s’involano, cominciano a girare, non appartengono più a nessuno. Il filosofo, il paziente, la psicoanalista, sono solo funzioni, o personaggi concettuali che non si sa più a chi appartengano, si sa solo che circolano e producono effetti di sorpresa. Sottolineano con puntualità i curatori del libro a proposito delle riflessioni di uno dei partecipanti: “il pensiero che segue è molto particolare: ciò che lo caratterizza e che ci colpisce è il passaggio senza soluzione di continuità dalla terza alla prima persona. È come se, inizialmente Pierpaolo volesse mantenere il racconto più neutro possibile (“se una persona…”), ma non riuscendovi fosse costretto a passare alla prima persona (“sono sempre stato messo da parte...”), facendo anche riferimento alla propria immagine. Il suo intervento si conclude infine introducendo una forma impersonale, ovvero né completamente neutrale, né completamente ancorata a sé (“Allora scoprendoti…”) che esprime piuttosto un passaggio continuo e reciproco tra svelamento e rivelazione del sé, un’apertura a ciò che di quel vissuto costituisce una tensione comune”.
Ma la sorpresa forse più grande per chi ha preso parte a questo lavoro, come sottolineano Ferronato e Campoli, non è stata tanto quella di mostrare la dimensione comune del trauma, quanto piuttosto osservare che esiste un punto cieco sia nel trauma che nell’immagine che i partecipanti hanno scelto per evocarlo. Attraverso le parole che le fotografie hanno consentito di mettere in circolazione ciò che si è prodotto non è stata la riappropriazione del contenuto di ricordi perduti, ma una ritramazione dell’evento doloroso – Freud la chiamerebbe ricostruzione – rivelativa dell’inappropriabilità della memoria del trauma.
È lo sguardo di Sorrentino che non può uscire da Napoli, nemmeno quando apparentemente lo fa, non può seguire le orme del maestro Capuano, può solo rimanere fedele a ciò che non gli hanno permesso di vedere (“non me li hanno fatti vedere”), a ciò che se anche avesse visto non avrebbe potuto vedere: la morte del padre e della madre.
L’immagine ha una doppia forza ci dicono Ferronato e Campoli, da una parte è espansiva, germinativa, dall’altra può anche ritirarsi tutta su un punto, che Barthes chiamava punctum, e che gli autori ci invitano a pensare come coestensivo a tutta la superficie dell’immagine ritratta sulla punta di uno spillo, che “non si identifica né con il soggetto dell’immagine, né con un’intenzione celata in qualche dettaglio; indica un’assenza del tutto evidente ma totalmente singolare”.
Quest’assenza una volta narrata può assumere – e nel laboratorio è accaduto – la consistenza di un amico, di un maestro, di un genitore morto, ossia delle spoglie di un lutto che ha rappresentato anche l’inizio di una nuova vita. Anche in questo Sorrentino è preciso: è la perdita dei genitori a informare l’occhio e ad elevarlo allo statuto di sguardo, di oggetto pulsionale. Quello sguardo che da ragazzino aveva indugiato sulle forme dell’avvenente zia Patrizia, figura a metà strada tra la Ninfa di Warburg e una fattucchiera, e che ne era rimasto turbato, invischiato, al punto da precipitarvi dentro con una fiducia senza remore, come l’occhio di Charcot alla Salpêtrière convinto che davanti a lui quello che si manifestava attraverso quei corpi di donna era qualcosa dell’ordine della verità.
“Zia, io quella volta ti ho creduta”, sono le parole con cui dal ragazzino turbato sorge l’occhio incantato del regista che non può smettere di vedere ciò in cui ha creduto. In psicoanalisi questa è la grande lezione del fantasma: qualcuno un giorno avrà visto qualcosa che non si poteva vedere, in cui ha così profondamente creduto da consegnare ai suoi maneggi un’intera esistenza.