Lazzarato: il rifiuto del lavoro
«Io non ho deciso di andare all'estero, come fanno oggi tanti giovani della tua età. Io sono scappato all'estero perché avevo un mandato di cattura. Ero un militante di Autonomia Operaia, che è stata una grande esperienza politica, anche se minoritoria, del processo di trasmissione dalla vecchia composizione di classe alla nuova. Non ci pensavo proprio, io, al futuro. Una volta arrivato in Francia mi sono rimesso a studiare. Ma sono precario ancora adesso.»
Maurizio Lazzarato, filosofo e sociologo indipendente, vive in Francia dal 1982 e in Italia ci viene raramente. Domenica 13 aprile era a Milano, a Macao, per partecipare al seminario Fare Pubblici. Nell'intervallo tra il panel della mattina e quello pomeridiano, tra una sigaretta e l'altra, si lascia intervistare per Doppiozero. A partire dal suo ultimo libro, Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro (Edizioni Temporale).
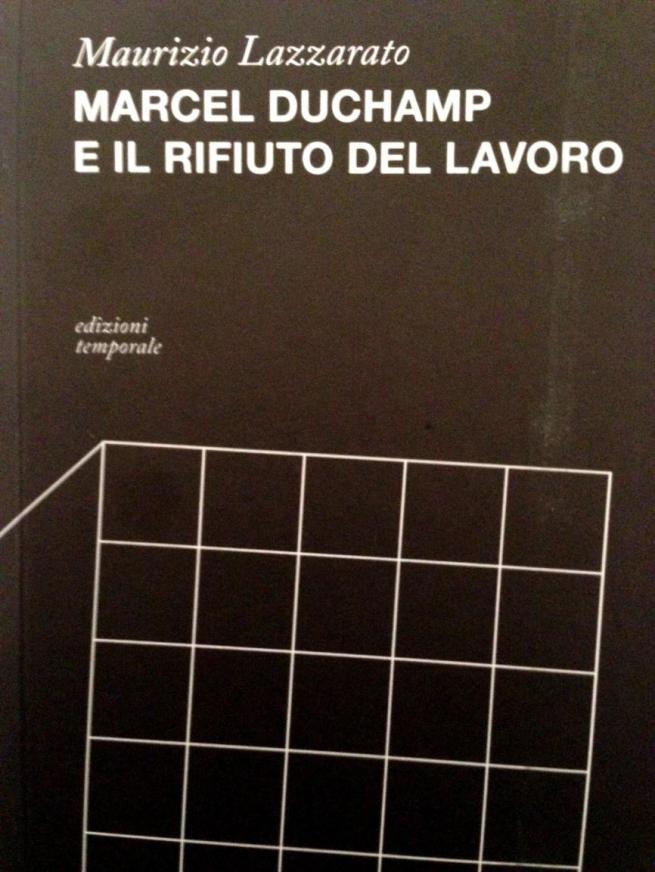
Nel tuo ultimo libro, scrivi: per Duchamp «il rifiuto del lavoro artistico significa rifiuto di produrre per il mercato». Ma al di fuori del mercato, esiste un metro per dare un riconoscimento materiale al lavoro immateriale?
Quella di Duchamp è senza dubbio un'esperienza molto particolare. Il mercato dell'arte come lo conosciamo oggi non si era ancora affermato, diciamo così. E lui aveva scelto di starne ai margini. A portarlo nel mercato furono le avanguardie degli anni '60, e fu Schwartz, un gallerista milanese, a compiere questa operazione. L'opera di Duchamp fino a quel momento non era passata per il mercato, era un'opera nascosta. Era poco conosciuto negli Stati Uniti, sconosciuto in Europa, ed è entrato nel mercato dell'arte solo in un secondo momento. Il ready made, per esempio, prima non era mai stato esposto. Erano cose sue, private. Solo una volta, era stato esposto il... pissoir, come si dice in italiano?
Pisciatoio.
Ecco. Quella di Duchamp è una situazione particolare. Oggi appare improponibile. Ma del resto lui stesso dice che il problema è essere al limite: tra lo stare dentro l'arte, dentro il mercato dell'arte, e lo starne fuori. In un'intervista lui stesso riconosce che se avesse abbandonato completamente l'arte, come hanno fatto molti artisti negli anni '60 e '70, che hanno lasciato il mondo dell'arte definitivamente, con una critica severa... questi sono stati completamente dimenticati. Duchamp resta al limite, in maniera qualche volta anche ambigua. Nello stesso tempo, però, il rifiuto del lavoro che applica, un rifiuto sia verso il lavoro in generale, sia verso il lavoro artistico, mi sembra molto interessante. Certo, ci sono delle condizioni materiali. Duchamp aveva una piccola rendita, era aiutato da alcuni ricchi borghesi, e gli ultimi anni della sua vita ha avuto un po' di denaro in tasca. Però prima ha vissuto... non gli interessava molto questo aspetto. Mi sembrava che questa sua caratteristica fosse interessante rispetto a quello che sta succedendo oggi, nel mondo del lavoro. Anche se, ripeto: il rifiuto del lavoro, una strategia del genere, oggi, in quanto tale, è difficilmente riproponibile.
Mi chiedo: rifiutare il lavoro in un momento in cui la disoccupazione a livello europeo è al 12%, in Italia al 13% e quella giovanile è arrivata al 42%, non rischia di suonare quantomeno fuori luogo?
Sì, ma bisogna distinguere tra lavoro e impiego. Non sono la stessa cosa. Dal mio punto di vista, la questione è molto semplice: si lavora spesso – come tu stai facendo in questo preciso momento – ma si viene pagati molto raramente! Il problema non è lavorare, ma farsi pagare. Si lavora, anche su cose che possono essere più o meno interessanti, però... essere impiegati, cioè far corrispondere a questo lavoro un salario, o un reddito, beh, è molto più difficile. Quello che manca non è il lavoro, quello che manca è l'impiego. Lavoro ce n'è troppo. Si fa troppo lavoro gratuito, come quello che stai facendo tu adesso [ride]. Il problema è che ci fanno lavorare sempre di più, ma sempre più gratuitamente. È la logica del sistema, ed è una cosa molto strana, perché da un certo punto di vista sei costretto a farlo. È un lavoro che ti interessa, che ti piace... e allora in un certo senso trovi una giustificazione al fatto che fai qualcosa che ti piace. Però, di per sé, è un tipo di sfruttamento come un altro, forse anche più di un altro, perché non c'è nessuno che te lo impone veramente. C'è un dispositivo che te lo impone, se vuoi, quello dell'economia neoliberale. Però, è come se fossi tu a scegliere questa situazione. È un fatto molto complicato, perché la messa in discussione di questo tipo di relazione implica la messa in discussione di te stesso. L'esperienza di Duchamp è interessante, perché lui non aveva un padrone. Come te, anche tu non hai un padrone. Ma sei preso da una serie di dispositivi, che ti obbligano, da un certo punto di vista, anche se non ne sei perfettamente cosciente...

Quindi, secondo te, non essendo pagato per fare questa intervista, io avrei dovuto rifiutare di farla. Stai dicendo questo?
[ride] Ma no, non so... probabilmente no. Il problema è che una volta questi erano i lavori che si facevano per uno, due, massimo tre anni. Invece adesso è diventata la prospettiva di una vita intera. Cioè, tu devi fare il precario, lavorare un casino, fare cinque interviste e te ne pagano una sola.
Una condizione che riguarda in particolare il lavoro culturale, o il lavoro in generale?
No, riguarda il lavoro in generale. Ma in particolare il lavoro culturale. Che dovrebbe rendersi conto di essere giunto a un livello di proletarizzazione e sfruttamento abbastanza rilevante. Le condizioni, i sistemi di concorrenza... Questi meccanismi stanno andando avanti da anni, però: prima o poi i lavoratori culturali dovranno dire "no" a questo tipo di situazione. Prima o poi, delle forme di rifiuto si dovranno esprimere. E poi c'è un altro problema: dagli anni '70 ad oggi, la ricchezza prodotta dai paesi occidentali in cui viviamo è raddoppiata. Dove cazzo è finita?
La crescita, parola magica del nostro tempo, è stata una crescita delle diseguaglianze: è questo che intendi?
La crescita si dà come crescita diseguale. Per cui, se ci sarà una nuova crescita, non risolverà la cause della crisi. Le riprodurrà di nuovo. Non dobbiamo dimenticare che la crisi che stiamo vivendo è diseguale per definizione: la redistribuzione della ricchezza, durante la crisi, è avvenuta e sta avvenendo a tutto vantaggio della rendita.
Crisi e diseguaglianze sembrano aver trovato una giustificazione in quella che, citando il titolo di un altro dei tuoi libri, si potrebbe definire l'ideologia dell'«uomo indebitato». In cosa consiste?
Diciamo così: l'economia neoliberale, da quando si è imposta alla fine degli anni '70, è un'economia del credito. È tutta organizzata sul mercato finanziario. Il credito, se lo leggi dall'altra parte, è debito. Ma porta in sé stesso una promessa di futuro. Perché chi accede al credito lo fa per poter realizzare dei progetti, per comprare qualcosa, per mettere in piedi un'attività, c'è un'apertura verso il futuro. Questo sistema è andato incontro a un rovesciamento. A partire dal 2007/2008, il credito si è rovesciato in debito. Perché il credito funziona solo se il sistema è continuamente in espansione. Se la riproduzione allargata prolifera, tutto bene. Se si blocca, il credito si rovescia in debito. Improvvisamente l'orizzonte si è chiuso. E la finanza non è stata più in grado di mantenere quella promessa.
Che cos'è per te la finanza?
In fondo, la finanza e il credito sono un tentativo di controllare il futuro. L'economia finanziaria è un'economia che è interamente diretta verso il futuro, perché è fatta di investimenti che vanno realizzati nel futuro. Il futuro, però, per definizione é indeterminato e imprevedibile. Quindi, il problema diventa come neutralizzare questa imprevedibilità. Da un certo punto di vista, la finanza è un tentativo di bloccare il tempo, di togliere al tempo l'imprevedibilità. Di bloccarlo anche come creatività. Bisogna cercare di anticipare i comportamenti futuri, e paradossalmente l'effetto è quella strana sensazione di vivere in una società senza tempo, senza autentiche possibilità, senza futuro. E' una contraddizione: il credito dovrebbe aprire delle possibilità. Allo stesso tempo, però, per assicurare il ritorno dell'investimento occorre neutralizzare il rischio. Scaricandolo su una molteplicità di attori, ma senza eliminarlo. La crisi dei mutui subprime lo dimostra. La distribuzione del rischio è diventata un'infezione, ed è stata scaricata sulle popolazioni. Cioè su chi non aveva la responsabilità di aver assunto quel rischio. E' un meccanismo delirante, però il capitalismo è così. Il capitalismo, da un certo punto di vista, è un delirio. Non è una razionalità.
L'uomo indebitato come fa a uscire da questo delirio?
L'ideologia dell'uomo indebitato è un tentativo di colpevolizzare le popolazioni. Che secondo me, però, non ha funzionato. L'ideologia dell'uomo indebitato dice: lavorate troppo poco, andate in pensione troppo presto, vi curate troppo bene... Ma non è un'ideologia convincente, dal mio punto di vista. L'unica possibile via d'uscita è politica, ma per il momento non si vede quale possa essere. Tanto per cominciare, si potrebbe dire che il problema non è il costo del lavoro, ma il costo della rendita. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il debito è un meccanismo per catturare la ricchezza sociale e trasferirla alla rendita. Che poi il debito sia servito anche a finanziare i servizi sociali, la sanità, le pensioni... questo si sarebbe potuto fare comunque, perché dagli anni '70 ad oggi la ricchezza è raddoppiata. Che fine ha fatto questa ricchezza?
Neutralizzare la rendita, realizzare «l'eutanasia del rentier» di cui scriveva Keynes, sono soluzioni praticabili oggi?
Non si può più fare, perché il capitalismo attuale è integralmente finanziarizzato. Mentre nel capitalismo degli anni di Keynes c'era ancora una non identificazione tra capitale industriale e capitale finanziario, oggi non è più così. Neutralizzare la finanza oggi significa neutralizzare il capitalismo. E quindi, da un certo punto di vista, il capitalismo non ha alternative all'austerity in Europa, e alle continue iniezioni di liquidità negli Stati Uniti e in Giappone. Ma continuare così finirà per creare altre bolle.
E il reddito di cittadinanza?
Io sono d'accordo col reddito di cittadinanza, ma per ottenerlo ci vogliono dei rapporti di forza che non ci sono. Occorre ricreare dei rapporti di forza, delle forme di resistenza e di auto-organizzazione che ricordino le classi. Non sarà più la classe operaia, ma se non si ricostruisce questo tipo di rapporto di forza, non vedo come sia possibile ottenere il reddito di cittadinanza. Se tutti continuano a lavorare gratis, perché qualcuno a un certo punto ti dovrebbe pagare? Se non si trovano delle forme di organizzazione, come hanno fatto i lavoratori fino alla generazione di mio padre, che non erano "cognitivi" però erano un po' più intelligenti [ride]. La generazione di mio padre ha guadagnato dei diritti, ha combattuto per averli. E noi li stiamo perdendo uno ad uno, pur essendo "cognitivi", formati, eccetera eccetera. Non è la "cognizione" che determina la politica, non so come dire. Come si fa ad organizzarsi con gli altri? Questa è la difficoltà da superare, per imporre dei rapporti di forza e conquistare il diritto di discutere, anche di reddito di cittadinanza. L'uscita dalla crisi ci sarà, dal mio punto di vista, solo quando ci sarà la possibilità di ricomporre e organizzare un conflitto reale. La situazione al momento è ancora troppo asimmetrica, il rapporto di forza è ancora troppo sfavorevole. Nonostante la crisi e anzi, anche dentro la crisi. Come organizzare la molteplicità dei soggetti sfruttati, dei precari, dei più-o-meno-precari, più-o-meno-garantiti, in una lotta dualistica contro il capitale? Questo è il problema.









