Ricordo di un poeta / Scarabicchi, la miniera della interiorità
È difficile scrivere di un amico fraterno che scompare; e per questo è per me difficile parlare ora di Francesco Scarabicchi, che si è spento pochi giorni fa, dopo aver affrontato con straordinario coraggio una lunga e atroce malattia, durata anni. Forse sarebbe meglio tacere, affidandosi soltanto a due versi del suo amatissimo Antonio Machado, in una delle Galeries che Francesco aveva tradotto splendidamente: «Oggi soltanto lacrime / per piangere. Non c’è che piangere, silenzio!» (le traduzioni da Machado erano apparse dapprima, con il titolo Il seminatore di stelle, per le edizioni Sestante, di Ripatransone; poi, insieme a quelle da Garcia Lorca, nel volume Non domandarmi nulla, edito da Marcos y Marcos nel 2015).
Ma Francesco aveva una concezione sacra, quasi omerica dell’amicizia, che occupava i vertici del suo mondo; e per tentare di rimanere fedele a quell’amicizia, dirò che la prima parola che mi viene in mente, pensando a lui, è: intensità. L’intensità, tanto dei rapporti umani quanto della ricerca espressiva, era la caratteristica immediatamente ravvisabile in Francesco, nello sguardo, nella parola, nei modi, e naturalmente nella scrittura. Non c’era spazio, accostandolo, per le schermaglie, per le buone maniere prive di sostanza: tutto era ricondotto subito e costantemente al nucleo più bruciante dell’essere, alla necessità di confrontarsi intimamente su ciò che conta davvero, su ciò che non può essere rinviato, su ciò che attrae e ustiona. Ho cercato di ricostruire il nostro primo incontro: è avvenuto a Fano, nel settembre del 1987, in occasione di un “convegno poetico” intitolato “Poesia dell’Europa latina” a cui entrambi, assai giovani, eravamo stati invitati. Due mesi dopo si sarebbe tolto la vita Remo Pagnanelli, che allora non conoscevo, e che non so se ho incontrato in quelle strane giornate di cui ricordo poco, come non so se ho conosciuto in quella circostanza Ferruccio Benzoni, che forse c’era. Ricordo solo una grande sala, un palco su cui si avvicendavano un numero sterminato di poeti e aspiranti poeti; la figura di Franco Scataglini, che di Francesco, ma l’avrei saputo dopo, era il maestro; e, accanto a me, un giovane barbuto, dallo sguardo inquieto e quasi febbrile, con cui avrei parlato un po’, e che avrei incontrato ancora più tardi, rientrando in non so quale albergo, su un ponticello dove saremmo rimasti a lungo a parlare. Era appunto Francesco Scarabicchi, che prima non conoscevo e che non avevo ancora letto; ma che da quella sera avrebbe avuto una parte importantissima nella mia vita e nella mia riflessione. Ricordo anche un’altra cosa: la sensazione, condivisa con quel mio quasi coetaneo, di sentirci fuori posto, in imbarazzo di fronte a quella situazione troppo vasta, quasi triviale: ai margini, sbagliati, in cerca di qualcosa che non era lì.
Francesco aveva pubblicato cinque anni prima La porta murata (Residenza, Ancona, 1982), il suo libro d’esordio che era stato amato da Caproni e che doveva vincere il premio Viareggio Opera Prima, poi sottrattogli in modo meschino. Io avrei letto quel libro solo qualche mese dopo, su consiglio di Massimo Raffaeli, un altro grande amico marchigiano, che di Francesco è stato il primo, il più profondo accompagnatore nei labirinti oscuri del mondo, e forse si potrebbe dire la principale e più fedele coscienza critica. Nello stesso 1987, presso le bresciane edizioni L’Obliquo, sarebbe anche apparso Il prato bianco, e due anni dopo il grande libro Il viale d’inverno; opere poi confluite nell’autoantologia del 2001 Il cancello, edita da peQuod. Sin dalla raccolta d’esordio e dal suo titolo emblematico, appare con forza il cuore profondo della poesia di Scarabicchi: il tema dell’assenza, per cominciare, originato prima di tutto dal trauma fondativo della sua personalità umana e poetica, la perdita del padre in età infantile. L’assenza, la porta che non c’è più e da cui non si potrà mai passare, la chiusura dell’orizzonte (e, nella concretezza biografica, la necessità imperiosa di impiegarsi presto, senza poter seguire gli studi che si sarebbe desiderato ardentemente compiere), la costante coscienza della precarietà di ogni cosa: questo è il basso continuo che informa la poesia.
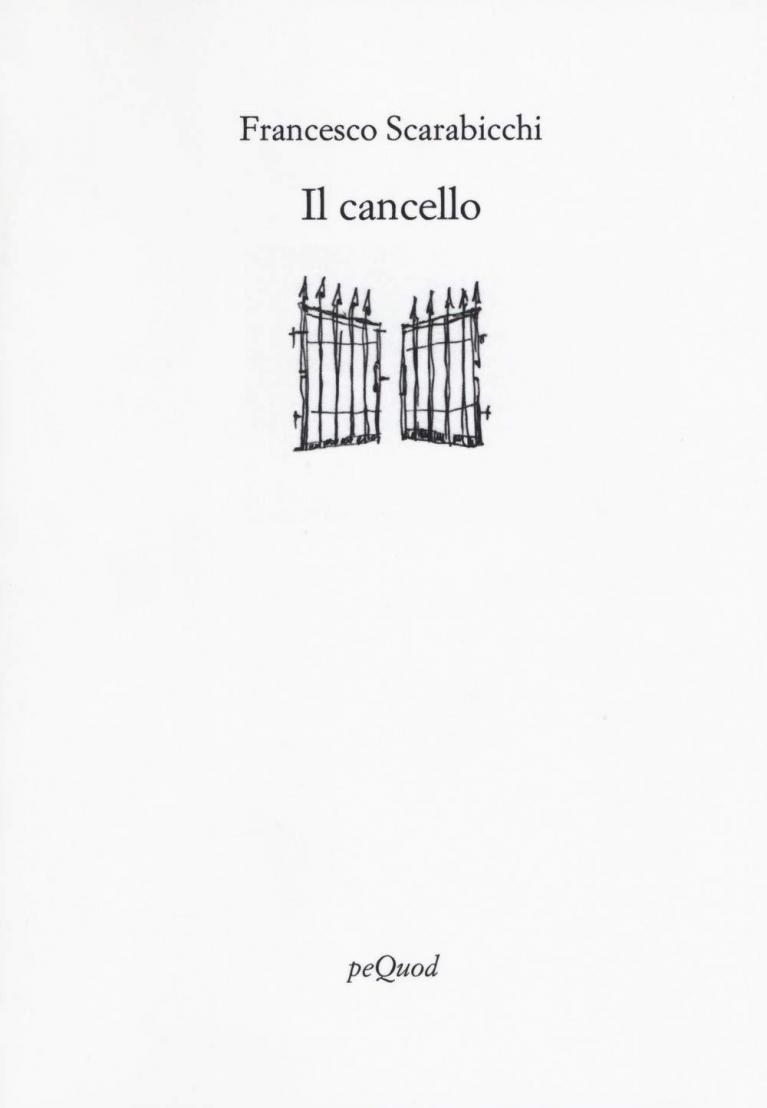
Ma l’acuta percezione dell’assenza si trasforma immediatamente, quasi con un gioco di parole, nella febbrile ricerca di ciò che conta davvero, di ciò che resta e sa opporsi alla dissoluzione del tutto: cioè dell’essenza della vita e delle cose, delle persone e degli oggetti. Intanto la vita di Francesco scorreva, accanto a Liana, sua moglie; scompariva anche la madre, e nasceva la prima figlia, Chiara, cui anni dopo si sarebbe aggiunto Giacomo; la famiglia e i suoi affetti radicatissimi, felici e faticosi insieme, occupavano infatti un posto più che centrale nell’esistenza di Francesco, e anche nella nostra amicizia, ora a distanza ora propiziata da visite, incontri, vacanze familiari fatte insieme (ad Ancona, nell’entroterra marchigiano, nel Gargano o in Abruzzo) e passeggiate lungo i laghi e sulle montagne svizzere.
E tuttavia, accanto a questa realtà importantissima e solare, ardeva in Francesco il fuoco segreto della poesia, che lo spingeva regolarmente a scendere in miniera (così si esprimeva in una lettera; e un’espressione simile avrei poi incontrato in un passo di Giorgio Caproni), a scavare negli strati di profondità dell’esperienza, alla ricerca di minerali dolorosi e preziosi. La difficile miniera dell’interiorità, della meditazione sull’essere: questo era il territorio in cui il poeta voleva e doveva immergersi, lungo una tradizione novecentesca che passava dal maestro in presenza, Scataglini, a quello più distante e presto scomparso, Caproni, all’archetipo di questa concezione della poesia, Umberto Saba; più indietro, il grande paesaggio di Leopardi. Queste coordinate culturali, per quanto sommarie, aiutano anche a capire l’originalità della scelta stilistica di Scarabicchi, messa a punto sin dall’inizio e poi caparbiamante affinata, sviluppata, ma senza ripensamenti o smagliature: versi brevi, orientati soprattutto attorno al leggero ticchettio del settenario, strofe controllatissime, che cercano il ritmo e la musica proprio mentre mettono davanti la coscienza della perdita, della vertigine, lessico e sintassi a loro volta distillati con cura, senza concedere nulla all’esibizione sperimentale, prediligendo un tono medio, con qualche venatura preziosa e talvolta qualche frammento di parlato o persino di dialetto (quello napoletano, dell’amato Di Giacomo, non quello anconetano). Era stupefacente, per chi conosceva bene Francesco, osservare la distanza apparente tra la sua straordinaria capacità affabulatoria e imitativa (era bravissimo ad assumere le cadenze dei più svariati italiani regionali, facendo ridere i suoi ascoltatori; ed era un eccezionale narratore orale, di cose minime o di grandi ragionamenti) e la trattenutissima parola poetica. Ma quest’ultima nasceva da una distillazione lunghissima e meticolosa; e si potrebbe dire che il nitore formale che la caratterizzava era appunto lo scrigno necessario per questa lenta brunitura dell’espressione, l’alambicco attrarverso cui la parola doveva procedere verso la trasparenza e la concentrazione massima.
Tutta la prima parte della storia poetica di Scarabicchi, cioè gli anni che vanno dalla prima giovinezza all’antologia del 2003, si è svolta nella marginalità editoriale e geografica, insieme scelta e subita. Scelta, coscientemente, per fedeltà a un’idea di “residenza” nata molto anni prima nel sodalizio tra Scataglini e alcuni giovani autori marchigiani (Massimo Raffaeli, Gianni D’Elia, e più tardi Claudio Piersanti): l’idea di non cedere alla tradizionale diaspora, di non abbandonare il territorio; di abitarlo, piuttosto, intensamente, come si abita la parola, e così facendo di trasformarlo in centralità. E quell’idea, che si era originariamente concretizzata in una notevole trasmissione radiofonica, avrebbe appunto guidato Francesco per tutta la vita, sostenuto da alcuni piccoli, ammirevoli editori, tra cui spicca soprattutto il già nominato L’obliquo, dell’amico artista Giorgio Bertelli, presso cui Francesco ha pubblicato non pochi libretti preziosi. Ma nello stesso tempo la marginalità, fisica e editoriale, è faticosa, quando gli anni trascorrono e la propria opera sembra rimanere costantemente nell’ombra, poco considerata rispetto a quella di chi sembra capace (ma a che prezzo?) di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, di occupare i posti migliori privo di dubbi, di ombre, di scrupoli. Di queste cose si parlava spesso, con Francesco, in quei lunghi anni fine secolo; sempre per via dell’amicizia profonda, e forse anche perché quei concetti di margini, di residenza e di esilio, di rapporti contradditori con i luoghi in cui vivevamo, ci affratellavano. Una visibile amarezza, mai tinta di invidia o di risentimento, ha a lungo accompagnato la ricerca di Francesco, che ciononostante non ha mai abbandonato il suo modo di essere e di scrivere e non è mai sceso a compromessi con se stesso o con gli altri. Una volta mi aveva detto con la sua ironia: «Vedi Fabio, noi vorremmo tanto che qualcuno ci desse la patente; ma non c’è nessun ufficio che possa farlo». La patente di poeti, intendeva dire: quella che molti pensano di avere e che pochi davvero possiedono.
Poi, in anni più recenti, le cose sono fortunatamente cambiate: l’accoglienza e il sostegno trovato presso un editore finalmente importante come Donzelli (presso cui sono apparsi L’esperienza della neve nel 2003, e L’ora felice nel 2010), la fortuna di un libro miracoloso come Con ogni mio saper e diligentia, che traduce in stanze poetiche l’antichissima ammirazione per un artista a sua volta drammaticamente marginale, come Lorenzo Lotto (molto si potrebbe e si dovrebbe aggiungere sullo stretto legame tra Scarabicchi e gli artisti, del passato come Lotto e del presente, come Valeriano Trubbiani, Ezio Bartocci, Giorgio Bertelli e molti altri); e infine la ripubblicazione di quel Prato bianco, apparso e quasi subito scomparso tanti anni prima, e ora accolto nella collana bianca di Einaudi, tutto questo avrebbe mostrato come l’opera di Scarabicchi non sia affatto trascurabile, e si collochi anzi tra le maggiori del nostro tempo. È questa la zona più nota dell’opera di Scarabicchi, su cui non è ora il caso di insistere. Ma, purtroppo, gli anni del tardivo successo pubblico coincidono con l’apparizione della malattia, che avrebbe accompagnato Francesco durante l’ultimo decennio; ammirevolmente sorretto e assistito dall’infaticabile Liana, il poeta non si è però affatto rassegnato al male e fino a quando le condizioni fisiche l’hanno concesso, ha continuato a lavorare, a scrivere, a progettare.
Non con la malattia e con le sue tinte oscure vorrei però concludere questro troppo breve ricordo di un amico meraviglioso e di un poeta ammirevole; ma con la forza e la luce che si incontrano nella sua opera e che ci accompagneranno nel futuro che ci rimane. Tra i molti grandi autori europei letti e amati da Francesco Scarabicchi c’era anche un poeta che ci accomunava ulteriormente, Philippe Jaccottet, che Francesco aveva insistito per invitare ad Ancona venticinque anni fa, nell’estate del 1995, in una serata memorabile (era arrivato in extremis Vanni Scheiwiller, con la sua solita borsa gonfia di libri, per portare fisicamente a quella lettura il Libretto italiano di Jaccottet fresco di stampa; c’erano Daniele Garbuglia, Claudio Piersanti, Emmanuela Tandello, e naturalmente Massimo Raffaeli; e c’erano le nostre famiglie, i nostri amici) conclusa sul Conero, davanti a un bicchiere di vino. E proprio in una poesia di Jaccottet, che a sua volta se n’è andato in questi mesi, trovo i versi che vorrei dedicare ora a Francesco:
rimani come modello di pazienza e di sorriso
simile al sole sulla nostra schiena ancora
che rischiara la tavola e la pagina e l’uva.









