Una radiografia permanente / L'Immagine fantasma di Hervé Guibert
Da dove viene il bagliore che regna in L'immagine fantasma, libro di Hervé Guibert pubblicato per la prima volta da Les Editions de Minuit nel 1981?
Una luce improvvisa e diffusa, di una trasparenza sorprendente che colma tutti gli angoli, un riflesso in grado di impregnare lo spazio della narrazione dandoci l'estro di poterlo percorrere attraverso sensi nuovi. Ma cos'è l'Immagine fantasma? Un diario? Un reportage? Una raccolta di testi teorici sulla fotografia? Quello che ci viene raccontato è l'intimità più profonda e la ricerca, la messa a fuoco di quell'intimità, la rotta per attingere a un'esperienza interiore attraverso la scrittura, i suoi misteri e i suoi riti con i quali Guibert si mette continuamente alla prova.
Come si sa, la sua opera sfugge a ogni facile classificazione di genere: diari di viaggi e pellegrinaggi, testi teatrali, recensioni di film o fotografie, autobiografie, dialoghi ossessivi, raccolte e inventari di memorie e un unico film, La Pudeur ou l'Impudeur, realizzato tra il 1990 e il 1991. Si ha spesso l'impressione che Guibert non abbia voluto scrivere romanzi, racconti o poesie, lettere d'amore. Certo, perché lui voleva scrivere storie nella maniera più diretta possibile, fuori dai generi, dalle antologie dove rifiuta di ritrovare il suo posto.

Fotografia di Hervé Guibert.
Nessun trucco o gioco di prestigio, nessuna possibilità di barare. Come con la fotografia. Nel suo primo libro, La mort propagande, Guibert dice che «il suo corpo per effetto del piacere o del dolore, si ritrova sempre in uno stato di teatralità, di parossismo, che mi piacerebbe riprodurre in qualche modo: attraverso la fotografia, un film, una colonna sonora».
C'è qualcosa di magico in quello che scrive. Come un imbalsamatore ha trasformato il suo corpo in un calco mortuario. L'ha messo in scena meticolosamente studiando ogni secrezione, contrazione; una marea che ha esposto su un tavolo operatorio per poi essere schedata e analizzata.
Aspirazione non molto diversa da quella di Francis Ponge, che in Il partito preso delle cose si augurava «che l’uomo mettesse la sua cura a crearsi nelle generazioni una dimora non molto più grande del suo corpo, che tutte le sue fantasie, le sue ragioni, vi fossero comprese, che usasse il suo genio per l’adattamento, non per la disproporzione – o, per lo meno, che il genio riconoscesse a se stesso i limiti del corpo che lo sopporta».
In quegli anni Guibert ha la fissazione per l'arte anatomica. Viaggia moltissimo per soddisfare quella mania, quella “ossessione estetica, da voyeur”. Compie sempre lo stesso rituale segreto perdendosi nei corridoi bui di qualche museo, e più di una volta, rischia di farsi sbattere fuori dai custodi. Va al Musée Grévin per ammirare certi corpi smembrati; poi al museo di antropologia di Firenze con i suoi totem, falli, divinità mascherate ed ex-voto. Vede gli intestini in formalina, le riproduzioni dei fegati di animali selvatici e le collezioni teratologiche del Musée Fragonard. Racconta tutto in Vice, testo in cui erano state incluse alcune sue fotografie, scattate tutte durante quelle visite, di occhi chiusi che si ritraggono, corpi senza testa e teste senza corpi, calchi di mani, vasi sanguigni e un suo drammatico autoritratto in un museo delle cere. In questi luoghi l'atmosfera è malsana, penosa, sembra di sentire un cattivo odore. Sicuramente il fascino per queste reliquie provenienti da altre epoche gli permetteva di osservare gli effetti della morte su un corpo, su una faccia, dimostrando quanto i tratti apparissero più definiti «dando stabilità a ciò che la vita rendeva incerto». Difficile dire quale parte del corpo non sia stata messa a fuoco dalla sua Rollei 35 per costituire una collezione di scatti dove dominano le forze del vizio e del desiderio. Alcuni intenditori potranno usare quelle fotografie a loro piacimento in attesa che qualcun altro venga e onori la loro immaginazione. Sembra proprio che Guibert volesse offrire ai suoi lettori un servizio pubblico di piacere.

Una curiosa coincidenza vuole che un secolo esatto separi la vita dell'artista francese da quella del poeta Arthur Rimbaud. Testimoni della fine di un secolo in crisi, entrambi adolescenti ribelli che sognano Parigi. All'inizio degli anni Settanta Guibert riesce ad affittare un piccolo alloggio vicino a Rue de Vaugirard, a cavallo tra il VI e il XV arrondissement, disubbidendo al volere dei suoi genitori. È vicino di casa di Michel Foucault – per lui sempre Muzil – suo amico e mentore, proprio come Verlaine per Rimbaud. Quando Foucault scopre di essere affetto da una malattia terribile e brutale, Guibert prova a «tendere col pensiero reti invisibili fino alla sua finestra» per cercare di salvarlo dalla sua depressione; ignora quale fosse il suo male ma comprende, dalla sua voce al telefono, che è grande. Solo in un secondo momento, scopre che Foucault non aveva mai confidato a nessuno la sua malattia, tranne a lui.
In quel periodo Guibert, diventa collaboratore della rivista per adolescenti 20 ans, occupandosi della Posta del cuore e rispondendo alle lettere, talvolta banali, di giovani lettori in crisi. Successivamente il lavoro per alcuni giornali come Cinéma, Les Nouvelles littéraires, Combat e Le Monde lo aiutano a fare amicizia con alcune delle sue confidenti come I. (Isabelle Adjani) e Gina Lollobrigida. Sono giorni selvaggi. Scrive, vede gli amici, scatta fotografie prima a loro e poi a se stesso. Ha l'abitudine di tenere in dispensa una bottiglia di champagne e un rullino di pellicola Tri X nel caso avesse incontrato un ragazzo carino pronto ad accettare un invito nel suo appartamento. Non succederà mai anche se Guibert, con i suoi riccioli biondi e gli occhi grandi, assomiglia davvero a una star del cinema.
La scrittura e la fotografia sono le sue ossessioni. È nel 1976 che comincia a tenere un diario. Molti anni dopo gli viene chiesto quale fosse il legame tra il diario e i suoi libri: «un legame decisivo» risponde. «I miei libri sono le appendici e il diario è la colonna vertebrale, l'essenziale». Scrive delle sue relazioni sessuali sciogliendo completamente il linguaggio dalle forme convenzionali. Si prende tutte le libertà, sembra addirittura voler accreditare l'autenticità di quello che ha vissuto aggiungendo tra virgolette le parole dei partner.
Ha un'attività di scrittura intensa. Nel 1979 pubblica il romanzo fotografico Suzanne et Louise al quale fanno seguito il catalogo Le seul visage e L'immagine fantasma. Quest'ultimo è la raccolta di 64 frammenti suscitati da fotografie pubblicitarie, fototessere, foto rubate o dalla radiografia del suo torace.
Tuttavia succede qualcosa di strano. Veniamo turbati mentre leggiamo quelle pagine. Perché dovrebbero turbarci così tanto? Il diario è da sempre legato alla strana persuasione che sia possibile osservarsi e che sia necessario conoscersi. Si scrive per non perdersi nelle miserie del quotidiano, ci si interroga sui propri errori, si registrano le fortune e gli errori della navigazione. A Guibert però non basta, non è soddisfatto. Le date non ci sono oppure si mescolano creando una straordinaria tensione tra quello che è fattuale e quello che rimane immaginario, pura fantasia; riconfigurando un'esperienza temporale alternativa dà vita a uno spazio privato che non è più il luogo della confessione, ma il trampolino di lancio per un'immaginazione erotica condivisa. Quella di Guibert non è certamente una scrittura innocente: cerca di rendere il lettore un voyeur quanto il narratore un esibizionista. L'ebbrezza dei dettagli diventa l'unico mezzo sicuro per salvare una moltitudine di istanti che altrimenti verrebbero inghiottiti dall'oblio, dal silenzio del tempo.
Aveva ragione Balzac quando diceva che «ogni corpo, in natura, è composto da varie serie di spettri, in strati sovrapposti all'infinito, stratificati in pellicole infinitesimali, in tutti i sensi in cui l’ottica percepisce quei corpi».

Fotografia di Hervé Guibert.
Tuttavia, non troverete nessuna fotografia in L'immagine fantasma, finalmente pubblicato in Italia nella nuova collana di Contrasto, Lampi. (Poteva esistere titolo più azzeccato?)
Guibert decide di non includerne nemmeno una perché improvvisamente gli sembra che siano diventate estranee al suo racconto che «non parla che di immagini che non sono state realizzate, o immagini latenti, immagini intime al punto da essere invisibili» come quella che ha scattato alla madre nella residenza a La Rochelle. Un set fotografico bisogna prepararlo: come prima cosa allontana suo padre, poi libera il volto della donna «da quel guazzabuglio d'acconciatura bionda», la trucca con una cipria bianca, toglie le piante e la fa accomodare su una poltrona anch'essa bianca. Al giovane Hervé in quel momento sembra una donna bellissima ma bastano pochi scatti per trasformarla nuovamente nella casalinga dimessa e senza ambizioni di qualche minuto prima. Nel momento dello sviluppo, affidato al padre, Guibert pensa a un complotto, a un ostile scherzo del destino, ma deve tragicamente arrendersi all'evidenza: il rullino non è stato inserito bene nel corpo macchina. La fotografia è perduta per sempre come la bellezza di sua madre, ormai esposta all'invecchiamento.
È il tempo il vero protagonista del libro, che lega i singoli frammenti l'uno all'altro. Il tempo che l'ha fatto diventare calvo, fatto ingrigire la chioma di sua madre, che ha deteriorato uno scatto in bianco e nero, che si è portato via il farmacista anziano di Vaugirard. Fantasmi di una giovinezza malinconica che rimarranno sempre lì, tra le fotografie o nelle sue parole. Tutti fantasmi oziosi – come dice Gerard Macé – destinati a guardare senza vedere per l'eternità. E che cos'è la fotografia se non un affascinante strumento di tortura che uccide lentamente?

Fotografia di Hervé Guibert, Michel Foucault.
Nel primo frammento del libro, intitolato Gli occhiali per leggere nel pensiero, Guibert riporta «il crimine di una pratica quasi diabolica»: la fotografia potrebbe leggerci nel pensiero e costringerci a spogliarci. Incredibile. Uno strumento così piccolo e ordinario, come la macchina fotografica, promette la magica rivelazione di verità visibili e invisibili, ed è con il coraggio di un esploratore che il fotografo si abbandona, come un eroe in cerca di avventure.
Per esempio quella volta all'Isola d'Elba. Guibert esce per una passeggiata e vede quella che descrive come l'immagine perfetta: quattro ragazzi che fanno il bagno in mare. Peccato aver dimenticato la macchina fotografica a casa e meglio così, oggi con il cellulare sarebbe diverso. Se avesse scattato, l'intimità e l'emozione di quella visione sarebbero andate perdute nel bagno chimico, nei confini chiusi di un'immagine vuota, assente, neutra, in un tempo senza profondità. Meglio immaginare. Proprio per questo Guibert preferisce la foto erotica alla foto pornografica. La foto pornografica dice tutto, è iperrealistica, mentre con la foto erotica si può giocare, fantasticare: «cosa mi piacerebbe fare con quel corpo. […] È un corpo aperto, possibile, un corpo non definito», si impone sull'immaginazione e le impedisce di funzionare liberamente: è il punto di partenza per una fantasia. Del resto “fantasia” e “fantasma” vengono dal latino phantasma-atis ossia “un'immagine priva di fondamento reale prodotta dalla fantasia”.
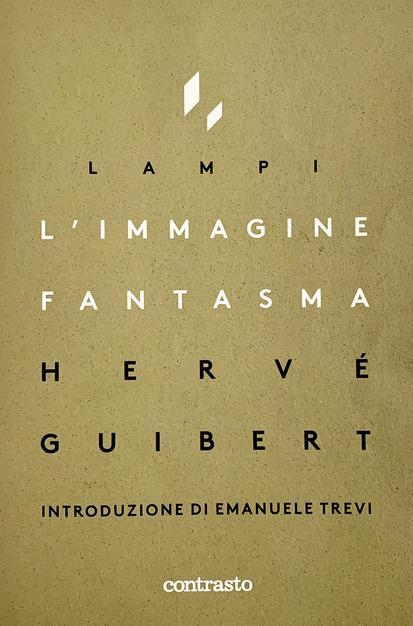
Ogni pretesto è buono per raccontare qualcosa di sé e aggiungere una tessera al grande puzzle autobiografico che Guibert vuole comporre. Quello che è reale e quello che è fittizio sono chiamati a incontrarsi infinite volte. L'elemento fantastico e quello autobiografico nella loro contrapposizione e complementarietà rappresentano una sorgente creativa capace di nutrire la totalità del suo progetto artistico, letterario e fotografico. Tante sono le trappole, le sue invenzioni bizzarre che spesso sfociano in confessioni fasulle. Tuttavia, possiamo ammirare la maestria di Hervé Guibert, la riflessione con cui ha sostenuto la sua ricerca e l'aspetto sperimentale dei suoi libri. La loro seduzione sta soprattutto in questo chiarore che illumina d'evidenza di certi nostri sogni.
Cos'era alla fine quella luce? Clic – il rumore dell'otturatore. Ci ha fotografati. Facciamo parte di quelle pagine. Desideriamo insieme a lui.









