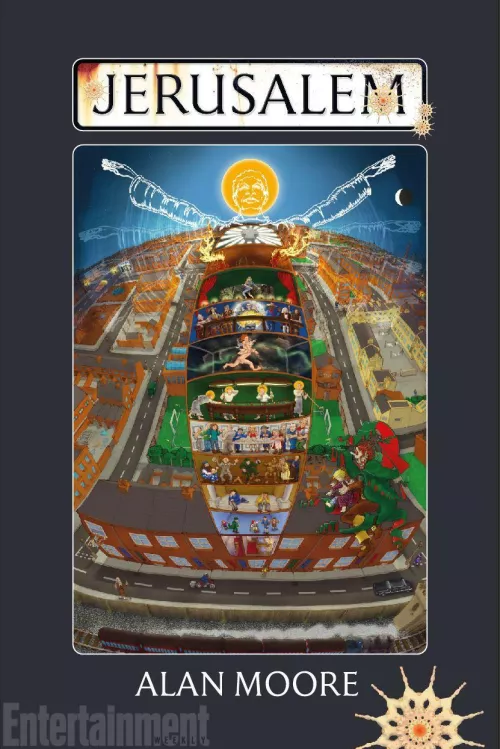Quindici mesi a stretto contatto con la sua immaginazione / Tradurre Jerusalem di Alan Moore
Il mio primo contatto con Jerusalem di Alan Moore risale all'inizio di ottobre 2014, con la lettura proposta dall'editore italiano di tre capitoli del romanzo – ancora in stesura – più una panoramica generale sull'opera mastodontica dell'autore di Northampton. Credo ancora che il succinto report inviato a lettura ultimata riassuma all'incirca i punti chiave del libro di Moore:
– scrittura di livello molto alto, sia come gusto sia come lingua usata e diversificata per i vari personaggi e contesti;
– intreccio misterioso e interessante pur non essendo di genere: è – almeno in questi tre capitoli – un romanzo molto ambizioso e poderoso (a quanto si annuncia nell'outline) che intreccia varie epoche e generi diversi; il tema di fondo è la relatività (Einstein viene citato apertamente), la relatività degli affetti, della storia – sia personale che con la "s" maiuscola –, e dei luoghi;
–– Alan Moore si distacca dall'immaginario "illustrato" che deriva dalla sua origine con fumetti e graphic novel (sebbene le parti romanzate di Watchmen mettessero già in luce le sue qualità narrative); l'ambientazione è molto ancorata alla realtà, sembrano scene dei film di Andrea Arnold (Red Road) o di Ken Loach sulla suburbia inglese;
– le pagine sono pervase da un'atmosfera sinistra, una specie di rumore sordo che accompagna la lettura finché qualcosa esplode (come la scena davvero suggestiva dell'affresco parlante nel secondo capitolo);
– non è un romanzo commerciale nel senso di pop, sembra molto letterario e sicuramente più papabile per un lettore medio-forte;
– resta che comunque la lettura è coinvolgente, e non è scontato che un autore venerato (giustamente) per la scrittura di graphic novel passi con scioltezza al romanzo letterario – si tratta comunque di due linguaggi diversi.
fatemi sapere che fine fa, a presto!
La fine che ha fatto è stata la traduzione full immersion proposta nella primavera 2016 e iniziata ai primi di luglio, per essere consegnata quindici mesi dopo, alla fine di settembre 2017. Forse proprio per questa immersione totale nel linguaggio e nella mente di Moore, molto preciso su numeri e date, considero questi quindici mesi trascorsi a stretto contatto con la sua immaginazione e il poderoso volume che la racchiude come una specie di terapia d'urto/teofania non solo professionale. La traduzione di Jerusalem è stata un'intensa apnea lisergica nell'aggregatore (quasi un Distruttore, per citare il Nulla vorace e nemesi dell'umanità nel romanzo) di profonda cultura e passione storica, nozionismo sparso, curiosità e slancio creativo formidabile che è la fantasia iperbolica di Moore.
Nonostante le ripetute invocazioni a William Blake a partire dal titolo stesso del romanzo (Jerusalem è l'unico inno composto da Blake), il riferimento portante del romanzo di Moore è James Joyce e il primo capitolo non a caso si intitola Work In Progress, titolo di lavorazione dell'ultimo romanzo dello scrittore irlandese pubblicato nel 1939, Finnegans Wake, “ambientato” all'interno di un sogno del protagonista Tim Finnegan. Il romanzo di Moore non si svolge tutto all'interno di un sogno, ma un'esperienza di morte apparente di un bambino di quattro anni soffocato da una caramella per la gola e il suo viaggio allegorico nell'aldilà (il “Di Sopra” nel romanzo di Moore) innescano la trama principale – se così possiamo definirla – e rivestono una buona fetta del romanzo. Jerusalem è composto da macro capitoli della lunghezza di racconti lunghi (o romanzi brevi, a scelta) scritti seguendo registri e stili diversi: oltre a tonnellate di citazioni dalla cultura pop contemporanea (musica, arte, fumetti e cinema), dal punto di vista letterario Moore si affida ai modi del romanzo vittoriano (Dickens), della poesia (John Clare e Lewis Carroll), del teatro (Beckett) e della letteratura sperimentale (il Joyce di Finnegans Wake).
Per una questione di affinità di temi e sensibilità, salta all'occhio l'esclusione dalle fonti di Moore di La terra desolata di T. S. Eliot (nel capitolo in cui Mick Warren riflette sui tarocchi in una notte insonne), mai neanche nominato di sfuggita insieme ad autori suoi contemporanei come Pound (citato solo nel capitolo su Lucia Joyce, figlia dello scrittore, che a Trieste lo chiamava «Signor Sterlina»). Lo stesso vale per Dante, a cui è impossibile non pensare quando ci troviamo a leggere la cronaca di un'avventura ultraterrena carica di significati religiosi (il teologo puritano Philip Doddridge è un personaggio chiave in Jerusalem, una specie di Virgilio in pensione). Come nella Commedia (e come in Finnegans Wake), anche in Jerusalem gli angeli si esprimono in una lingua assurda con sprazzi di vaga comprensione, una sorta di onomatopea aliena. Come per Eliot, Pound e Dante (anche lui citato solo di passaggio in una battuta veloce) è chiaro che la loro esclusione dipenda forse dalla volontà di Moore di accentrare tutto in Inghilterra, e in una specie di sciovinismo locale in particolare a Northampton. L'unico autore straniero di cui si avverte una forte eco è Lovecraft, oltre che per la sovrabbondanza di aggettivi e avverbi anche per il richiamo “visivo” a certe fantasie dello scrittore americano di Providence (amato da Moore). A differenza di quanto scritto nel report all'editore dopo la lettura di tre capitoli, la transizione da autore di graphic novel ad autore letterario non è sempre fluida nella corrente impetuosa che è Jerusalem. Impossibile da annullare pur con un tentativo letterario così ambizioso, la natura “illustrativa” di Moore è evidente nelle minuziose descrizioni delle passeggiate per Northampton dei suoi personaggi (forse potrei girarci pure io tranquillamente ormai), o le scene d'interno tratteggiate come se fossero tavole (in senso niente affatto diminutivo) dove l'occhio si ferma su ogni dettaglio finemente disegnato, a volte con troppa dovizia di particolari.
Non credo che esista un metodo universale per affrontare una traduzione, certo leggere il libro prima sarebbe piuttosto indicato, ma nel caso di Jerusalem poco agibile considerati i tempi di lavorazione relativamente stretti per l'ovvia ragione della sua mole stessa: Jerusalem è stato scritto in circa dieci anni, dal 2006 al 2016 (incluse le limature finali a ridosso della pubblicazione), è composto da oltre tre milioni e mezzo di caratteri e nel 2012 – a detta di Moore durante un'intervista e quindi non ancora ultimato – era già più lungo della Bibbia.
La seconda ragione per cui leggerlo prima di tradurlo risultò impraticabile era la densità del linguaggio evidente fin dalle battute iniziali. Il capitolo d'apertura di Jerusalem è infatti uno dei più ostici e ostili del romanzo; descrive il sogno di un personaggio alter ego al femminile di Moore oltre che uno dei fili conduttori dello pseudo intreccio, la futura artista Alma Warren, da bambina insieme alla madre e al fratellino Mick. Nel sogno viene descritta una passeggiata per Northampton dove è ambientato tutto il romanzo in ogni epoca passata, presente, futura e ultra inimmaginabile della storia e del tempo. Nel sogno Alma racconta l'incontro con un gruppo di falegnami impegnati a lavorare a tarda sera in una bottega, l'unica fonte di luce nella buia e sinistra Market Square. Doreen, la madre di Alma, parla con un'inflessione dialettale impossibile da rendere (a meno di non volere ripetere gli orrori della versione nostrana dei Monty Python e il Sacro Graal, con i vari accenti resi in dialetti regionali italiani alla Brancaleone, giusto perché era una commedia ad ambientazione medioevale): «Well, I’ll goo ter ayr ace. Look ’ere, you two, it’s the Frit Burr un ’iz angles».

Per la prima volta compare un termine che punteggia il resto del romanzo di Moore fino all'ultima pagina: il Frit Burr, nello slang pronunciato da mamma Doreen, ossia Third Borough. La scelta di rendere in italiano un termine così è più complicata di quanto possa sembrare, soprattutto perché racchiude un duplice riferimento personale e di luogo; borough significa “quartiere” o “distretto” e nel contesto, per estensione, anche chi lo amministra. Durante la lettura del romanzo si parla del Third Borough in più occasioni, soprattutto concepito come un piano astrale che incarna in sé un'entità, figura e luogo un'unica cosa.
Lo stesso discorso vale per un altro termine importante e frequente nel testo, deathmonger; si tratta di donne formidabili che un tempo vivevano a Northampton, e svolgevano funzioni di benvenuto e congedo in questa vita lavorando come ostetriche e, al sopraggiungere della morte, una figura per certi versi simile alla nostrana “accabadora” (scelta di traduzione considerata e poi abbandonata perché in fondo si adattava solo a metà del significato del termine originale, e per non incappare nella goffa resa dialettale a cui si accennava più sopra). Dopo avere tentato alcune strade per renderlo con la stessa efficacia di significato e “suono”, con l'editore si è concordato di lasciare la parola in Inglese, anche perché viene spiegato per esteso nel testo il ruolo delle deathmonger. Oppure ancora, e questi sono i casi più ricorrenti per cui si è stabilita la linea generale della scorrevolezza da seguire per tutto il romanzo: lo slang mezzo inventato dei monelli fantasma della Banda di Morti Morti («But as for where you wizzle be before, there ent no go-back») e la lingua foneticamente confusa e minata da giochi di parole di Mick appena emerge nel “Di Sopra”, nella lunga parte del romanzo dedicata al suo viaggio nell'aldilà («Know eye doughnut! Late me grow black square eyewash be four!»).
Già dal primo capitolo Moore sembra chiarire un concetto a cui resta fedele per tutto Jerusalem: l'assoluta indifferenza verso il lettore e, di conseguenza, verso il gusto del mercato. La densità e il sovraccarico di citazioni, riferimenti e giochi di parole all'interno del testo è così insistente da richiedere una linea guida da applicare a tutto il romanzo: la scorrevolezza. È chiaro fin da subito che Jerusalem non abbia un target di lettori a cui puntare (anche i suoi fan più accaniti facciano attenzione); è un concentrato di allusioni alla storia e alla letteratura inglesi che spazia dall'800 d.C. al 2006 con slanci visionari sulla fine del tempo stesso, indaga e fornisce teorie sulla relatività (o il capriccio) del cosmo, della vita e di ogni attimo che la compone tutto senza spostarsi da Northampton, il centro del Paese, la X che segna il punto – come giustamente è intitolato il capitolo sul pellegrino che trasporta una reliquia sacra dal Golgota fino all'Inghilterra del Regno di Mercia.
Anche il titolo Jerusalem può ingannare. La religiosità presente nel romanzo è più mistica e pagana, la cultura esoterica di Alan Moore (convertito alla magia dalla metà degli anni Novanta) riveste di simbologia quasi ogni gesto compiuto dai suoi personaggi (Alma organizza la propria giornata consultando le tabelle di Cornelio Agrippa), e per Moore stesso la scrittura è di per sé una pratica magica. Per Jerusalem viene in mente il commento di Croce sulla Commedia dantesca, a proposito della “struttura tutta coperta da tenace e fiorente vegetazione”. Il romanzo di Moore, soprattutto in alcuni capitoli, è proprio così: sotto una fitta copertura di rami e foglie c'è una storia da raccontare; è un intreccio tutto sommato né troppo complesso né particolarmente originale, ma pur con le sue estenuanti insistenze, la precisione con cui incasella ogni dettaglio in un gioco a incastri tra spazio e tempo per millecinquecento pagine è davvero encomiabile. È un mega romanzo imperfetto e stupefacente proprio per questa sua unicità colossale, va studiato più che letto per coglierne le sottigliezze, è certo un libro dal riverbero ritardato, che ha bisogno di tempo per entrare sottopelle ma alla fine lascia tracce indelebili. È un romanzo, se proprio vogliamo trovare un pubblico più indicato, per lettori tenaci e cerebrali, abituati a sopportare le esagerazioni dell'ego autoriale sulla pagina perché certi che prima o poi si imbatteranno in un brano memorabile, che peraltro abbondano in Jerusalem.
Tale è la ricchezza di citazioni nel testo originale, che bisognerebbe pubblicare una guida al testo, una vera e propria esegesi. Dalla sua uscita sul mercato anglofono nel settembre 2016, Jerusalem ha spronato un gruppo di pazienti e meticolosi lettori di Moore ad aprire una pagina wordpress di corredo critico al testo, un forum aperto con parafrasi e interpretazioni del testo, che sopperisce alla mancanza di uno strumento simile a disposizione del lettore nell'edizione pubblicata. Può essere una scelta snobista, come quella di scimmiottare il linguaggio polisemico di Joyce nel Finnegans Wake, per un capitolo tra i più lunghi, deliranti e struggenti di tutto libro: Girato l'angolo, che descrive una giornata di Lucia Joyce (giovane promessa della danza moderna e allieva di Isadora Duncan a Parigi negli anni Venti) anziana e malata di schizofrenia e ninfomania, ricoverata come paziente al St. Andrew's Hospital di Northampton, il manicomio dove morì sola e dimenticata nel 1981. Il titolo originale Round the Bend è un'espressione gergale, può significare “fuori di testa” e “folle”, ma anche “girato l'angolo” (gli angoli/angeli sono un altro punto fisso in Jerusalem). Per tradurlo seguendo la linea della scorrevolezza si è scelta una parafrasi del testo (di cui sotto un brano dell'originale con di seguito la traduzione), peraltro operazione compiuta anche dai lettori inglesi nel sito citato sopra, con due traduzioni diverse ma entrambe a loro modo corrette del capitolo, tante sono le interpretazioni possibili:
A wake, Lucia gets up wi' the wry sing of de light. She is a puzzle, shore enearth, as all the Nurzis and the D’actors would afform, but nibber a cross word these days, deepindig on her mendication and on every workin' grimpill's progress. Her arouse from drowse is like a Spring, a babboling book that gorgles up amist the soils o' sleep, flishing and glattering, to mate the mournin' son. Canfind in this loquation now she gushes and runs chinkling from her silt and softy bed, pooring her harp out down an illside and aweigh cross the old manscape to a modhouse brookfast. Ah, what a performance, practised and applausible. She claps her hands, over her ears, to drone out all the deadful wile-ing and the sorey implecations of whor farmlay. With her bunyans all complainin' she escapes the Settee o' Destraction and beguines her evrydaily Millgrimage towar's ridemption or towords the Wholly Sea; to wards, the tranquilisity of night.
Lucia si sveglia con la luce. Lei è sicuramente un enigma, come la definiscono infermiere e dottori, ma non sempre è un cruciverba, dipende dalle medicine e dall’efficienza dei sedativi pellegrini. Prende coscienza come una sorgente, un ruscello che gorgoglia nel terreno fertile del sonno, alla luce intermittente e abbagliante del sole del mattino. Confinata in questo luogo, sprizza dal suo soffice e comodo giaciglio di limo e scorre senza peso giù dalla collina attraversando il paesaggio per consumare la sua modesta colazione. Ah, che esibizione strepitosa, si è esercitata tanto e strappa sempre gli applausi. Si copre le orecchie con le mani per ridurre al minimo il ronzio in sottofondo, le allusioni dispiaciute e avvilenti della sua famiglia. Con gli alluci valghi che si lamentano sfugge al Lettino della Distrazione e inizia il suo quotidiano pellegrinaggio verso la redenzione o verso la santità; verso la quiete della notte.
Di per sé la versione originale di Jerusalem non è provvista di note, glossari o apparati di alcun tipo. Il tempo di attenzione richiesto per abituarsi al ritmo, alla costruzione mentale prima ancora che sintattica delle scene descritte è rallentato per la complessità di riferimenti e doppi sensi buttati nella mischia fin da subito. Jerusalem è un libro che non va divorato, non vuole essere il cosiddetto page turner costruito per creare dipendenza da suspense a ogni pagina, prende il suo tempo e subissa il lettore di immagini frastornanti, molto spesso potenti e anche se spesso minate dall'impulso sfrenato dell'autore di ribadire a oltranza concetti ed espressioni che dopo lo sbalordimento iniziale rischiano di diventare ripetitivi. In parte è certo dovuto alla lunghezza estrema del romanzo e al fatto che abbia ricevuto un editing limitato, come sottolineato anche nella chiosa dell'onesta e acuta recensione del «Guardian».
È impossibile che un'opera di questa ambizione, esibita e sfrontata davanti al lettore con noncuranza, consapevolmente limata fino a un certo punto, non sia priva di difetti degni della sua mole: è strano che, molto avanti nel romanzo, un inglese purosangue come Moore non abbia corretto un refuso come “Doctor Martins” per i famosi anfibi “Doc Martens”, a meno che non si riferisca a qualcosa di cui non disponiamo abbastanza informazioni da interpretare (perché la traduzione è prima di tutto una decifrazione, soprattutto come in questo caso); si spiega di più il molto probabile gioco di parole sotto l'apparente errore quando cita gli articoli da pittura del brand Winsor & Newton come “Windsor & Newton”, anche se nel contesto risalta più come una svista che un'allusione. Il testo di Moore straripa di rimandi a qualcosa in ogni riga.
Non è il libro a cui si risponde facilmente quando si arriva al sodo, cioè quando la domanda è: di cosa parla? Oltre ai temi indicati in apertura, la follia riveste un cardine portante su cui ruota una parte importante della vicenda, ma si tratta sempre di un involucro che racchiude una nuova cosmogonia: l'idea di aldilà onnipresente per ogni luogo e individuo, il tempo come un concetto metageometrico, la quarta dimensione che permette di attraversare epoche ed eoni avanti e indietro, sempre però senza muoversi mai, o troppo, dallo stesso posto. È un libro più “sui” che di fantasmi, non solo spettri di individui ma soprattutto di luoghi, intriso di nostalgia, a volte soffuso da un velo di paura nei confronti della morte, per quanto nel romanzo si cerchi di neutralizzarla come una dimensione alternativa e permanente, di cui non avere paura (anche perché ricolma degli stessi orrori dei vivi). È un romanzo che sconfina nella saga familiare, quella dei Vernall, un cognome di per sé simbolico: in inglese vernal significa “primaverile” o si riferisce all'equinozio di primavera (l'importanza della simbologia astrale), con la doppia L, Vernall riprende un antico cognome di origine anglo-scozzese che nel corso del tempo è diventato una specie di sinonimo di un'occupazione (come certi cognomi italiani di retaggio medioevale, per esempio Fabbri, Barbieri e Tintori). Nel caso di Vernall aveva qualcosa a che fare con la cura dei “confini” lungo le strade, a loro modo delle specie di guardiani, un'accezione ripresa da Moore nel contesto della trama.
Jerusalem è il secondo exploit letterario di Alan Moore. Il suo esordio come romanziere è avvenuto nel 1996 con La voce del fuoco, per certi versi una versione preliminare, molto più breve, di questo volume impegnativo. Durante i quindici mesi di lavoro intenso sulla traduzione più volte ho imprecato e inveito contro l'autore, e altrettante volte avrei voluto averlo di fianco per stringergli la mano e abbracciarlo per la bellezza di quanto aveva scritto. Poco alla volta la traduzione di Jerusalem è diventata parte integrante del mio quotidiano, non c'era giorno che passasse senza tradurre qualche pagina del romanzo, spesso perdendo ore dietro alla ricerca di citazioni e riferimenti disseminati a ruota. Dopo averlo consegnato, il giorno dopo quasi mi mancava già. Come avere un amico con cui hai condiviso la casa per più di un anno, con cui ti sei divertito e hai litigato in parti uguali, ma che ti dispiace si trasferisca altrove. Per fortuna, da un certo punto di vista si tratta di un trasloco snello, considerato che occuperà un angolo di rilievo della libreria in salotto (e Moore forse approverebbe, visto il suo amore per gli angoli).