Diamond cammina sul filo
Se vi piace il rischio, occupatevi dei rapporti fra le società tribali e il mondo occidentale. I rulli di tamburo delle polemiche sono assicurati. E’ quello che candidamente ha fatto Jared Diamond ne Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (Einaudi, 2013), camminando per cinquecento pagine sulla corda tesa di un nervo scoperto. Come si fa a passare in pochi decenni dall’età della pietra a un aeroporto internazionale? La risposta consiste, per l’autore, in una miscela di elementi comuni (ciò che ci fa essere umani in quanto tutti esemplari di Homo sapiens) e di differenze comportamentali, cognitive e culturali che illustrano il caleidoscopio degli innumerevoli esperimenti di socialità umana sul pianeta.
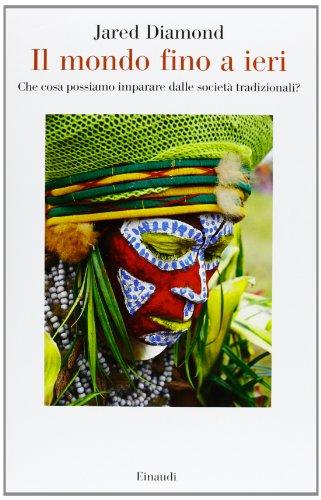
Il mondo di ieri non è una presenza esotica lontana: è dentro di noi e permea ancora profondamente le società industrializzate, anche perché queste ultime sono soltanto una delle tante possibili evoluzioni nello spettro della variabilità umana (un tempo assai più ricco di oggi, peraltro). Come ci insegnano le transizioni evolutive più importanti, le innovazioni avvengono tramite un’esplorazione di possibilità a ventaglio, non focalizzandosi su una via maestra. Per Diamond ogni cultura rappresenta un esperimento naturale su come si costruisce una società umana, e come tale la studia, appunto come un esperimento naturale di organizzazione. Poi però questa volta, rispetto al capolavoro Armi, acciaio e malattie e al più impastato Collasso, l’autore si avventura in un esercizio spericolato: discernere, fra le soluzioni sociali sperimentate dai popoli tribali, quelle che dovremmo recuperare e adottare anche noi occidentali (delizioso il capitolo sulla “paranoia costruttiva” con cui i popoli della foresta affrontano i pericoli, reali e potenziali, dando la massima importanza anche ai minimi indizi) e quelle che invece dobbiamo essere ben contenti di aver abbandonato del tutto, apprezzando così i vantaggi che la nostra società ci offre e che distrattamente diamo per acquisiti. Insomma: che cosa dobbiamo invidiare loro e su che cosa possiamo altresì essere orgogliosi, nonostante la nostra nicchia ecologica asfaltata di cemento.
Da qui prende avvio una lunga esplorazione di territori comparativi (la libertà di movimento, l’amministrazione della giustizia, la risoluzione dei conflitti, l’educazione dei figli, la vita familiare, le lingue, le religioni) basata su parametri quantitativi che ad avviso di Diamond permettono di stabilire adeguate correlazioni: dimensione demografica, forme di sussistenza, centralizzazione del potere, stratificazioni sociali, e così via. A sua volta la calibrazione di questi parametri dipende dai vincoli ecologici. La banda di cacciatori-raccoglitori è una soluzione sociale adatta per certi set di parametri, lo stato nazionale per altri, e in mezzo si apre una vasta gamma di strategie intermedie per vivere insieme.
Mettendo insieme capitoli già pubblicati in prime versioni come saggi autonomi, il libro – obiettivamente pesante, ripetitivo e di faticosa lettura – finisce per diventare un catalogo dei molti modi di vivere, di credere, di fare la guerra e la pace, di allevare la prole, di entrare in relazione con l’altro, sperimentati dalla moltitudine delle culture umane. Un catalogo di per sé neutrale dal quale si può prendere e lasciare – ripete Diamond – per costruire società migliori in futuro, prima che le società tradizionali scompaiano del tutto. La tesi principale, sempre camminando sul suo filo teso, è moderata e quasi banale: per certi aspetti, le società moderne offrono vantaggi importanti rispetto a quelle tradizionali (in particolare in fatto di gestione della violenza individuale); per altri aspetti, abbiamo al contrario tanto da imparare dai nativi (dal senso delle relazioni comunitarie, al rispetto per l’ambiente, al multilinguismo). Ne consegue che è sbagliato sia affidarsi a ingenue visioni del progresso umano sia idealizzare nostalgicamente le popolazioni tribali.

Sembra un messaggio quasi innocuo, e invece il docente della UCLA sta passeggiando con un accendino in mano sopra una polveriera. Il libro di Diamond ha suscitato critiche così aggressive e automatiche da lasciare qualche margine di sospetto. L’indignazione proviene in gran parte dal mondo dell’antropologia culturale e dai movimenti di difesa dei diritti delle popolazioni native, oltre che da alcuni rappresentanti di queste ultime, che si sono sentiti offesi per il modo in cui è descritta la loro presunta bellicosità. E’ stato sostenuto che Diamond commette un grave errore nel considerare le sue tribù “società tradizionali”, quasi fossero relitti del passato sopravvissuti tali e quali fino a oggi, un po’ come certe specie biologiche rimaste uguali a se stesse per milioni di anni e una volta definite “fossili viventi”. Ebbene, come nell’evoluzione non esistono fossili viventi, così in antropologia è errato descrivere i popoli tribali al pari di vestigia del passato.
La critica è corretta e riguarda diversi passaggi in cui Diamond indulge effettivamente nel confronto diretto (e a volte inopportunamente valutativo) fra società tribali e società statali contemporanee. Tuttavia, l’indignazione che ne consegue si basa su un fraintendimento. La tesi di Diamond è che i popoli nativi rappresentano un insieme di stili di vita, estremamente diversificati, che fino a diecimila anni fa riguardavano tutta l’umanità. E questo non è un merito né una colpa, ma un dato di fatto dell’evoluzione di Homo sapiens. Sa benissimo, l’autore, che i popoli indigeni sono non soltanto culturalmente ma anche “biologicamente” moderni (lo ribadisce più volte e fin dall’introduzione, a pagina 21, e del resto era il motivo centrale di Armi, acciaio e malattie), e che i cacciatori-raccoglitori di oggi si stanno evolvendo almeno da 60mila anni (come attestano anche recenti dati genetici). Il suo obiettivo primario però non è un confronto diretto fra passato e presente, bensì una comparazione sistematica fra “esperimenti sociali” differenti, da classificare integrando alcuni criteri comuni (densità demografiche, caratteristiche dell’ambiente, tipi di risorse, animali e piante domesticabili, e così via). Vedere in questo un bieco esempio di progressionismo e di complicità imperialista è francamente un po’ troppo.
Ma siamo solo all’inizio della bufera. Si aggiunge infatti che l’idea secondo cui i popoli tribali sarebbero gli ultimi sopravvissuti di un tempo passato (posto che non si tratta affatto della tesi centrale del libro) condurrebbe logicamente alla giustificazione dei tentativi colonialistici di “fare evolvere” a forza questi popoli, “educandoli” ai valori occidentali, distruggendo le loro culture e assimilandoli una volta per tutte. Questo non soltanto non è il convincimento di Diamond (semmai l’esatto contrario, visto che il libro è un lungo peana al valore intrinseco di queste culture) ma non discende affatto logicamente dalla premessa, dato che anche un reperto archeologico del passato (a maggior ragione se ci riguarda direttamente) avrebbe di per sé un enorme valore, come quando proviamo a salvare l’ultimo gruppo di parlanti una lingua in via di estinzione.

Se un governo nazionale usa quell’argomento per sopprimere popoli e culture, lo fa perché non ha capito l’argomento o perché lo sta brutalmente strumentalizzando. E Diamond non c’entra niente. I popoli tribali non sono nostri antenati, ma nostri cugini e fratelli nella grande storia della diversità umana. Qualsiasi forma di progressionismo, anche velato e implicito, va sostituita con un pensiero improntato all’unicità dei tanti ramoscelli della vicenda umana. Questo però non ci impedisce di (anzi ci esorta a) provare a studiare scientificamente l’evoluzione di tali diversità, considerando ciascuna di esse una traiettoria unica e dotata di pari dignità rispetto a tutte le altre. Scopriremo così che qualcuno è vissuto in ambienti più stabili di altri, con maggiori o minori possibilità di spostamento, con differenti specie domesticabili, con reti sociali diverse, e così via. Senza con ciò affibbiare giudizi morali. E invece, come una tagliola, scatta l’accusa infamante di favoreggiamento dell’imperialismo.
Un secondo ordine di critiche riguarda la tesi di Diamond secondo cui in alcune società tradizionali vi sarebbero elevati livelli di bellicosità, di vendette personali, di infanticidio e di altri comportamenti che noi ovviamente riteniamo oggi (in linea di principio, salvo poi fare di molto peggio) contrari ai diritti umani fondamentali. Si possono discutere le statistiche a volte grossolane usate da Diamond (come quando compara le percentuali di vittime di una guerra tribale con l’11 settembre), ma che la descrizione di questi normali fenomeni presenti in qualsiasi gruppo umano debba suscitare offesa e indignazione è stupefacente. Anche qui vale la fallacia logica di prima: se anche scoprissimo che la brutalità è molto diffusa nei popoli tribali, ciò non sarebbe in ogni caso un motivo per imporre loro con la forza una struttura statale pacificante. E non è questo l’argomento di Diamond. Se un generale di qualche paese equatoriale brandirà il libro di Diamond prima di muovere i suoi uomini contro una tribù di cacciatori, vorrà dire che non avrà capito una riga di ciò che ha letto, e nessuno se ne stupirà.
Evidentemente qualcuno pensa ancora che i popoli tribali siano indistintamente esempi fulgidi di solidarietà, di pace e di sostenibilità ambientale, nonostante le evidenze contrarie. Non quindi umani imperfetti come noi, si badi bene, ma incorrotti rappresentanti di un’età dell’oro ormai soppiantata dal cancro della civilizzazione. E così rifulge la stridente contraddizione dei critici di Diamond: guai a definire le società tradizionali come fossili viventi, d’accordo, ma poi non va bene neppure se le dipingiamo per ciò che sono, cioè esperimenti in corso di umanità organizzata, con le loro ambivalenze e le loro idiosincrasie in evoluzione. Non sono relitti arretrati del passato, certo, ma poi ci piace pensarli come tali, cioè come riferimenti morali di una saggia e armonica naturalità perduta, di un tempo in cui Homo sapiens viveva in pace con gli spiriti della terra e del cielo.
Vogliamo insomma come sempre la botte piena e la moglie ubriaca. In questo caso, vogliamo che gli “altri da noi” siano moderni, evoluti a modo loro, nostri fratelli contemporanei con pari diritti e dignità, ma poi abbiamo bisogno di lenire il nostro (ben motivato) senso di colpa occidentale rappresentando i popoli tribali come presepi di vetro immuni dalle nostre storture. Eppure anche loro hanno avuto i genocidi, le pulizie etniche, le devastazioni ambientali, le faide senza fine, l’omicidio e la tortura. Anche se su scala infinitamente meno invasiva rispetto alle nazioni dominatrici, sono stati al contempo inguaribilmente distruttivi e creativi come ogni gruppo di Homo sapiens da quando siamo nati in Africa 200mila anni fa. Magari Diamond esagera sulla “quantità” di belligeranza di quella o di quell’altra popolazione, e per questo va corretto: ma che cosa cambia rispetto al succo della questione?
Gli invasori hanno ucciso, torturato e depredato molto di più, non c’è dubbio, e non dobbiamo stancarci un momento nel denunciare l’estinzione di massa vergognosa delle culture native e l’omologazione forzata delle diversità che prosegue in tutto il mondo nell’indifferenza generale. Dunque, non vale alcun argomento assolutorio del tipo “siamo tutti cattivi, pari e patta”. Ma questo è forse un motivo valido per prendersela con un libro che racconta come anche loro abbiano ucciso e fatto la guerra in determinate circostanze? Siamo sicuri di difenderli correttamente idealizzandoli in questo modo per nostre esigenze polemiche tutte occidentali? I capi di alcune tribù della Papua Occidentale si sono risentiti per le ricostruzioni a loro avviso fuorvianti dei conflitti fra gruppi, ma perché dobbiamo automaticamente considerare più attendibile il loro punto di vista interno rispetto a quello di uno studioso che ci ha lavorato per decenni?
La società industrializzata, inquinante e schiacciante, ci coinvolge tutti, con i nostri desideri e i nostri consumi: non basta radicalizzare una buona causa per illudersi di essersene tirati fuori. Lo sguardo eterodosso di Diamond – un po’ biologo, un po’ fisiologo, antropologo, geografo, ecologo – ha questa colpa imperdonabile: il decentramento dell’approccio evolutivo, che svela la radicale ambivalenza di noi loquaci mammiferi sociali. E’ innamorato degli ultimi cacciatori-raccoglitori rimasti, ma tenta comparazioni che i militanti non amano. Investigando le sue tanto care “cause remote” e non soltanto quelle prossime, si avventura con fare naïf in territori presidiati, da un secolo e mezzo, da scontri accademici all’arma bianca fra culturalisti ed evoluzionisti. Ha l’ardire di rifiutare qualsiasi essenzialismo (compreso quello di chi attribuisce agli uni o agli altri meriti cognitivi e biologici particolari) e di puntare tutto sulle contingenze ambientali che hanno spostato i destini dei popoli. Cerca di mettere insieme, caso per caso, le invarianti oggettive e i tratti storico-culturali indipendenti. Gli piace il rischio e continua a camminare sul suo filo teso. Per chi sta sotto, è più rassicurante raggomitolarsi nel proprio senso di colpa e travasarlo nella nostalgia per un tempo che non è mai esistito.









