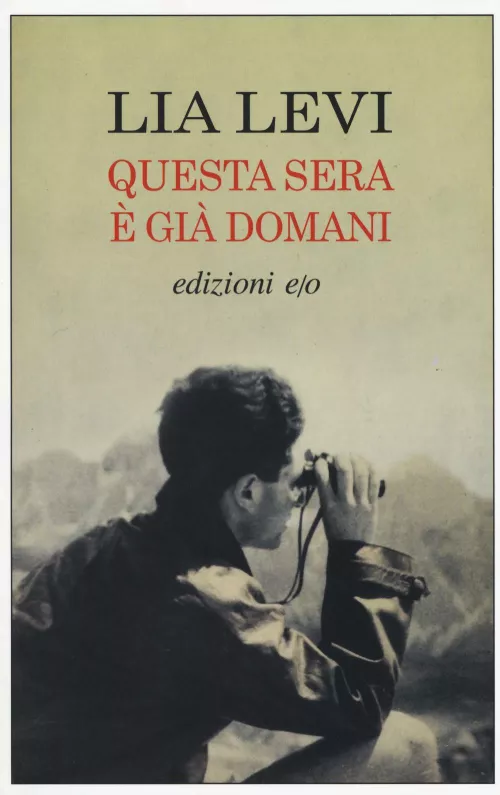Romanzi come intensi esercizi di memoria
La citazione in esergo nell’ultimo libro di Rosella Postorino, Le assaggiatrici, rimanda all’Opera da tre soldi di Brecht («Nel mondo l’uomo è vivo a un patto: / se può scordar che a guisa d’uomo è fatto») e alla necessità di dimenticare “infamie e brutture” di cui egli vive per scontare il peso dell’umanità senza lasciarsi schiacciare. In Questa sera è già domani, ultimo romanzo di Lia Levi, finalista al premio Strega, l’epigrafe prende invece la forma dei versi di Emily Dickinson e avverte chiunque osi disubbidire al mandato dell’oblio avventurandosi nel regno solenne e polveroso della memoria («Quando spolveri il sacro ripostiglio / che chiamiamo “memoria” / scegli una scopa molto rispettosa / e fallo in gran silenzio. / Sarà un lavoro pieno di sorprese – / oltre all’identità / potrebbe darsi / che altri interlocutori si presentino – / Di quel regno la polvere è solenne – / sfidarla non conviene – / tu non puoi sopraffarla – invece lei / può ammutolire te»).
Tutto ciò che segue, in entrambi i libri, dimostra l’assunto paradossale secondo il quale per sopravvivere è necessario dimenticare l’orrore che ci ha abitato, ma per andare avanti e spezzare la coazione a ripetere è obbligatorio guardarsi indietro, riattraversare incubi e ferite per cambiare il passo e la direzione.
Per questo motivo leggere questi romanzi è fare un esercizio di memoria che ha tutta l’intensità della narrazione riuscita; è un tornare indietro consapevolmente, ripetere vecchie strade con gli occhi aperti; è sovrapporre le parole del passato a quelle che ci risuonano intorno oggi, appesantendo l’aria come un presentimento e ricalcare con la mente i punti in cui coincidono senza sbavature, tanto da ferire le orecchie e far pulsare ferite sottopelle ancora fresche ma dimenticate.
Rosella Postorino. Le assaggiatrici
È l’autunno del 1943, Rosa Sauer ha ventisei anni, un marito partito per il fronte sovietico e una vita già dissestata da crolli, buche e privazioni. Il fratello Franz si è imbarcato per l’America lasciandosi dietro solo una vecchia fotografia stropicciata, il padre se n’è andato con un infarto, incapace di abituarsi all’idea del nazismo, la madre se l’è presa un bombardamento ed è morta in una cantina che puzzava di urina e paura, con la giacca sopra il pigiama, dentro le macerie di un palazzo sventrato. Ma Rosa sopravvive e viaggia su un treno che da Berlino si muove pigro verso la Prussia orientale, verso Gross-Partsch dove vivono i suoceri, l’unica famiglia che le rimane. Mentre fugge dalla capitale svuotata, Rosa non immagina che a tre chilometri dalla sua nuova casa, nel cuore di foresta, c’è il quartier generale di Rastemburg, il bunker segreto di Hitler; non sa di viaggiare verso la wolfsschanze, dritta nella tana del lupo.
Rosa non è una nazista, nessuno nella sua famiglia è mai stato un nazista e nelle orecchie le rimbomba la voce del padre, che aveva rifiutato la tessera del partito e dall’oltretomba le ripete con la violenza delle verità impossibili che chiunque è responsabile del regime che tollera, che non si è immuni da nessuna colpa politica. Nella Germania del 1943, infatti, sembrano tutti consenzienti: «la nazione si consegnava al suo Führer e lo dichiarava senza indugio, pronunciando il suo nome, formula magica e rituale, vocabolo di potenza smisurata, quella nazione era struggente, era il senso di appartenenza che rovesciava la solitudine nella quale chiunque nasca è confinato».
A scuola Rosa impara a fare il saluto nazista, i muscoli contratti in una vibrante tensione votiva, l’anima offerta al Führer nella mano protesa; eccelle nell’esecuzione, ma si stanca presto: il nazismo «era un’illusione cui non mi importava di credere, avrei solo voluto sentirla dentro di me come un languore - non un sentimento di vittoria, ma di corrispondenza». Il nazismo infiamma e acceca, come la più crudele delle illusioni.
Rosa non era mai stata nazista, Hitler le aveva rubato il fratello, il marito, la famiglia, ma la vita del Führer vale più di tutte le altre vite spazzate via, vale più della sua stessa vita. Per questo viene arruolata nella squadra delle assaggiatrici di Hitler, dieci donne che ogni giorno mangiano il cibo a lui destinato per scongiurare attentati venefici e manomissioni, dieci cavie, dieci tubi digerenti con uno stipendio e tre pasti al giorno.
Ogni boccone scatena alla vista l’acquolina e stringe lo stomaco di fame e paura, ogni piatto è una scommessa con la morte: «nella caserma di Krausendorf rischiamo di morire ogni giorno, ma non più di chiunque sia vivo». È la vita il cibo avvelenato, che consumiamo e ci consuma, e Rosa aveva iniziato questo gioco sin da bambina, quando deglutiva di nascosto le fibre di cotone che sua madre rovesciava per terra dalla cesta del cucito, chiedendosi quale filo colorato l’avrebbe uccisa; quando aveva infilato la mano del fratellino neonato fra i denti e aveva morso con forza. “Quando si mangia si combatte con la morte”, le ripeteva sempre la madre, e mai era stato vero come nella caserma delle assaggiatrici: «il mio stomaco non ribolliva più, si era lasciato occupare. Il mio corpo aveva assorbito il cibo del Führer, il cibo del Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo di nuovo fame».
Ogni pasto è un’eucarestia, il cibo del nemico dentro il proprio corpo: «ogni giorno i nostri dieci piatti allineati evocavano la sua presenza come in una transustanziazione».
Rosa non è nazista, ma lavora per Hitler, mangia il suo cibo per salvargli la vita. Ripensa al suo insegnante preferito, che le SS avevano strappato dalla cattedra una mattina davanti ai suoi occhi, con l’accusa di essere ebreo, ripensa al coro in cui cantava, sciolto a causa delle leggi razziali, pensa a suo marito spedito al fronte, al figlio che non avrà mai, all’offesa di una vita che sembra non valere niente eppure resiste, non muore. Rosa è una cavia utile a testare il cibo del Führer, è un corpo attraverso il quale farlo passare, da vivisezionare se qualcosa va storto. Così lei si identifica con il corpo, legge nella carne le rotte da seguire, impulsi, brividi, scosse, nausea, spilli che pungono sotto la pelle, angoscia che morde lo stomaco, eccitazione, il cibo lungo l’esofago, i lividi sulle gambe, “la merda, che è la perversione di dio” o la prova della sua infondatezza.
Il nazismo toglie, un pezzo alla volta, tutto ciò che fa un individuo e una volta finito rimane il corpo, la carne che non suscita compassione, il misero contorno dello spazio che occupiamo nel mondo, il peccato di dio, la condanna e l’assurdità di pensarsi finiti.
È forse per questo che Rosa sceglie di aggiungere la colpa alla sua condanna, che scivola nel corpo per trovare focolai di vita rimasti accesi, che lo sente divampare di colpo quando uno sguardo estraneo e nemico, le si posa addosso.
«Da troppo tempo eravamo donne senza uomini: non era il sesso a mancarci, ma l’impressione di essere viste»: gli occhi del nemico le si puntano addosso e il desiderio dell’altro la fa esistere un po’ di più. Nel buio lui la guarda dalla finestra, lei è vista, è riconosciuta, non è solo corpo, tubo digerente, è Rosa che canta, che veste un abito che lascia scoperta la schiena, che si alza di notte per essere guardata da qualcuno che ha scelto proprio lei. Questo è sufficiente per accettare lo sguardo su di sé, per decidere di percorrere a occhi chiusi il corpo di un altro cercando una ragione del proprio: «avevo camminato verso di lui perché ero una persona che poteva spingersi fino a lì, fino a quella vergogna fatta di tendini e ossa e saliva». L’intimità con il nazismo non è più accidentale, è una scelta, una colpa scontata nell’illusione che non ci sia altro che il corpo, corpi nudi senza insegne né divise, corpi umani, corpi ribelli, corpi che resistono e sopravvivono. Eppure nel corpo l’umanità sembra smarrirsi: «Perché da tempo mi trovavo in posti in cui non volevo stare, e accondiscendevo, e non mi ribellavo, e continuavo a sopravvivere ogni volta che qualcuno mi veniva portato via? La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana».
Il libro di Rosella Postorino racconta di come la vita resista anche circondata dal buio, di quanto il confine che ci divide dall’oscurità illudendoci di essere salvi scivoli sempre più avanti, di come più ci avviciniamo al buio, più i contorni delle cose si slabbrino, di come la nostra vita continui intollerabilmente a discapito dell’orrore, di quanto l’orrore sia parte della nostra vita.
Adolf Hitler è un essere umano che digerisce, arriccia il labbro superiore in un modo ridicolo, rifiuta la carne perché rigetta le torture sugli animali, ama il suo cane Blondie che canta e guaisce a comando, digerisce male, fatica a prendere sonno. Il nazismo è umano e individuale, se l’idea trascende il singolo per farsi coro idolatra, la sua forza sta dentro le case, nei discorsi, negli sguardi, nei silenzi, nelle scelte di ognuno.
Rosa è una donna che si trova suo malgrado di fronte all’orrore, non può ignorarlo senza morire, ma la vita è più forte e allora lo sfiora, lo inghiotte a fatica, lo spia, riesce quasi ad amarlo, ne ha paura, lo rifiuta, gli sputa in faccia e se lo addormenta in braccio a furia di carezze. Perché l’orrore s’incarna e ha volti, nomi e un’inconfondibile risata nasale, un respiro di bambina di notte, capillari che fioriscono sulle guance come ali di farfalla, occhi troppo vicini che non fanno paura.
«Non esiste pietà universale, solo l’impietosirsi davanti al destino di un singolo essere umano», e sembra impossibile guardare il buio senza esserci dentro, già contagiati, impossibile posare uno sguardo sull’altro che non sia complice e insieme colpevole. «È solo ignorando la vita degli altri mentre scorre, è solo grazie a questa fisiologica carenza di informazioni che possiamo non impazzire» pensa Rosa, e sopravvivere è il frutto di un caso e della capacità di distogliere lo sguardo, darsi ragione di una vita che resiste, nella somma di tutte quelle perdute. Dove non c’è scelta si sopravvive scontando le colpe degli altri, portandole addosso senza lasciarsi schiacciare.

Lia Levi. Questa sera è già domani
È il 1937 Alessandro ha otto anni, vive a Genova con i genitori e il nonno Luigi, ferroviere in pensione rimasto solo dopo la morte della moglie Rachele. Di lei ad Alessandro non rimane che uno struggente ricordo e una medaglietta d’oro con la stella ebraica, eredità simbolica da custodire in segreto per leggere la propria storia e conquistare la propria identità.
A otto anni Alessandro si prepara per cominciare la quinta elementare perché da bambino ha frequentato le due cugine più grandi, ne ha ricalcato gesti e parole su libri e quaderni finché non è stato capace di leggere e scrivere anche lui, e a cinque anni è stato spedito in seconda elementare.
La benedizione di un enfant prodige riscalda la famiglia Rimon, raggelata dai rancori e dai malumori della madre: Alessandro è un piccolo genio che riempie d’orgoglio e di speranze zii e parenti e regala alla madre fantasie di riscatto.
Il bambino è così bravo che viene scelto per declamare il giuramento di fedeltà al Fascio a nome della sua scuola. Viaggia con la classe fino a Roma per applaudire il duce affacciato al balcone di Palazzo Venezia e prende parte alle adunanze del sabato in piazza della Vittoria in rappresentanza della primavera fascista genovese finché un giorno, stretto nella divisa da balilla, morso alle gambe e alle braccia dal mostro della noia, sente i piedi che si muovono da soli, un passo dopo l’altro a lasciare la piazza e le adunate per non tornarci mai più. Il padre Marc Rimon, ebreo belga con passaporto inglese che nel melting pot portuale di Genova ha trovato un posto da chiamare casa, ne è segretamente contento, gli legge Le Journal, gli racconta della guerra di Spagna contro Franco e i cattivi fascisti, gli regala una parola per i buoni, gouvernamentaux, che Alessandro si rigira in bocca, gustandone rintocchi e rotondità. «Tenersi lontano dalla politica in quei tempi era assennato ma non facile»; c’è il cugino comunista che entra ed esce di prigione, il parente disperso, forse preso dai fascisti, c’è la stampa che si fa coro di una sola voce, e i giornali internazionali che spariscono dalle edicole insieme alle notizie “politiche e vere”.
Nel 1938, a nove anni, Alessandro inizia la prima ginnasio. È un bambino in mezzo a ragazzini ostili, i risultati scolastici calano, è bravo ma non più brillante, non più genio, un ragazzo come gli altri, un terreno fertile da accudire e coltivare, ma non più buono per piantarci sopra dei sogni.
In classe lo prendono in giro, è diverso per l’età e per il fatto che salta le lezioni di religione in quanto ebreo, ma solo la prima differenza per il momento sembra contare davvero. Un giorno non riesce a frenare una battuta contro il regime che gli rotola fuori dalla bocca e fa calare il gelo nell’aula. Gli toccano cinque giorni di sospensione e poi l’incontenibile entusiasmo dei compagni al suo ritorno, le pacche sulle spalle al ragazzino che ha fulminato professori, bidelli e preside. Alessandro finalmente è accolto tra i compagni, ma il regime ha per lui piani diversi.
Le prime avvisaglie sono le notizie sparpagliate sulla stampa nazionale, parlano degli ebrei, dicono che sono troppi, come in Germania, ma la Germania non è l’Italia, Mussolini non è Hitler. La famiglia Rimon, come le altre famiglie ebree, le accoglie come un presentimento vago. Una mattina compare su un quotidiano il Manifesto degli scienziati razzisti, parole infette stampate e incorniciate, tante piccole detonazioni che battono nelle orecchie e spezzano il fiato, esplose sui tavoli delle famiglie che scoprono che esiste una razza italiana dalla quale loro sono esclusi, estranei su territorio straniero, in bilico su sedie e poltrone già instabili e insicure.
Ma la vita continua come sempre, con una preoccupazione infilata in gola che non scende e l’attenzione a captare segnali come presagi. L’Ufficio demografico del ministero dell’Interno diventa Direzione per la demografia e per la razza, ma sull’Informazione diplomatica scrivono che «il governo fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei in quanto tali. Discriminare non significa perseguitare». Secondo lo stato gli ebrei non sono italiani, riflette lo zio Osvaldo, e «se qualcuno si trova a casa tua, hai per lo meno diritto di sapere chi è e che cosa fa. Ma questo non significa essere ostile nei suoi confronti».
Li avrebbero censiti, schedati, controllati, ma non perseguitati. Pochi giorni dopo arriva la lettera di espulsione indirizzata al padre di Alessandro, ebreo con passaporto inglese entrato in Italia dopo il 1912. Ma Genova è casa, l’Inghilterra no, così decidono di restare, mentre Alessandro, scopre che non tornerà nella sua classe dopo l’estate perché gli alunni ebrei sono espulsi da tutte le scuole.
Via dalle scuole, via da aziende e negozi, via dagli albi e dagli elenchi telefonici, gli ebrei si trovano frastornati, obbligati a fare i conti con un’identità che improvvisamente li ha marchiati, distinti dagli altri, legati fra loro. Prima di aver captato tutti i segnali, le leggi razziali sono entrate in vigore passando lungo i labirinti della burocrazia, sottotraccia, in un progressivo e cauto adattarsi di quel piccolo mondo all’antisemitismo: «i provvedimenti contro gli ebrei continuavano a cadere a scansione lenta, come quei goccioloni radi ma già carichi che preludono alla tempesta. Si ritrovarono fradici senza essersene accorti».
La famiglia Rimon si accoda a quel lugubre corteo di ebrei dispersi, si ritrovano tutti insieme perché il marchio che li ha improvvisamente divisi da tutti gli altri italiani li ha anche raccolti in una comunità. Si incontrano disorientati e confusi per capire come salvarsi la vita, come fuggire, come restare. La vita intanto prosegue sotto i loro piedi, Alessandro finisce alla scuola ebraica, fa nuove amicizie, il padre riesce a lavorare nonostante gli abbiano tolto la licenza, perdono la radio, la cameriera, ma la vita va avanti quasi come prima. «Possibile che la vita nonostante tutto scorresse bene?» – si chiede Alessandro – come ebreo gli era proibito andare a pattinare, andare in spiaggia, ascoltare la radio, eppure giocava con il figlio del portiere, si innamorava di una compagna di scuola, «gli sembrava che tutto procedesse come se un treno, dopo aver deragliato, continuasse la sua corsa sul terreno. Infido, pericoloso, pieno di buche, ma pur sempre terraferma e in qualche modo rassicurante. La spinta umana a rassegnarsi è davvero così forte? Quello che ieri era sembrato insostenibile, oggi si riusciva a inghiottirlo quasi senza fatica».
La sopravvivenza, anche qui, è frutto di un caso, lo spiega bene Paula, la ragazzina austriaca sfollata a Genova e ospitata dalla famiglia Rimon, che in francese racconta ad Alessandro di come Vienna sia cambiata in una notte, della segregazione, della violenza sul fratello a scuola, del fatto che a lei è andata meglio “ma è stato un caso, capisci? Solo un caso. L’inferno ha parecchi gradini ma sempre di inferno si tratta”.
L’inferno è una scala che sembra non finire mai; quando anche l’Italia entra in guerra Marc da cittadino ebreo e straniero diventa cittadino straniero e nemico. La vita della famiglia Rimon vacilla, si sposta, si separa, ma resiste, continua a scivolare veloce come un treno deragliato. Con il settembre 1943 tutto precipita nella confusione, il treno acquista velocità, dirottato verso un’ipotesi di salvezza in cui la possibilità della vita prende la forma della fuga e si sbiadiscono i contorni del concetto di casa.
In entrambi i libri la casa è un concetto fragile, precario, può crollare, bruciare, diventare improvvisamente luogo ostile, straniero. Entrambi i libri testimoniano di come il mondo possa cambiare in un istante, in una parola, di come la vita di chiunque possa essere pesata, valutata, umiliata, offesa e continuare comunque, come una bestemmia. Raccontano che dieci, cento, migliaia di vite possono essere negate semplicemente guardando da un’altra parte, che non c’è compassione se non per il singolo individuo, per un nome, un sorriso, una storia, ma che ovunque è possibile allestire una mensa, ovunque si può credere che sia ancora possibile ridere, giocare, esistere. Quello che questi libri rivelano è che non c’è orrore a cui sia impossibile sopravvivere, non c’è sopruso, violenza, peccato davanti al quale il mondo si fermi, non c’è abominio di fronte a cui l’umanità non sia capace di piegare lo sguardo e passare oltre. Questi libri ricordano che l’impotenza, l’ignoranza, la nostra stessa disgraziata finitezza non ci rendono meno responsabili del mondo in cui viviamo, che la sopravvivenza è un caso, così come trovarsi dalla parte giusta di un gioco crudele. Mostrano che la ribellione assume moltissime forme, così come la connivenza e che, tragicamente, ogni nostro movimento, ogni nostro respiro è una scelta e il mondo e la storia sono fatti di minuscole azioni e parole. Sono libri importanti perché ridisegnano sul nostro mondo i contorni del mondo passato, ricalcano strade già percorse e finite nel buio, tentano di sbarrarle, di impedirci di percorrerle a occhi chiusi, posano qualche segnale su grandi sterrati di domande impossibili e necessarie e ci avvertono di come non sia possibile andare avanti senza attraversarle.