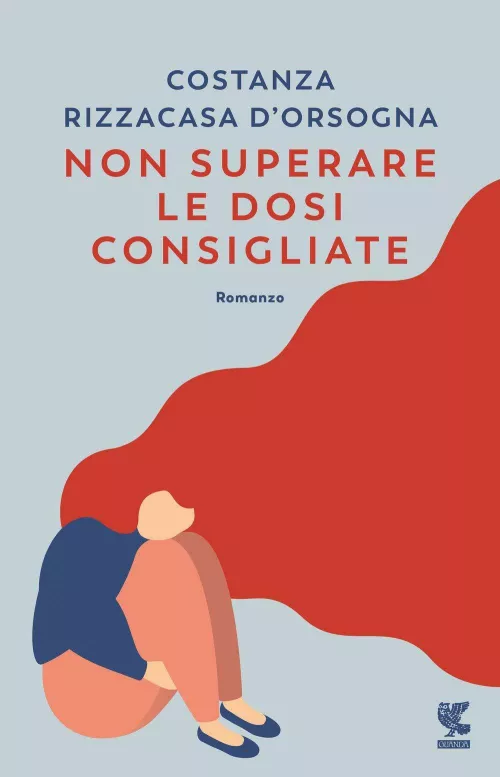Costanza Rizzacasa D'Orsogna / Non superare le dosi consigliate
Matilde, protagonista e voce narrante di Non superare le dosi consigliate di Costanza Rizzacasa D'Orsogna (Guanda, 2020), ha quarantaquattro anni e pesa centotrenta chili, quasi centotrentuno.
Matilde ha vissuto ingiustizie, fatiche, ambizioni, conquiste, perdite e lutti, e ogni cosa, mentre riaffiora nel suo racconto, pare immancabilmente legata alla massa del suo corpo.
A otto anni Matilde cena a mezzanotte quando il padre torna dal lavoro e si ritrova spesso sola, dimenticata nel refettorio della scuola delle suore, dove non c’è nulla di buono da mangiare.
A casa ruba il pane, scioglie la mollica sul palato e la invade un senso di pace e soddisfazione, poi spia il corpo nudo della madre piegato sul water in un bagno moderno, senza privacy e senza porte e ingoia i lassativi che la madre condivide con lei, perché è una bambina grassa, sbutriata.
Il lessico materno è intriso di dialetto siciliano e quando la descrive suona come una lingua violenta e spietata: ingorda, abulica, culona, balenottera bianca, cretina, cretina, cretina.
Per costruire l’immagine di sé Matilde non ha che lo sguardo deluso della madre e questo linguaggio che è giudizio di una forma sbagliata, imperfetta, irrimediabilmente tarata; il vuoto d’amore sembra stare in quello scarto, nella misura che la divide dalla perfezione e lì si annida anche la colpa.
Il corpo diventa il metro di tutto, anche dell’amore; cibo è tutto ciò lasciamo entrare, e quando non nutre annienta, e se non è abbastanza, crescono dipendenza e una fame senza rimedio.
Matilde comincia a ingrassare quando nasce il fratello (“Se c’è un momento, nell’infanzia, che scatena disturbi d’immagine e di peso, mio fratello è il mio. È il mio principio attivo, e a otto anni io lo odio”); a casa mancano molte cose, attenzioni, ascolto, dialogo, affetto, comprensione, non c’è amore a sufficienza e quel poco che c’è dev’essere ancora diviso.
Un senso di scarsità dilaga nella sua vita, la paura di non avere abbastanza di che nutrirsi, l’avidità, la gelosia, il bisogno d’attenzione, le dipendenze, il senso di colpa e un perfezionismo autodistruttivo.
E “se fossi un’erba cattiva?” si chiede Matilde, mentre coltiva l’idea che sanando le tare, estirpando la colpa originaria che si incarna continuamente nei suoi difetti e nei suoi errori, non potrà non ricevere amore.
Così cerca di riprendere il controllo sul proprio corpo, provando a modellarlo con i farmaci e con il cibo, per espulsione o privazione di ciò che lo riempie, di farne una forma malleabile, che può restringersi fino a lasciar affiorare le ossa dei fianchi (“the lovely bones”) oppure gonfiarsi, prendere densità fino a non vederlo più nel suo insieme, fino a perdercisi dentro, per sparire nel corpo, perché il corpo si espande fino a nasconderla o perché si fa così sottile da diventare quasi trasparente.

“Non c’è problema che un farmaco non curi, mamma lo dice sempre. A casa nostra non si parla, si prendono medicine”, scrive Matilde, ma nessuno le ha insegnato a dosare farmaci e cibo e il corpo si fa terreno di battaglia: tutto passa per il corpo che si lascia attraversare, anche quando si fa scudo, trincea.
A diciotto anni Matilde è magra come la madre e finalmente sono di nuovo complici, “come quando le voleva bene”, ma non è abbastanza. Inciampa Matilde, negli ostacoli che si trova davanti, fatica a mantenere l’equilibrio in una vita che non è mai a sua misura, che le toglie gli appigli e continua a negarle, nonostante gli sforzi, i successi e il dolore, quello sguardo d’amore e approvazione che le manca sin dal principio.
E così torna a riempire tutte quelle piccole e grandi voragini che le si aprono dentro e a cercare poi di liberarle di nuovo, in un gioco che affatica il corpo e lo lascia stremato.
E ci sono tanti segnali a guardia dei limiti da non attraversare, delle dosi da non superare, ancora “prima di quelli visibili sul corpo, prima che gli abiti comincino a tirare”: la trasandatezza, le luci spente per non vedersi nello specchio del bagno, la negligenza nella cura di sé, il corpo che non ci appartiene più, che è una scusa, una difesa, una punizione.
Tutto il romanzo è una corda tesa tra gli estremi opposti di una stessa caduta, manifestazioni fisiche di uno stesso dolore; è uno scavo verso l’interno, nella memoria delle ferite originarie e in ciò che da lì è venuto alla luce, un flusso di coscienza, o meglio una lunga seduta di autoanalisi, che spiralizza il proprio discorso oscillando tra autocritica, autoindulgenza e autoassoluzione.
È un tentativo di ricostruire le cause, di darsi ragione del proprio stare nel mondo, dell’occupare un posto che sta sempre stretto, ma anche quello di dar voce a un particolare tipo di sofferenza, meno familiare e meno compreso di altri disturbi alimentari: “se l’anoressia suscita compassione, tenerezza, senso di protezione, perfino l’invidia, quando si parla di binge (eating), quando si spiega cos’è il binge, perché tanti ancora non lo conoscono, le reazioni sono solo di disgusto.”
“Il perfezionismo viene associato all’anoressia, ed è per questo, al di là del canone estetico, che alle anoressiche è perdonato quasi tutto. Perché si sforzano di essere migliori, lottano per un ideale e ne portano i segni sul corpo. Ma anch’io porto i segni sul corpo. Nessuno ha mai pensato quand’ero obesa, che fossi una perfezionista.”
Tutta la vita ricostruita nel libro sembra guidata da un perfezionismo autolesionista e dalla paura di fallire, che finisce per coincidere con la colpa e con la mancanza d’amore.
La scrittura autobiografica del libro di Costanza Rizzacasa D'Orsogna, esplicita e personale, sembra voler forzare lo sguardo laddove solitamente lo si distoglie, pare escludere cure o rimedi e spingersi verso il fondo, fino al punto dove nasce la sofferenza per poi guardarla produrre i suoi effetti nel corso della propria vita.
Ma la stessa qualità intima e autobiografica della voce narrante è anche ciò che rende tutto individuale e in qualche modo parziale, spingendoci verso una prospettiva così ravvicinata da smarrire i contorni di una storia compiuta.
E si arriva alla fine in qualche modo disorientati, ma con la sensazione di essere stati molto vicini al dolore di qualcuno, di averne ascoltato le confidenze da una posizione un po’ scomoda, perché sempre fuori da un racconto che sembra rivolto soprattutto verso chi parla.
C’è però, reso esplicito e depositato nelle pagine, un desiderio di riscatto che pare riconfermarne il significato in un senso intimamente personale. Il libro finisce come si svolge, dentro una questione privata, e non cerca risposte in chi legge, né tanto meno mette ordine nella materia narrativa che ha generato, ma forse neppure si propone di farlo, perché, sostiene Matilde, tutte “le vite sono disordinate. Sono eccessive e sregolate. Come me”, e la forza e la motivazione del romanzo stanno forse in questa rivendicazione, nel farsi discorso e nel portare questo discorso fuori di sé, nel raccontare la propria storia ad alta voce per possederla, per riconquistare gli anni che sembrano perduti e, nella condivisione, accettarli e passare oltre.