Mengaldo / Franco Fortini: il Super Io
Siccome quando discutono della poesia dell’ultimo mezzo secolo non sono d’accordo su nulla, e anzi nemmeno si capiscono, i letterati italiani continuano a raccontarsi come una favola rassicurante la storia del pieno Novecento, che magari giudicano in modi opposti, ma la cui trama sembra a tutti abbastanza chiara. E a forza di raccontarla, alcuni dei suoi protagonisti ne escono fuori stilizzati come i caratteri di un dramma. Tra i poeti che hanno avuto un ruolo pubblico rilevante dal dopoguerra agli anni Settanta, si potrebbe dire che Franco Fortini rappresenta il Super-Io, Pier Paolo Pasolini l’Es, e Vittorio Sereni l’Io. Super-Io ed Es appaiono imponenti, ma non provocano la partecipazione emotiva che i lettori dimostrano davanti al fragile Io sereniano, il cui fascino sta nella scelta di descrivere i rovelli esistenziali senza sublimarli teoricamente, cioè senza porsi al di sopra dell’esperienza scontata in prima persona. Fortini e Pasolini vengono considerati due indici culturali, piuttosto che due scrittori da leggere lasciando che le loro parole reagiscano spontaneamente con le vicende della propria vita. Anche perché fanno tutto da soli: piantano ovunque dei cartelli segnaletici. Troppo impazienti per rispettare lo svolgimento di quella dialettica a cui rendono un ininterrotto omaggio, mettono sempre in bella vista i rispettivi ossimori e costumi manieristi, che Pasolini afferra in fretta al primo bazar on the road per drogare le sue doti espressive, e che Fortini utilizza viceversa per reprimerle – tanto che i meno accorti lo credono poeta a furia di volontà, mentre al contrario la sua volontà non fa che frustrare gli estri di una natura versatile e talentuosa quanto e più di quella pasoliniana. L’uno offre come garanzia e integrazione dei propri abbozzi incompiuti un personaggio; l’altro distingue ostinato i livelli del discorso, mostrando a nudo il sistema di tubi retorici che collegano e separano i vari generi che pratica.
Fortini ha criticato acutamente il doppio gioco, tipico delle personalità pedagogico-carismatiche, con cui Pasolini chiede di essere preso alla lettera e insieme fugge nella metafora, saltando dall’una all’altra a seconda che debba giustificare la debolezza di una soluzione poetica o di una diagnosi politica. Ma una mistificazione analoga emerge anche nell’autore di Verifica dei poteri. Pur con tutta l’insistenza su uno stile antisuggestivo, Fortini avvolge le sue pagine in un’altra suggestione, quella dell’“ospite ingrato” strenuamente dialettico. Anche lui avverte il bisogno di esibire una certa identità, e di marcare le posizioni con un gesto che finisce per risultare più significativo dell’argomento in gioco. E c’è un’aggravante. Si può essere più o meno consapevoli della storia collettiva in cui ci si muove, e più o meno capaci di combattere le sue mezze verità o la falsa coscienza che induce a coltivare. Ma la recita di chi, come Fortini, ostenta la consapevolezza storica a ogni riga, tende a trasformarsi in una posa di sublime bovarismo. Oltretutto, nel tardo ventesimo secolo questa recita rafforza proprio una delle ideologie più chiaramente legate allo spirito del tempo, ossia la convinzione, subito volta in ricatto, che fuori da un tale sfoggio di controllo non restino che l’ingenuità o la complicità con lo stato di cose presente. Si tratta di una convinzione facilmente riscontrabile negli interlocutori a cui Fortini, tra la maturità e la vecchiaia, si è sentito costretto a render conto delle sue mosse appunto come chi si lascia ricattare. Tra l’altro, visto il crollo generalizzato della coscienza storica, questo pregiudizio si è presto svuotato di contenuto. Così, ecco la nemesi: l’intellettuale che pretendeva di sottoporre anche la minima molecola del discorso alla verifica di compagni altrettanto intransigenti, viene oggi mitizzato da studiosi che ammirano la complicazione dei suoi libri come si ammira un geroglifico venerabile perché incomprensibile, e che mentre si esaltano per certe sue astratte proposte di ideologo rimuovono istintivamente le domande del critico dell’ideologia, ancora a tal punto attuali da rischiare di compromettere il loro lavoro.
Nell’oratoria fortiniana, le giunture tra i differenti piani di un testo possono a volte produrre un effetto di comicità involontaria. “Caduta Saigon, cenavo con Mario Tronti” citava perfidamente Garboli, indicando in quell’ablativo assoluto una mostruosa unione di Quintiliano e Lenin. E che cos’è questo se non un personaggio, costruito con la stessa ossessività narcisistica che si attribuisce giustamente a Pasolini? “Aveva torto e non avevo ragione”, ha detto il vecchio Fortini riflettendo sulle loro polemiche. Ma questa non-ragione dipende anche da un’incessante costruzione della propria immagine per via di accumulo dialettico. Più in generale dipende dal procedere tortuoso di chi, pur volendo pesare con scrupolo persino il più lieve granello di polvere storica sulla bilancia del valore, arriva spesso a stabilire misure e giudizi inaccettabili in primo luogo davanti ai fenomeni epocali più drammatici. La scrittura di Fortini, con i suoi dribbling vertiginosi, implica infatti una tale cavillosa rete di distinguo tra il dibattito con la propria parte e lo scontro con gli avversari, che si condanna quasi sempre all’impossibilità di accogliere le verità elementari care a Orwell solo perché sarebbero strumentalizzabili dal fronte opposto. Come ogni elaborazione di sofisticato settarismo, anche i ‘comizi’ fortiniani per élite di sinistra via via più immaginarie hanno qualcosa di ipnotico.
Se si rimane dentro il loro circolo argomentativo, tutto torna - ma basta mettere un piede fuori e se ne vedono le capziosità, oltre che le angustie. Ecco perché anche chi non condivide l’approccio di Garboli può meditare utilmente sul suo rifiuto di lasciarsi attrarre nel labirinto mentale dell’ospite ingrato. Ma siccome vale la pena di correre il rischio, io direi piuttosto che dopo averne esplorato le sottigliezze bisogna rifare il percorso a ritroso e fingere di non capirle, o contestarle con una rozzezza studiata. È un antidoto alla violenza dialettica che Fortini, come Adorno, conosce benissimo, ma che dimentica non appena teme possa appannare la sua sagoma di colonnello del marxismo eretico. Pier Vincenzo Mengaldo, il quale pure gli è stato molto vicino, ha scritto del suo discorso critico “che, per il suo carattere folgorante e sapienziale, contiene sempre alcunché di costrittivo e quasi di autoritario, cui si vorrebbe sottrarsi”, e ha riconosciuto l’eccesso d’enfasi con cui Fortini dichiara il proprio compito testimoniale in nome dei “destini generali” o degli esseri umani ammutoliti dalla Storia. Sono tratti che in altra forma si ritrovano in Pasolini: e infatti, in uno di quegli epigrammi che considera il fiore della critica più alta, Mengaldo paragona felicemente i due ai “teologi nemici e medesimi di cui parla Borges in un suo racconto”.
Traggo entrambe le citazioni da I chiusi inchiostri, un volume Quodlibet nel quale il critico e filologo, come già aveva fatto per Sereni, riunisce oggi i suoi scritti dedicati all’amico, facendoli scortare da un saggio di Donatello Santarone. Siamo di fronte a una galleria ampia e variegata, che va dall’introduzione stesa nel ’74 per le Poesie scelte a una recente nota sulla traduzione del miltoniano Lycidas, e che comprende tra l’altro la recensione all’antologia fortiniana del 1977 sui poeti italiani del Novecento, il profilo compreso nell’antologia di Mengaldo uscita l’anno dopo (e da quella di Fortini non poco influenzata), qualche appunto sul critico, una lettera aperta al poeta, un saggio esaustivo sulla raccolta del ’73 Questo muro, diverse indagini sulle dominanti stilistiche, più alcune analisi di singoli testi (come il ritratto del vecchio Lukács, che si potrebbe confrontare con il ritratto del vecchio Saba schizzato in una famosa poesia di Sereni). Mengaldo cerca di leggere Fortini come un Io, sfatando le leggende diffuse intorno allo scrittore, senza tuttavia eludere le richieste non soltanto letterarie che ci vengono dall’opera. Uno dei temi ricorrenti è ad esempio quello dei modi in cui la sua militanza di intellettuale può ostacolare la comprensione dei suoi versi. Il critico esclude la priorità di una vocazione sull’altra, e parla di “due parallele che s’incontrano”: ideologia e poesia procedono ognuna con una sua logica, eppure entrano anche in conflitto, nutrendosi a vicenda e insieme rischiando di mettere reciprocamente in dubbio la loro legittimità.
Partiamo dal Fortini saggista. Nelle sue raccolte il discorso sulla società coabita con il discorso sulla letteratura, e in particolare su quelle caratteristiche formali della poesia a cui riserva un’attenzione rara tra i critici marxisti. Si potrebbe anzi dire che i due discorsi funzionano l’uno per l’altro da testo a fronte. E dato che Mengaldo inclina allo specialismo, gli fa onore insistere a questo proposito sull’idea fortiniana della critica come mediazione “non fra autore e lettore ma fra l’opera e quel che l’opera non è”, ovvero come confronto tra il sistema di valori dell’opera e sistemi differenti o differenti ambiti dell’esistenza. Per Fortini il genere della critica è il saggio, che denuncia la falsa totalità esprimendo la nostalgia di quella vera. “Con un po’ di audacia si potrebbe dire che i segni dell’opera letteraria e il rapporto, essenziale per Fortini, tra ciò che essa è, dice e ciò che tace non sono di natura diversa da quanto suggeriscono le mani di Radek, fra il poco che l’immagine conserva e il molto che ne è cancellato”, spiega Mengaldo alludendo a un celebre pezzo dell’amico che prende avvio dal filmato in cui Stalin ha fatto cancellare la sagoma del dirigente sovietico, ma in cui per un errore le sue mani si agitano ancora accanto a Lenin. Il saggio permette a Fortini di saltare rapidamente dalle minute osservazioni sulla forma al campo lungo della società, senza quasi passare per la descrizione del ceto letterario.
Non credendo nella teoria dell’arte come rispecchiamento, Fortini evita infatti il livello sociologico: piuttosto estrae i caratteri sociali da quelli formali o istituisce fulminei parallelismi, magari tra gli istituti metrici e il contesto storico. In questa attitudine, e nella preminenza assegnata alla lirica rispetto alla narrativa, si può misurare la sua distanza dall’ammiratissimo Lukács. Come Adorno, Fortini privilegia un’arte utopica e antimimetica, che incorpori i riflessi dell’epoca nel prisma di una forma antagonistica; e tuttavia di Adorno non accetta né il rinvio sine die della prassi politica, né la tendenza a vedere nell’arte moderna un’unica linea di ricerca aristocratica destinata all’invecchiamento. Brechtianamente, ritiene che la storia contenga molte storie: le tecniche apparentemente arretrate possono sempre tornare buone, e comunque l’autentica poesia, agendo coi mezzi di bordo, sa trasfigurare anche i materiali più poveri. In sostanza, nella critica e nella visione del mondo di Fortini le prospettive lukacsiana e adorniana coesistono senza confondersi. Come l’autore di Storia e coscienza di classe, l’italiano avverte l’esigenza di traghettare l’eredità dell’umanesimo al di là della borghesia, e d’inverarne le speranze migliori in una società marxisticamente liberata; ma come l’autore della Dialettica negativa, ipotizza che la liberazione potrebbe consistere in una cesura così traumatica da rendere muto il linguaggio della preistoria. È una compresenza visibile anche nell’alternanza di argomentazione estesa e aforisma isolato su cui si sofferma Mengaldo; e altre spie, nell’intera opera fortiniana, sono due termini chiave come “adempiersi” e “tutto”, che invocano il recupero di un’umanità integrale, ma al tempo stesso compaiono in contesti in cui l’integrità sembra esigere un salto nel buio, il passaggio obbligato della morte.
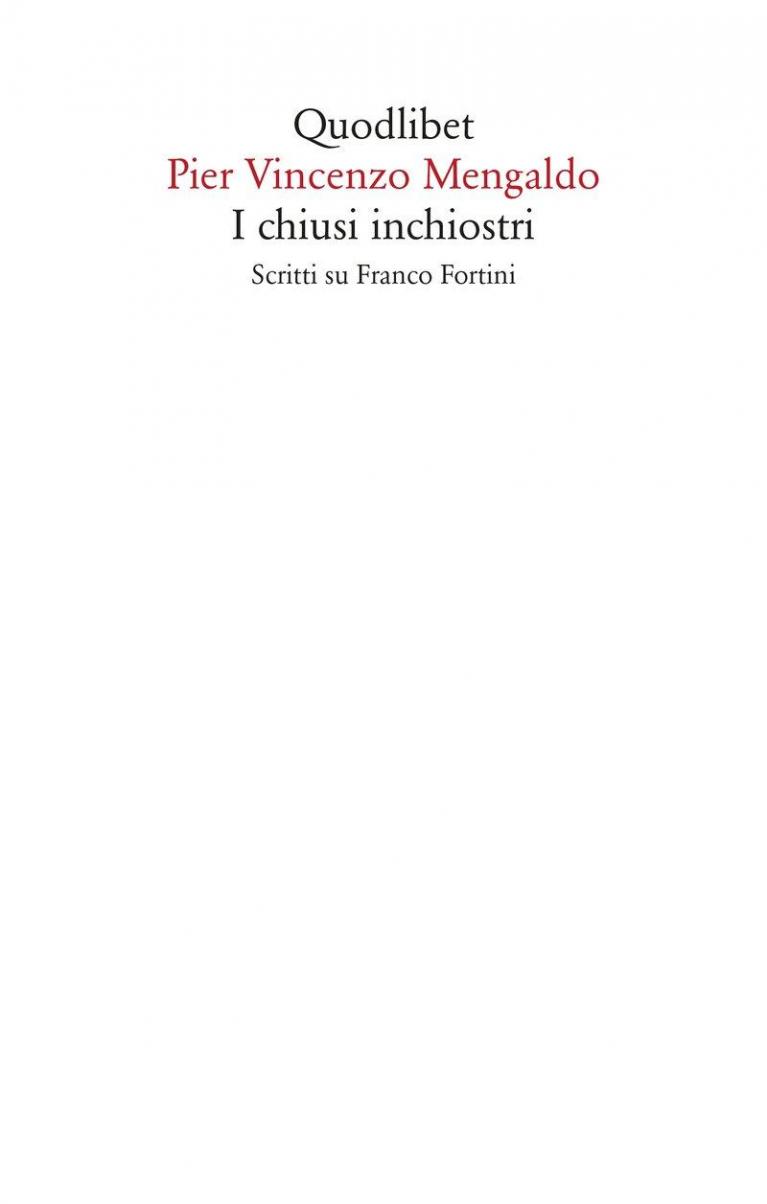
A prescindere dalle loro filosofie della storia, sia Lukács che Adorno sono per Fortini due modelli di saggistica. Il saggio richiede di mettere in gioco la biografia, più l’immaginazione; e in effetti, nonostante il suo poderoso sistema inibitorio, il Fortini critico e ideologo è a volte quasi più lirico del poeta. Questo però dipende anche dalla sua concezione della poesia. Sebbene il genere offra di per sé garanzie dialettiche, data la costitutiva doppiezza di ogni parola pronunciata in campo estetico, è pur sempre il luogo in cui l’io tende a dilagare senza limiti; perciò l’autore ci tiene a schermarlo dal soggettivismo assai più di quanto non faccia per i ragionamenti in prosa su comunismo e anarchia o su Leopardi e Manzoni. L’obiettivo è quello di ricordare che il far versi è un’attività tra le altre, parziale e limitata, e che bisogna guardarsi dal confonderla con l’assoluto. Citando un titolo del secolo forse più presente alla fantasia di Fortini, Mengaldo parla della sua lirica come del “luogo della necessaria lontananza mediatrice, per non dire della riserva mentale e della dissimulazione onesta”. “Quanto più preme una rovente materia esistenziale”, osserva già nel ’74, “tanto più Fortini affida alla poesia non già il ruolo dell’immediatezza individuale d’espressione, ma quello della mediazione oggettiva e indiretta”. Questa prospettiva pesa anche sul modo di avvicinarsi ai versi altrui. Fortini è disponibile a dar credito a opere lontanissime dalla sua: a patto però che gli autori si mostrino bene armati, e che lascino intravedere i mezzi di oggettivazione o mediazione con cui, magari loro malgrado, mettono in discussione lo statuto della lirica mentre ne dànno un esempio, rivelandone il carattere di tessera spezzata che invoca in eterno il tassello mancante dell’altra esperienza umana. Il critico marxista diffida invece delle prove di sapiente e sublime ‘ingenuità’, persino quando sono eccezionali: il che spiega perché, pur insistendo sul fatto che la gerarchia di valore dei poeti non coincide con gli sviluppi storici del genere, così come le attuazioni non coincidono con i programmi, finisce per sminuire il grandissimo Sandro Penna, a cui Mengaldo, basandosi sulle sue distinzioni, assegna nella propria antologia uno spazio più adeguato.
Se nel comporre un saggio ideologico o critico occorre vigilare perché la dialettica non rimuova la parte notturna della vita, ossia quella natura leopardiana che nessuna rivoluzione può sconfiggere, nel tentare la via della poesia, subito pronta a identificare la sua storicità con la vita e la natura, è al contrario una dialettica severa che deve ridimensionare la parte dell’individuo. Di questa esigenza è sintomo il frequente susseguirsi, nelle poesie fortiniane, di affermazioni e negazioni, a volte associate alla correctio. Insomma: malgrado i versi siano per essenza indiretti, Fortini vuole al solito dimostrare di essere ben consapevole di ciò che sta facendo. Spesso si ritrae mentre evita le trappole romantiche: addita con straniamento brechtiano gli strumenti usati, e segnala solennemente con un verbo la posizione dell’io rispetto alla realtà. Ne risulta una sorta di esposizione della poesia. In questo senso va interpretato il rovesciamento del surrealismo – tanto più necessario, a opinione dell’autore, in quanto nella seconda metà del Novecento non è più un’avanguardia letteraria ma il modo comune della percezione. In Fortini, ricorda Mengaldo, la poetica surrealista “dell’invasione dell’inconscio nella ragione” diviene infatti “poetica dell’assorbimento del primo nella seconda per via di simboli concettualizzabili”. Elaborando una forma artistica, che dovrebbe essere figura di un futuro “uso formale della vita”, non si deve mai dimenticare che insieme all’istanza di Rimbaud c’è l’istanza di Marx: bisogna cioè evitare che da anticipazione la poesia si trasformi in alibi, in un surrogato della politica o della fede.
Secondo lo schema dialettico consueto, nei saggi fortiniani questa preoccupazione si traduce in una doppia polemica: mentre da una parte, contro gli Asor Rosa, l’autore rifiuta di liquidare la poesia in nome della sua bellezza utopica, dall’altra ribadisce agli spiritualisti che non è una religione. Nei versi, invece, esprime il suo tema appunto razionalizzando la magia poetica dall’interno. L’esito è quel classicismo paradossale, tra virgolette, che Mengaldo analizza in più di un contributo, e che ha l’effetto di impedire un’adesione immediata al presente o quasi di derealizzarlo. Ma in realtà questo “classicismo”, con la sua nitidezza e il suo “gusto della punta secca”, come ogni classicismo venuto dopo l’età romantica, si basa su un altrettanto peculiare “manierismo”. A differenza dei postmoderni più tipici, però, Fortini non sembra disponibile a flirtare disinvoltamente con il complesso del patrimonio storico: compie scelte drastiche, e si direbbe militari. Ripesca forme “ben morte”, che non possano quindi sembrare arretrate; e assorbe o strania una serie di luoghi letterari distanti dalla linea egemone della modernità simbolista. Spiccano tra le tracce più evidenti: un Brecht devitalizzato; la parabola cinese, s’intende filtrata anche dal poeta tedesco; un Seicento raggelato in chiave poussiniana; l’eloquenza perentoria della Bibbia; e il grande deposito di Tasso, con i suoi brividi gelidi e gli ossimori a cascata, con la concentrazione di troppe materie in uno spazio minimo e le più varie citazioni amalgamate in pochi versi, ma soprattutto con il tentativo vano di ridurre a unità un mondo scisso (in una dichiarazione interessante, ripresa da Santarone, Fortini afferma che in gioventù l’attrazione per il manierismo letterario e pittorico del Cinquecento gli ha permesso di ignorare D’Annunzio).
Queste e altre eredità, uniformate da una vernice metallica e traslucida, comunicano l’impressione che i testi alludano sempre ad altro, e che il loro autore, del resto incline alla “imitazione” e al “rifacimento”, mantenga nei loro confronti un distacco da traduttore (così nei saggi l’abuso del corsivo fa l’effetto di un intarsio di citazioni). Ma anche al di là delle fonti, letterarie o politiche, “il testo fortiniano tende a essere molto vestito”. Ed è vestito di una stoffa in cui non si vedono le cuciture. Fortini evita con cura le toppe vivaci, ‘espressioniste’: nella sua poesia “l’escursione lessicale e i mutamenti di registro tendono a instaurarsi di massima da testo a testo, non all’interno del medesimo testo, governato tendenzialmente da una struttura monolinguistica”, annota Mengaldo; e aggiunge che “l’assunzione di terminologie settoriali-speciali (in particolare quella dei politici) non è molecolare, ma trasferisce generalmente interi brani o almeno intere frasi: non si ha perciò lavoro di mosaico, ma citazione o parafrasi”.
Il lessico, si tratti di natura o industria, di “erbe” o di “ossidi”, più che delle realtà concrete designa delle essenze. Fortini aspira al quadro incolore, e a volte al negativo fotografico evocato qui dal suo interprete; oppure sintetizza delle tinte nette, araldiche. In un modo o nell’altro, il suo paesaggio si mentalizza, e “gli oggetti si coagulano antirealisticamente in una fissità glittica e spettrale”. La coagulazione avviene in genere attraverso il razionalismo della sintassi, e magari attraverso l’ordine ironico del metro, che pure funziona da contravveleno all’espressività libera. A prevalere sono “le strofette melodiche di versi brevi, dove il ‘tempo’ è regolato come una costante e quindi l’effetto ritmico è scontato a priori”, o “le sequenze di versi lunghi che impongono un respiro ritmico uguale e disaccentato ed esaltano l’articolazione delle unità sintattiche”. Di solito la canzonetta veicola ossimoricamente la descrizione dell’orrore, mentre il verso-frase, percussivo e scandito, trasforma la descrizione in giudizio. Un caso molto frequente è quello in cui la forma metrica si riduce a un mero perimetro per gli occhi, secondo un procedimento che Mengaldo associa al gusto grafico di Fortini. Ossessionato dal contesto, il poeta privilegia comunque il piano ritmico-sintattico. Contro l’espressività, per la costruttività, potrebbe essere il suo slogan. Ma si tratta, va da sé, di architetture internamente crepate: “una sintesi”, scrive ancora benissimo Mengaldo, “fra la costruzione discontinua dei moderni e quella continua dei poeti della ragione”, da cui risulta “una struttura a giustapposizioni, o meglio a gradini”.

Dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, il corrispettivo più adeguato di questa struttura è una tecnica prettamente novecentesca, ovvero la spazializzazione della storia. I riferimenti alle epoche e alle circostanze più eterogenee, col loro fortiniano peso di tragedia, vengono spesso riuniti in uno scenario invernale o in un falso idillio libresco. “Tutti i fiori non sono che scene ironiche” dice un verso citato più volte da Mengaldo. Sotto una quieta indifferenza, in certe liriche s’intravedono un ghigno sardonico e soprattutto una lacerazione mortale, come nell’ekphrasis bruegeliana di Auden o appunto nel paesaggio con serpente di Poussin a cui Fortini ha intitolato una sua raccolta. L’innaturalezza coincide allora con una calma assurda, agghiacciante e nitida, e con un dettato tranquillo o quasi pedante, ma costellato qua e là da esclamativi ancora più innaturali, che fanno pensare allo sforzo di chi salta sul posto. Così è la normalità del nostro mondo schizofrenico – quello che la poesia di Composita solvantur da cui viene il titolo del volume mengaldiano contesta in maniera esplicitamente grottesca, ma che nei componimenti maggiori è tenuto nella misura di una illustrazione: da una parte la pace bucolica dell’Occidente protetto, per cui l’intera realtà è testo; dall’altra parte, a garantirgli “un’aperta veduta e i chiusi inchiostri”, il sangue rimosso e vero degli scontri geopolitici. Vaste epopee di popoli (la Cina maoista, l’Urss, le guerre di religione) vengono pigiate in un unico quadro insieme con episodi di quotidianità mediocre come quelli che Mengaldo ritrova in altri poeti milanesi: un pranzo tra amici, un’occhiata al cortile… A una certa altezza, però, le epopee cominciano a essere soltanto alluse. Più la sua violenza si fa ineluttabile, più la Storia somiglia a “un Dio nascosto”. Da Questo muro all’ultima raccolta il suo volto si cela via via nelle piccole scene domestiche, prende le sembianze trasparenti e ingannevoli della natura.
Con un illimpidimento atroce del suo classicismo manierista, Fortini registra così una situazione in cui la prassi politica che auspica è divenuta impraticabile. Allora davvero il presente “non è che simbolo”: la irreale geometria di linee dietro un vetro, l’allegoria di una Storia pietrificata a cui la poesia rimanda riassumendo in cifra il passato e sporgendosi astratta sul futuro. “Di qui il paradosso per il quale questa poesia, continuamente e quasi accanitamente aggiustata sul millimetro e l’attimo dei fatti storici contingenti, finisce per proiettarli come ombre cinesi sul telone bianco di una metastoria trascendente”, chiosa Mengaldo, “quasi che Fortini abbia fatta propria fino in fondo la terribile sentenza marxiana che ogni storia, prima della consumazione del comunismo, non è che preistoria; e il corso storico, che l’ideologo razionalizza come continuità concatenata, nella pagina del poeta affiora come discontinuità e intermittenza”.
A questo punto proviamo a mettere i dati in fila: la Storia come allegoria, che ragionevolmente il critico connette al retroterra ebraico-cristiano dell’autore; la durata della tradizione ricondotta a sua volta a un’esistenza simultanea, di secondo grado; il marxismo ‘bloccato’ che perde presa sulla collettività e rischia di ridursi a una scommessa individuale; le contraddizioni, le dispute ideologiche e le tragedie novecentesche rappresentate attraverso quelle del Cinque-Seicento. L’insieme evoca luoghi molto frequentati da Fortini, come del resto da buona parte della cultura letteraria del secolo scorso. Benjamin, certo. Ma io credo che si possa fare anche un altro nome, più legato all’officina della poesia. Portata avanti con strumenti ideologici e formali ovviamente diversi e opposti, l’operazione di Fortini è forse quella che in Italia più ricorda l’opera di Eliot. Non Montale, con il suo Novecento generico, ma lo scrittore comunista della Poesia delle rose e di Verifica dei poteri si propone un programma paragonabile al percorso del pontefice conservatore della poesia inglese. Anche Fortini tende a una scrittura metafisica, oltre che allegorica; anche lui riprende Dante con occhio di tattico e di stratega; anche lui stabilisce un rapporto calcolato fin nei dettagli tra scelte ideologiche, critiche e poetiche; anche lui prova a ritradurre la storia profana in storia sacra; e anche lui prova a dare un senso religioso ai revenants senza pace, agli incubi, alla solitudine, ai frammenti in apparenza irrelati della vita privata e sociale, a una speranza che ristagna e a un pensiero che si ripiega angosciosamente su sé stesso (si pensi al fantasma della sestina di cui parla Mengaldo, alla sua ripetizione tormentosa come correlativo dello stallo, o ai paesaggi aridi e alle loro pietre dantesche quanto tassiane).
Ma torniamo dalle opinioni di chi scrive ai Chiusi inchiostri. Dopo avere citato solo alcuni dei tanti spunti che il volume ci fornisce a proposito dell’opera di Franco Fortini, vorrei concludere con qualche parola dedicata al suo critico, di cui pure ci offre implicitamente un’immagine abbastanza completa. Come può constatare il lettore di questi saggi, Mengaldo è capace di osservazioni di prim’ordine sia dove usa lo zoom sia dove inquadra gli oggetti col grandangolo. Può scoprire che in Fortini la consonanza è “più rilevata dell’assonanza”, collegando il fatto all’“intenzionale prevalere dell’asprezza” sulla “dolcezza”; oppure, allargando in ogni senso il discorso, e proponendo uno di quei diagrammi storici nella cui costruzione è maestro, può farci notare che mentre tra i crepuscolari d’inizio Novecento e tra gli “affabulatori dell’assoluto privato” egemoni alla fine del secolo scarseggiano le attività metapoetiche, dagli anni Venti ai Settanta il tipico poeta novecentesco è un traduttore e un critico. E a proposito di traduzione, quando indica nel Lycidas il capolavoro fortiniano gli capita di enunciare in due righe una teoria notevole, ipotizzando che le versioni da una lingua straniera tendano a riuscire meglio se l’autore ne ha una conoscenza limitata e se questa lingua è strutturalmente distante dalla sua. Sono osservazioni, oltre che intelligentissime, eleganti, nel senso in cui si dice che è elegante un teorema capace di dar conto con economia di molti dati sparsi. Tutto, insomma, funziona perfettamente; almeno finché il critico-filologo si muove nei pressi dei testi o della cultura estetica in cui i testi affondano le loro radici. Perché appena si volge a una realtà più vasta, sociale ed esistenziale, bisogna ammettere che le sue idee appaiono meno originali, non di rado desunte proprio da Fortini o da Cesare Cases. E com’è naturale, la minore originalità risulta più visibile da quando gli sono venuti a mancare gli aggiornamenti del loro marxismo eretico. Ma nel caso, anche questa debolezza diventa un omaggio di Mengaldo al suo difficile amico.









