
Speciale
Evidenza
Non ho mai avuto la barba, non ho mai avuto un corno in mezzo alla fronte, non sono mai stato in prigione (a tutt'oggi), non sono mai stato sulla cima dell'Everest: lo so. So inoltre che di tutte e quattro le circostanze, persino di quella anatomicamente più inverosimile, può essere prodotta una convincente pseudotestimonianza fotografica con strumenti di manipolazione iconica già esistenti da molto tempo – dal cosiddetto "fotomontaggio" al più aggiornato Photoshop. So infine che pseudotestimonianze analoghe ora possono essere generate via AI. Le modalità sono differenti non soltanto dal punto di vista produttivo. Non si tratta più dell'intenzione di produrre un'immagine falsa di me, per poi farne un uso ostile e fraudolento (come nella contraffazione: "provare" che sono stato in prigione) o al contrario ironico e ludico (come per una caricatura o per un travestimento carnevalesco). Si tratta di conferire al campo delle mie possibili immagini un'estensione di apertura indeterminata: delle mie come di quelle di chiunque e di qualunque altro soggetto; in immagini ferme come nelle fotografie o in movimento come nei video. Sole e irrisorie condizioni produttive: saper immaginare e saper trasmettere a un dispositivo di Intelligenza Artificiale quel che si è immaginato in un comando (un prompt).
Nel suo classico Fantasia Bruno Munari definisce a modo suo la differenza tra Fantasia e Immaginazione: la Fantasia "è libera di pensare qualunque cosa, anche la più assurda, incredibile, impossibile", mentre l'Immaginazione deve invece rendere visibile quello che la Fantasia ha prodotto e non sempre può: "una motocicletta di vetro si può pure immaginare" dice Munari ma se si pensa a una motocicletta d'acqua "questa non appare visibile". Può essere che l'esempio che ha scelto non sia perfetto e che già un illustratore o un animatore di cartoons possano mostrare una moto d'acqua. Sta di fatto che l'immagine si ottiene facilmente con un banale programma per la generazione di immagini che non manca di rispondere neppure al prompt "Disegna un cerchio quadrato". Vuol dire che è crollato il confine tra Fantasia e Immaginazione?
Avvertiamo che il passaggio all'AI non si può ridurre allo scarto dal cinema realistico dei fratelli Lumière a quello poetico e illusionista di Georges Méliès o all'industria ludica di Walt Disney. No, la novità è di quelle che implicano un cambio di dimensione ed è necessario disporsi a comprendere cosa questo cambio di dimensione implichi a sua volta.
Quali domande dobbiamo porci di fronte ai cambiamenti piccoli e grandi? Questo è stato il tema dell'ultima avventura intellettuale di Marshall McLuhan. Con l'intento di aggiornare il suo classico Understanding Media McLuhan scoprì (o perlomeno credette di scoprire) quattro leggi immutabili e onnipresenti, per accorgersi in seguito che queste si applicavano a ogni sorta di innovazione. Dall'Abaco allo Zoom, dalla lavorazione neolitica dell'ossidiana all'esplorazione di Marte, dai ritrovati delle telecomunicazioni alle dottrine scientifiche tali leggi sono in vigore per ogni nuovo elemento materiale, tecnico, ideale che l'ingegno umano introduce nel panorama. Di qualsiasi sorta essa sia, la novità non si limita (come normalmente si crede) ad accrescere una facoltà umana (prima legge) e a superare una condizione precedente (seconda legge): consente anche il recupero di qualcosa che era caduto nell'oblio (terza legge) e, quando è portata all'estremo, produce un proprio ribaltamento (quarta legge). È un principio tetradico che suggerisce di catalogare le innovazioni rispondendo a quattro domande: quale Amplificazione, quale Obsolescenza, quale Recupero e quale Capovolgimento sono comportati da questa novità?
In due libri usciti postumi, curati e cofirmati dal figlio Erich – il grande e grandemente bizzarro massmediologo applica il metodo tetradico a un'intera enciclopedia dello scibile: all'ascensore, al secondo principio della termodinamica, alla forma repubblicana dello stato, alla doccia, all'omosessualità, alla Tv via cavo, alla forchetta, alla fotografia, all'ermeneutica e persino al sogno. La tetrade della bussola è un buon esempio: la bussola amplifica le possibilità di navigazione, rende obsoleta la consultazione delle stelle e con ciò recupera la visione poetica dell'astronomia, mentre – quando è portata all'estremo – produce il sistema di navigazione inerziale (in quanto del tutto automatico). Un esempio più sorprendente è quello delle droghe, che amplificano la tolleranza del dolore e superano con ciò la pregnanza dei sintomi, recuperano il senso di isolamento protetto della vita fetale e si capovolgono, divenendo da rimedio circostanziale, intero stile di vita.
Il tipo di esposizione, che ricorda più gli haiku o l'I Ching che un trattato sistematico, ci aiuta a non prendere alla lettera le affermazioni che McLuhan presenta in forma aforistica e lapidaria, senza ulteriori argomentazioni. Non manchiamo però di accogliere la suggestione di questo modo di guardare alle innovazioni.
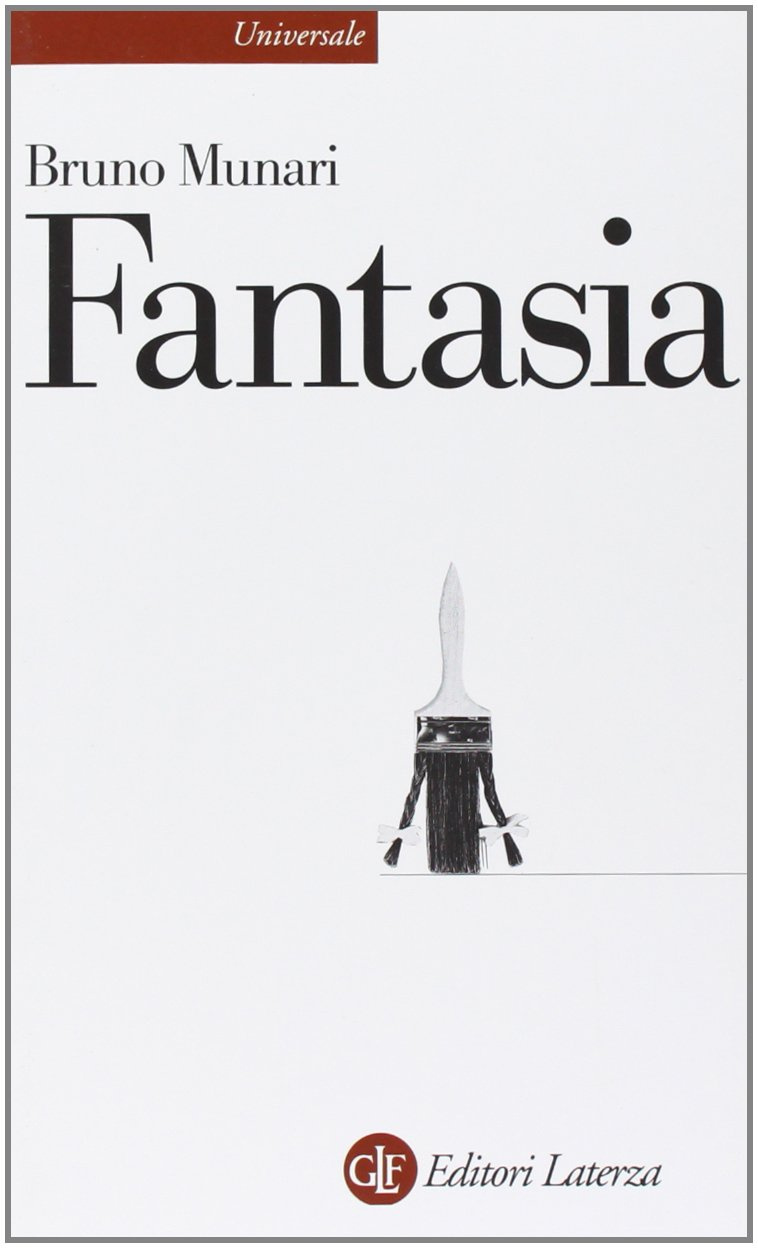
Non trovo al momento una tetrade sulla bomba nucleare in McLuhan, ma provo a costruirla io. Ha accresciuto la capacità dell'essere umano di distruggere l'ecosistema che ne rende possibile l'esistenza. Ha reso obsolescenti le guerre dirette tra le potenze nucleari nemiche. Ha recuperato la diplomazia e le guerre locali con armi convenzionali. Portata alle estreme conseguenze, si è rovesciata nella deterrenza.
Quale sarebbe allora il soggetto principale della tetrade sulla generazione di immagini in AI? La prima coppia, Amplificazione e Obsolescenza, non ha bisogno di molti pensieri e fronzoli: ciò che si amplifica è innanzitutto la possibilità di produrre immagini realistiche (sino all'illusionismo) a partire da pensieri di tipo fantastico, mentre ciò che va in obsolescenza sono i metodi tradizionali di manipolazione delle immagini, a partire dal fotomontaggio. Ma a essere interessanti sono la terza e quarta domanda della tetrade: Recupero e Capovolgimento.
Per il mondo antico, l'invisibile non aveva connotazioni di irrealtà: il piano di realtà degli dei e degli esseri invisibili era distinto da quello umano ma il transito era consentito – basti pensare alle unioni feconde fra esseri umani e dèi – e l'invisibilità degli dèi era più una prova della loro esistenza che la sua confutazione. Dall'invenzione della prospettiva pittorica all'Illuminismo, il primato della vista – già implicito nel mito platonico della Caverna e reso poi esplicito da Aristotele – acquisì una durevole connotazione veridittiva: vedo quel che è vero, quel che vedo è vero. Dando ora estensione di visibilità e realtà a ciò che vero non è, né reale, l'AI recupera la coesistenza di mito e realtà in un unico universo. Non nel modo antico, in cui cielo e inferi si popolavano di esseri e forze fuori dalla portata visiva umana. Ma in un modo del tutto inedito in cui nulla è condannato a rimanere invisibile e tutto (reale o no che sia) può raggiungere lo stato dell'evidenza. Ma in un modo del tutto inedito in cui nulla è condannato a rimanere invisibile e tutto (reale o no che sia) può raggiungere lo stato dell'evidenza. A qualcuno parrà vero, ma anche chi sospetterà la mistificazione subirà almeno in parte l'effetto dell'immagine, poiché per troppo tempo non abbiamo dubitato della forza veridittiva dell'evidenza. "Negare l'evidenza" è sempre stato, del resto, uno stigma contro l'ottusità: quanto tempo ci vorrà perché diventi una forma diffusa di scetticismo sistematico? E nel frattempo a quante mistificazioni l'opinione pubblica avrà dato credito?
Poniamo che venga fatta circolare l'immagine di un'autorità di massimo livello in condizione di nudità: il proverbiale "re nudo" incarnato in un capo di stato effigiato senza vestiti. Non si tratterebbe di una rivelazione, poiché la nudità non sarebbe quella reale (e regale). Se il monarca avesse un tatuaggio nascosto nelle zone per il solito coperte dagli abiti la sua immagine non lo riporterebbe. Eppure quel nudo non mancherebbe di turbare lui, e i suoi sudditi, indipendentemente dalla consapevolezza che non si tratta della reale e regale nudità. Non sarebbe più falsificazione ma mistificazione. Non costruzione ma ricostruzione, congetturale, verosimile e priva di marche della soggettività del produttore. Non manipolazione ma ostensione di una rappresentazione sintetica di una possibilità del reale.
Nella precedente puntata di queste rubrica ho parlato del video che mostra un bacio appassionato fra Elon Musk e Giorgia Meloni e concludevo con il dialogo: "Ma sei sicuro che Musk e Meloni si siano baciati?". "Sì, certo: l'ho visto coi miei occhi". Questa articolazione dell'AI, che rende obsolescente il fotomontaggio e amplifica la nostra capacità di produzione di immagini, recupera lo stato epistemico semionirico in cui l'esistente visibile può convivere con l'inesistente irreale in quanto quest'ultimo è stato portato all'evidenza. Nel mondo che si avvia a includere l'evidenza sintetica Musk e Meloni non si sono baciati e si sono baciati.
La "Revolution of Common Sense" annunciata solennemente da Donald Trump nel suo discorso di insediamento del gennaio del 2025 non è altro che l'attestazione dell'attendibilità ontologica degli "Alternative Facts", a cui credere risulta facilissimo e, appunto, comune. Il senso comune medialmente costruito non distingue fra realtà e mitologia, ovvero fra denotazione e connotazione secondo la sempre attuale lezione di Roland Barthes. Senza bisogno di alcuna alterazione tecnologica, le immagini probanti e incontestabili dell'assalto armato a Capitol Hill, della conseguente devastazione e della chiara intenzione di caccia fisica agli avversari politici risultano perfettamente compatibili con la proclamazione di innocenza dei responsabili e con la persecuzione giudiziaria di chi vi si oppose.

Ma se questa parità epistemica di realtà e mito è l'oggetto del Recupero (terza legge di McLuhan) la tetrade va ora completata: quale Capovolgimento può comportare l'innovazione mistificante, portata alle sue estreme conseguenze? Se apriamo il Grande Dizionario Italiano dell'Uso di Tullio De Mauro alla voce "Evidente" leggiamo come prima e seconda accezione: "1. che si vede chiaramente, che è ben visibile. 2. estens. che non ha bisogno di dimostrazione; certo, indubbio". La voce "Evidenza" attesta inoltre un uso recente, derivato dall'inglese "evidence", che era già un "falso amico" e ora non lo è più, poiché abbiamo adottato anche in italiano l'uso della parola per significare "Fatto che dimostra con certezza qualcosa, prova". Nel mondo medico, per esempio, si parla di "Evidence-based Medicine": ma con ciò si intende la necessità di individuare cause a finalità esplicativa, per cui quel “fatto che dimostra con certezza qualcosa” va ricercato. In campo scientifico l’evidenza è cioè un prodotto: non un dato. Va al contrario con le immagini create con prompt AI: lì non c’è nulla da cercare, nulla da dimostrare, ci si limita all'ostensione di qualcosa che è dato.
La solidarietà anche lessicale fra l'evidenza e la prova è minata per sempre dalla novità della generazione di immagini in AI, ovvero dall'invenzione di quella che possiamo chiamare "l'evidenza sintetica". Evidenza e apparenza si sono scambiate di ruolo. Ora è l'evidenza che inganna, mentre l'apparenza (che ne è sempre stata la seconda faccia oscura) a certe condizioni può essere promossa a verità alternativa.
La sfida che l'AI ci pone è quella di arrivare al Capovolgimento epistemico: cessare di credere ai nostri occhi, abdicare al primato illuministico della vista, quando le immagini generate li cattureranno con la blandizie o la mostruosità della loro evidenza sintetica.
Riferimenti bibliografici:
Algirdas J. Greimas (1983), "Il sapere e il credere: un solo universo cognitivo", in Id., Del senso II, Bompiani, Milano 1985.
Marshall & Eric McLuhan (1988), Le leggi dei media, Marshall e Eric McLuhan, Edizoni Lavoro Roma, 1994).
Id. Le tetradi perdute di McLuhan (2017) Il Saggiatore (2019).
Bruno Munari, Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, Laterza, 1977.
Prompt, Chi parla? Voci raccolte da Stefano Bartezzaghi, speciale in collaborazione con MAgIA, Magazine Intelligenza Artificiale. Leggi la rivista qui.
Leggi anche:
Stefano Bartezzaghi | Falso
Stefano Bartezzaghi | Mistificazione









