La schizofrenia alla prova della semiotica
Per chi dà fiducia all'etimologia delle parole, la schizofrenia è "mente divisa". Per chi pensa che il significato sia rappresentato da quella media degli usi che i vocabolari sanno attestare con empirica onestà, la schizofrenia è un "gruppo di disturbi mentali psicotici, caratterizzato da un'alterazione profonda del rapporto con la realtà, da dissociazione mentale, da autismo e altri disturbi della sfera affettiva e del comportamento" (Zingarelli). Come in altri casi, anche in quello della schizofrenia non è possibile farsi bastare né il modo in cui una parola si è formata nel suo significante (qui in modo assai artificiale) né la sintesi che è possibile dare della costellazione di unità culturali che compongono il suo spettro semantico. Oltretutto "permangono tuttora incertezze sull’eziologia e la nosografia di tale tipo di disturbi e sulle possibilità e modalità dell’intervento terapeutico" (Enciclopedia Zanichelli).
La schizofrenia è fuori dal senso comune tanto quanto il senso comune è fuori dalla schizofrenia. Si potrebbe pensare che la ragione ha tentato di costruire il suo opposto – l'Alieno, l'Altro, l'Assurdo – e si è data torto. C'è chi però non si è accontentato di vie di uscita aforistiche come queste né si è spaventato di fronte all'orografia colossale della bibliografia relativa al tema. Si parla di Luigi Lobaccaro, un ricercatore dell'Università di Bologna, che opera nell'ambito della scuola fondata da Umberto Eco e ora a questi intestata (Centro Internazionale di Studi Umanistici "Umberto Eco"). Non siamo insomma tra psichiatri ma tra semiologi.
Fra tutti i pregiudizi e le approssimazioni concettuali che alonano la considerazione generale che si ha della schizofrenia Lobaccaro ne elegge uno, forse il più grande, e ne fa l'obiettivo polemico della sua intera trattazione: che la schizofrenia sia il dominio dell'insensato. Atto assai coraggioso: per affermare che qualcosa sia insensato o non lo sia occorre avere un'idea del senso. "Proprietà comune a tutte le semiotiche, il concetto di senso è indefinibile [...]", dice la succinta voce dedicata al lemma in uno dei pilastri della semiotica del Novecento, e continua: "Nulla si potrebbe dire del senso, se non facendo intervenire presupposti metafisici fin troppo gravidi di conseguenze" (Greimas-Courtés, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, ed. orig. 1979). Ma è proprio domandandoci cosa possiamo comprendere della schizofrenia che ci troveremo a pensare a cosa la schizofrenia ci fa comprendere. Nel suo Ai confini del senso. La schizofrenia tra semiotica, psicopatologia e scienze cognitive (Quodlibet) il titolo di Lobaccaro mobilita le forze citate nel sottotitolo: l'autore propone un'apertura del campo semiotico alla contaminazione e all'ibridazione con psicopatologia, psichiatria, linguistica, neuroscienze, precisando che il metodo e l'intento non sono imperialistici ma simbiotici.
Nei tre capitoli della prima parte, intitolata "Mappare i confini", la schizofrenia appare come la sfida irrisolta della nosografia psichiatrica e il suo dominio concettuale viene sottoposto a perizia semiotica. Innanzitutto, il problema nosografico, cioè la definizione della patologia. Nel caso della schizofrenia la delimitazione è considerata malcerta dagli stessi psichiatri. Cosa può dirne la semiotica? Alle basi fondative e si può dire archeologiche della teoria dei segni contemporanei è la semeiotica medica, di origine presocratica. L'idea di segno non si è generata in ambito linguistico ma diagnostico, dal rapporto tra sintomo e malattia. Nelle patologie organiche tale rapporto è indicale: la febbre è un dito puntato sulla sua causa, l'infezione. Nel caso della schizofrenia non si può dire lo stesso: viene definita da un gruppo di categorie sintomatiche (deliri, allucinazioni, pensiero, eloquio e comportamento motorio disorganizzati, diminuzioni di attività) ma – il cortocircuito è imbarazzante – il gruppo è stato formato appunto per definirla. Fra le manifestazioni psicopatologiche e la loro interpretazione diagnostica come sintomi di schizofrenia il rapporto piuttosto che indicale è simbolico, che per la semiotica che discende da Charles Sanders Peirce significa che è retto da una convenzione. La schizofrenia è insomma un costrutto teorico: se non proprio un fatticcio latouriano, argomenta Lobaccaro, un concetto perlomeno instabile. Ciò non deve però condurre alle denegazioni dell'antipsichiatria: l'approccio di Lobaccaro, seguendo le indicazioni di Foucault, Basaglia, Borgna, sospende la questione ontologica e propone di continuare a parlare di schizofrenia, ma in termini di ipotesi regolativa.
La perizia procede di conseguenza prendendo i sintomi come manifestazioni fenomenologiche e non più come indici puntati su qualcosa che non si sa cosa sia. Viene infatti naturale pensare che le parole sconnesse del paziente siano causate da un disordine mentale, siano gli starnuti che rivelano il raffreddore. Ma le cose stanno diversamente.
È vero che da una storia semiotica della follia lo schizofrenico esce come figura definita dalla mancanza, deficit o regresso: è l'alogos, essere privo della ragione, del linguaggio, della comprensibilità. Così è stato considerato ma la fenomenologia dei suoi comportamenti ci dice che il tratto fondamentale del suo disturbo è ben diverso, ed è la separazione dal mondo: "Non c'è comunanza di senso tra sé e gli altri, il mondo vissuto assume delle tinte idiosincratiche, le strutture dello spazio, del tempo, della soggettività si modificano e il mondo non è più visto come possibilità di azione o di progetto". Da regno dell'insensato e dell'incomprensibilità la schizofrenia si fa così ambito di un'alterità che reclama una propria possibilità di comprensione e di considerazione semiotica.
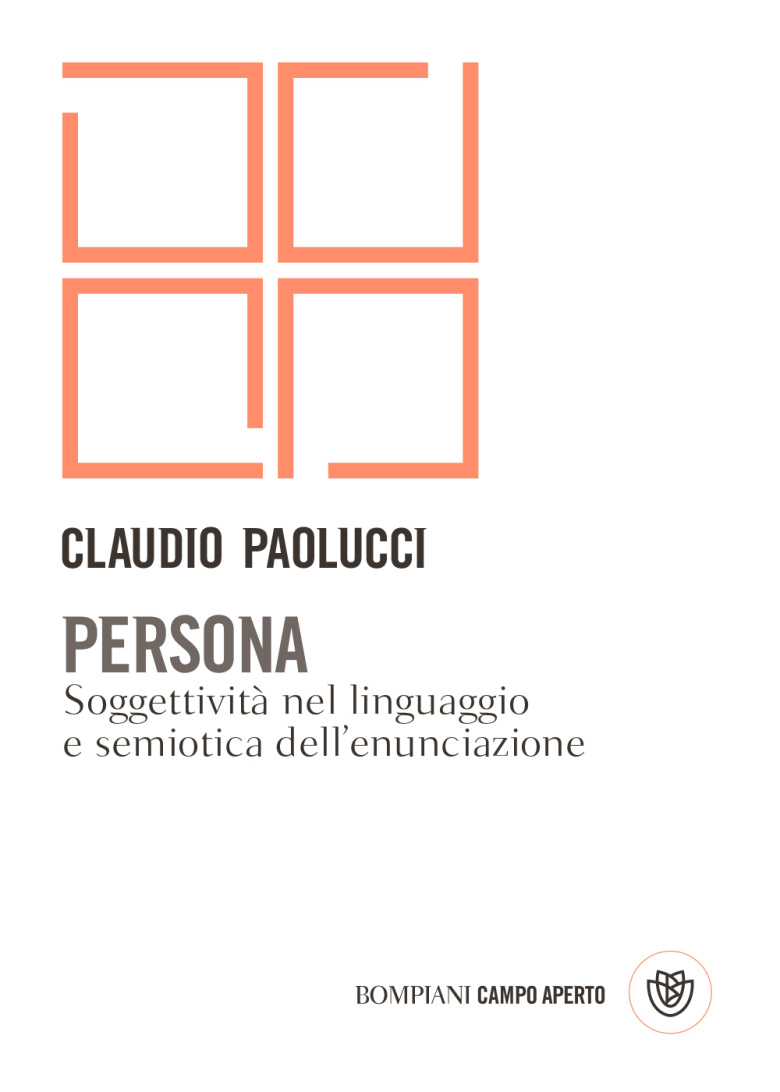
A dare ascolto al discorso schizofrenico, o schizofasia, e a sondarne una possibile comprensibilità si dedicano i tre capitoli della seconda parte del libro, intitolata "Dall'altra parte del senso", che prendono l'avvio dal versante linguistico della questione per mostrare come l'espressione verbale non sia affatto la conseguenza del disordine del pensiero (come comunemente si ritiene) ma ne sia caso mai una causa efficiente che a sua volta dipende da una causa generale: la perdita dell'intersoggettività.
Stereotipie, manierismi, verbigerazioni dell'alogos (che alogos ovviamente non è) hanno una causa psichica soggiacente? Parrebbe naturale pensarlo, ma su questo punto si opera prima un ribaltamento poi un'estensione. Il ribaltamento avviene negli anni Settanta, quando l'approccio cognitivo rileva come come sia il disordine del pensiero a derivare da problemi nelle facoltà linguistiche del soggetto (e non viceversa). Si dispone ormai di una mappa molto dettagliata di questi comportamenti linguistici e Lobaccaro la tratteggia con svelta efficacia: ipocomplessità e ipercomplessità del periodo, loop articolatorio, effetto valanga; fluttuazione, distorsione, dispersione, dissoluzione semantica; ricorso a neologismi e paralogismi (per un paziente, "sporco" significa "pulito", perché aggiunge la s- privativa al "porco"), glossolalia, stereotipie, uso ludico del linguaggio; deragliamento, tangenzialità, incoerenza del discorso, uso non letterale delle parole, incomprensione del linguaggio metaforico. A fronte di questa fenomenologia Lobaccaro ricorre all'idea fondante della semiotica di Umberto Eco, cioè il concetto teorico di enciclopedia, come "l'insieme del potenziale semantico esprimibile e l'insieme delle funzioni produttive per poterlo esprimere in un determinato contesto e in un dato momento": due insiemi che non escludono bensì includono ogni manifestazione schizofasica già avvenuta o comunque possibile.
Altro che alogos: lo schizofrenico produce segni e comprende il significato delle parole, da questo punto di vista non gli manca nulla. La devianza dei suoi comportamenti linguistici consiste nell'essere "perso nell'enciclopedia" non sa limitare le infinite connessioni che l'enciclopedia prevede e le vuole percorrere tutte. Un paziente ha detto: "Ogni volta che scrivo qualcosa non posso fare a meno di pensar a cosa non sto scrivendo". Lobaccaro cita anche Antonin Artaud: "Sono vacante per stupefazione della mia lingua. Mal- formazione, mal-agglomerazione di un certo numero di corpuscoli vitrei di cui fai un uso così inconsiderato".
Appena cessiamo di considerare la schizofrenia come dominio dell'insensato ci accorgiamo che la sua esperienza ha abbondanti tratti comuni con l'esperienza non patologica. Dove situare la differenza? L'infinità dell'enciclopedia vale per tutti, soltanto che nella condizione non patologica le connessioni e le diramazioni, le possibili strategie espressive e interpretative non sono tutte contemporaneamente attive ma vengono selezionate. I contesti, le circostanze, le norme, gli usi condivisi fanno in modo che i parlanti, gli scriventi, i lettori ritaglino volta per volta la porzione di enciclopedia pertinente. La schizofasia invece contempla sempre tutti i percorsi possibili nell'enciclopedia. Spiana ogni linea di discrimine: nulla per lei è altro che significativo, tutto ha pertinenza. Il discorso sbanda, prende linee laterali, fa salti logici che potrebbero essere anche presi come creativi se solo fossero forniti di intenzione. E invece no, il soggetto non si dà alcuna direzione: non è un'automobile in una rete stradale ma è una barca senza bussola in mezzo al mare.
Quindi non è che il linguaggio schizofrenico sia causato da disturbi del pensiero. Ma non bisogna neppure affrettarsi a invertire i termini e concludere che quella linguistica sia la causa del disturbo, da cui discenderebbero tutti i sintomi (allucinazioni, percezioni aberranti, eccetera). Che la dimensione linguistica sia rilevante è certo, del resto la schizofrenia è come il linguaggio verbale un proprium della specie umana e quindi una correlazione è possibile. Ma la schizofrenia insorge in età giovanile, quando il soggetto ha già sviluppato competenze linguistiche non patologiche (perciò per alcuni è possibile parlare di regresso) e inoltre tra i propria degli esseri umani c'è anche la capacità sociale di mimesi, attenzione e intenzione intersoggettiva: la capacità cioè di dare senso alle azioni ed emozioni altrui. Proprio all'intersoggettività e alla cognizione sociale – a una certa definizione di senso comune – è affidata la capacità di sintonizzarsi agli altri e di compiere la necessaria riduzione circostanziale della complessità illimitata dell'enciclopedia. La questione non è soltanto di pensieri né soltanto di parole ed è qui che avviene il decisivo allargamento della prospettiva dalla dimensione linguistica a quella più ampiamente semiotica.
Prima dell'io linguistico si stabiliscono livelli d'intersoggettività: il bambino comprende l'esistenza di un tu, quindi gioca a essere qualcun altro, impara a simulare il pianto, a usare il suo nome proprio e infine – quando è già un soggetto riflessivo – a dire "io". Interviene qui quel decisivo cambio di paradigma che nella teoria semiotica dell'enunciazione è stato delineato da Claudio Paolucci (l'allievo di Eco che ha guidato la ricerca di Lobaccaro) nel suo Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione (Bompiani, 2020). In questa visione la soggettività discende dall'intersoggettività, l'enunciazione personale dell'io attraversa quella impersonale e sociale e si media con questa, costruendosi in relazione all'egli: "Per riconoscersi in un me, il soggetto deve infatti accedere a una porzione enciclopedica che apre la posizione terza con cui assemblare l'io al non-io, poi riconoscersi in essa" (corsivi di Lobaccaro). Allo schizofrenico ciò non è possibile poiché la sua visione dell'enciclopedia non ha striature, gerarchie, organizzazione e ciò non gli consente di costruire la sua soggettività in relazione alla società di cui è parte, ai giochi linguistici della sua comunità.
La conclusione è tale da aprire orizzonti di ricerca interdisciplinare che già vengono perseguiti, ma nel farlo ci ha detto qualcosa su cui possiamo soffermarci. Privo di senso comune il discorso dello schizofrenico tuttavia non è insensato; incapace di accedere al gioco sociale, la sua umanità non è tuttavia aliena. Anzi è attraverso di essa che noi possiamo comprendere meglio il fondamento semiotico delle nostre esistenze – e dei loro mutui tentativi di spiegarsi e comprendersi.









