Un libro di Giorgio Ficara / Vite libertine
Il principio di Benjamin Disraeli, Primo Ministro e narratore inglese del XIX secolo, può essere ritenuto valido tuttora: «Quando ho voglia di leggere un buon libro, ne scrivo uno». Dev’essere per questo che i critici letterari, più volte nell’arco degli ultimi tre secoli, sono diventati saggisti, o saggisti-narratori, o saggisti-poeti; dunque, scrittori tout court. Se avvertono che la letteratura è in crisi, i veri intenditori non si limitano ad affermarlo, ma corrono in suo soccorso. Sarebbe sciocco, d’altronde, credere forsennatamente alla divisione dei ruoli e del lavoro, ai doveri di probità oggettiva, di accademica acribia. L’aver molto letto atteggia i nostri neuroni all’imitazione, li concima con l’idea che l’originalità emerge non dalla cancellazione dei maestri, ma dalla confidenza che essi ci hanno concesso.
Anni fa, Giorgio Ficara ha dato alle stampe un libro di saggi intitolato Lettere non italiane. Considerazioni su una letteratura interrotta: pagine che esprimevano non certezze, ma semmai sintomi, forti indizi di serietà letteraria, e al tempo stesso, con la propria prosa, operavano cuciture, connessioni, sollecitazioni. Forse anche resurrezioni. Credo sia questo l’unico modo onesto per farsi carico di una crisi: vergare la denuncia con tale rigore e brillantezza da riuscire a smentirla. È quanto in Italia fanno, da decenni, altri saggisti eminenti come Raffaele La Capria, Alfonso Berardinelli, Matteo Marchesini, e pochi altri ancora. In Ficara, poi, quelle Lettere non italiane erano insieme l’ammissione di uno smarrimento e una grande risorsa. C’è un così gran mondo, là fuori, che se non è italiano potrebbe diventarlo. E forse lo merita.
Fin troppo facile, allora, pensare che con le sue recenti Vite libertine (La nave di Teseo) Ficara abbia “tradotto in italiano” un sentimento oggi fin troppo estraneo al nostro tessuto culturale: non la sudditanza e la riproduzione pedissequa, né l’udienza universale e al tempo stesso calcolata, bensì l’intimo commercio delle menti e dei corpi, l’antica cerimonia delle autentiche, sfrontate libertà.
Per un filosofo sistematico la personalità più rilevante del Settecento, scontata la giusta considerazione per David Hume, è senz’altro Immanuel Kant. Ma per coloro che amano pensare lasciando che le parole s’impregnino, si nutrano e s’impoveriscano con l’esperienza, sarà difficile rinunciare a una sola pagina scritta da Denis Diderot, o a molte delle migliaia di pagine scritte da Voltaire, dagli impegnati o svogliati, coraggiosi o intimiditi redattori dell’Encyclopédie, dai memorialisti italo-francesi come Goldoni e Casanova.
Per converso, Ficara mostra giusta e legittima diffidenza per Rousseau, che corre in filigrana in parecchie delle sue pagine, ma sempre come assertore di una sincerissima vergogna personale e dunque di un’astratta, onnipotente “volontà generale”. Quanto di meno libertino è possibile attingere: stazione di passaggio di un convoglio partito dalla Repubblica di Platone e poi infilatosi nel tunnel rappresentato dall’incorruttibile ghigliottinatore Robespierre e dal comunista Lenin; tutti indefessi coltivatori di utopie universali, dunque atrocemente selettive.
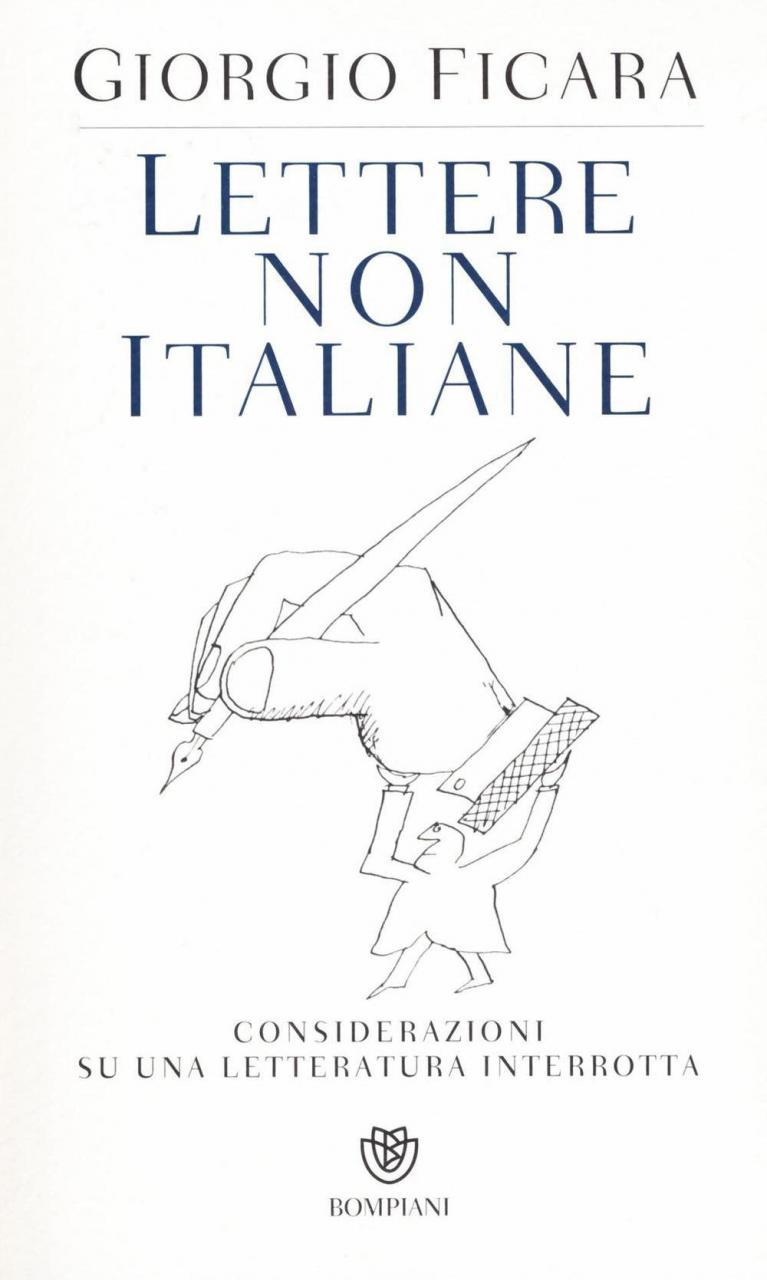
Il mondo dei libertini è invece per Ficara alieno da ogni sistema, e anzi accondiscende a ciò che non dirime, restando indeciso fra slancio e sospensione. Il libertinismo, anzi, se posso azzardare una formula, consiste nell’accettare il limite, ma non pretendere di sapere quale esso sia, a quale altezza, o profondità o estensione esso giaccia. Insomma, il libertino sperimenta il limite, lo allontana e lo avvicina, medita mentre lo scavalca e lo rimpiange. L’ironia è il suo presupposto e il suo esito; la conversazione e l’esprit sono la maniera (e non intendo il modo, ma proprio la maniera) per ingannare la morte e prolungare indefinitamente il piacere dell’approssimazione. Fra le decine di sapide historiettes, che Ficara felicemente preleva e traduce e reinventa, non è affatto difficile cogliere i fiori più maturi di un non sapere coltivatissimo, di uno smarrimento sagace:
“I filosofi parlano di uno spazio generale che tiene insieme tutti i mondi e tutte le intelligenze. Non sarà invece che ogni mondo è ristretto al suo spazio particolare e sta in sé, da solo, per l’eternità? Non sappiamo nulla. Se questo disegno nell’universo esistesse davvero, o altrimenti non esistesse, e ne fossimo certi, ora sapremmo qualcosa di più. Ma non è così: tutta la nostra scienza non ci dice neppure che voi siate voi e io sia io.”
Condividere la solitudine, lo stare in sé dello «spazio particolare»: ecco la missione forse inconsapevole dei libertini. Poche centinaia di uomini e donne, in fondo, cercarono di ampliare i confini del sapere e insieme di marcare con una specialissima immoralità l’ambito della sua divulgazione. La malinconia che ne deriva è evidente: molte delle scene colte da Ficara sono incorniciate dalla neve che cade a larghe falde; molti protagonisti muovono ormai a fatica le membra che ancora ricordano come seducenti e baldanzose, gli amori senili diventano una dolce articolazione della memoria. La musa ispiratrice di Ficara è senz’altro la mobile filosofia, l’implacabile divagazione delle Operette morali, capolavoro in prosa del Leopardi più settecentesco, più candido e scandaloso. La gioia della variazione, dell’inserto che cita e fagocita, del dialogo inconcludente per troppa ricchezza, è tutt’uno con un pensiero che compromette la poesia col suo metro, la favola col carcere in cui matura, l’inclusione indiscriminata col deserto delle illusioni:
“Noi tutti siamo spirito ‘pronto’ e carne ‘stanca’, come scrive il Poeta, o indifferentemente carne prontissima e spirito parecchio stanco. I due compari, carne e spirito, ad ogni modo non si allontanano mai di un passo l’uno dell’altro, vivono nella stessa tana come cane e gatto e nessuno al mondo è mai riuscito a dividerli.”
All’Ottocento dobbiamo la nascita del concetto di Nazione, nascita generosa e anti-imperiale, ma infine catastrofica per eccesso di lutti e di angustia mentale, come sappiamo dalla “guerra dei trent’anni” del 1914-1945 e dalle sue tante, più recenti repliche in scala minore. Il Settecento di Ficara, invece, è quello in cui Voltaire scrive le Lettres anglaises, Diderot si ispira a Sterne per concepire il capolavoro di Jacques le fataliste, lo stesso Sterne viaggia attraverso la Francia e l’Italia, Metastasio scrive libretti d’opera a Vienna, Giuseppe Baretti vive a Londra, Diderot va a Pietroburgo dalla zarina, Voltaire conversa in Prussia con Federico il Grande, Giacomo Casanova ripensa, vecchio, alla sua Venezia mentre osserva le nevi della Boemia; quello in cui a Parigi puoi incontrare Benjamin Franklin, Goldoni e l’abate Galiani, mentre Lorenzo Da Ponte sbarca a New York. È di questa intersecata “libertà” che Ficara approfitta, incastonando nella più fresca lingua italiana, sempre aperta all’aneddoto, al favoloso e all’apologo, i diversi modi idiomatici francesi e inglesi, quasi fossero dei formulari d’accesso all’intimità; così come ai paesaggi e giardini civilmente “italianizzati” si alternano inverni crudi e “ragazze selvagge” incontrate nel folto della foresta.
Anche queste Vite libertine sono dunque delle Lettere non italiane: missive fuori luogo, in delizioso, essenziale ritardo sull’oggi. La società di massa e della comunicazione globale non può – quasi per mancanza, ormai, di un organo fisico – apprezzare la conversazione e l’ironia: ognuno di noi è la particella di un leviatano pachidermico e insensibile, ma in quanto particella ridotto a una povera recintazione dell’identità, basata sulla suscettibilità e l’offesa di una privacy crivellata. Inaccettabili, ormai, l’ironia, la fuga, la sperimentazione, come anche lo slancio rapace, mediato dall’escamotage, ma acuito dalla tristezza. E se proprio nel Settecento si sviluppava intanto la scienza moderna, i libertini di allora mostravano la facilità con cui essa sarebbe stata travolta dall’immensa diceria che aveva promosso. Quella dei libertini non poté essere una comunione, e tantomeno una democrazia, ma di certo fu una comunità; ristretta al punto tale che io stesso non avrei goduto degli strumenti intellettuali per avvicinarla, e tantomeno per cercare di scriverne. È questa, oggi, la mia, la nostra malinconia speciale.









