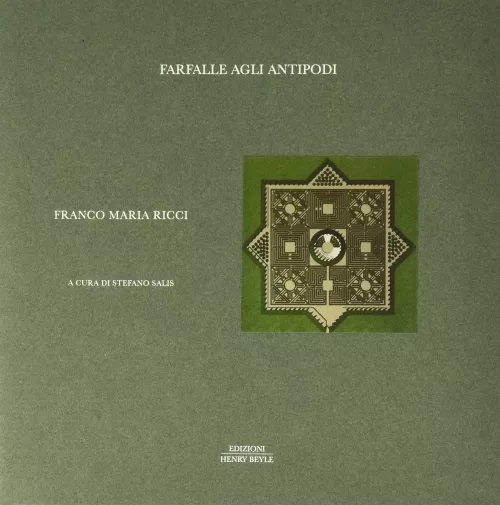FMR: Farfalle agli antipodi
Esiste un genere letterario, prettamente novecentesco, che è quello degli editoriali, a torto considerati articoli di accompagnamento o di introduzione di un numero di rivista, ignorando che invece si tratta di uno strumento dotato di sofisticata letterarietà. Diamo per scontato ciò che affermava Gianfranco Contini, cioè che l’Ottocento è stato il secolo della prosa e che i cento anni successivi vanno derubricati come il secolo delle riviste. Alla luce di questa affermazione diventa scontato accreditare gli editoriali nel novero delle scritture non soltanto rispondenti a scopi prettamente giornalistici, ma veri e propri esercizi letterari. Si potrebbe ripercorrere l’avventura novecentista – prendo in prestito un titolo di un libro di Massimo Bontempelli del 1974 – per ripensare a come siano cambiate le prospettive culturali sulla base degli editoriali che hanno battezzato la nascita di un periodico. Come non ricordare, per esempio, gli articoli con cui debuttarono «Leonardo» (1903) o «La Voce» (1908)? Senza trascurare i programmi di un laicismo tutto gobettiano, che trapelano dai primi numeri di «La Rivoluzione Liberale» (1922) e «Il Baretti» (1924).
Perfino il progetto di «Primato» (1940), riassunto nell’articolo di apertura di Giuseppe Bottai, Il coraggio della concordia, merita un posto nella galleria novecentesca dei più rilevanti editoriali perché non era solo una provocazione dell’allora Ministro della Cultura, ma una sorta di messaggio SOS, una richiesta d’aiuto in extremis, lanciato in prossimità dell’ingresso italiano in guerra. Non sarà inutile ricordare in questa sede i tentativi di dare fiato a un’idea di cultura contenuta nelle premesse teoriche che presiedono gli inizi del «Politecnico» di Elio Vittorini e del «Ponte» di Piero Calamandrei, entrambe nel 1945. Perché non altro che questo vanno considerati gli editoriali: premesse teoriche, pronunciamenti in limine, esercizi di progettualità.
Se con il passare degli anni, varcando il discrimine della dittatura e della ricostruzione, molte delle riviste che hanno cercato di raccontare le trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese hanno smarrito l’uso degli editoriali – penso a «Officina» (1955) di Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi o al «menabò» (1959) dello stesso Vittorini – credo che le ragioni della mancanza vadano individuate nella difficoltà con cui comprendere tali trasformazioni e di riassumerle, circoscrivendone gli esiti in un articolo con limitato numero di battute. Gran parte delle pubblicazioni periodiche che si inscrivono nella cornice degli anni del boom economico – dal «Caffè» (1953) di Giambattista Vicari fino ai «Quaderni Piacentini» (1962) di Piergiorgio Bellocchio, Grazia Cherchi e Goffredo Fofi – denunciano l’assenza di simili interventi, contribuendo in larga misura alla dispersione della capacità di tracciare il profilo di quella determinata stagione culturale.
Proprio da questo, in fondo, prendevano le mosse: essere la testimonianza di una militanza e offrire il ritratto di un modo d’essere intellettuale in un preciso tempo. La vicenda del Novecento ci ha abituato a pensare che un filo diretto si estenda tra chi redige un editoriale per una rivista e l’idea di impegno intellettuale, di progetto morale che quella rivista intendeva assumere. Se da diversi decenni e da più parti si denuncia l’assenza del ceto intellettuale, una certa correlazione dovrà stabilirsi con l’assenza di editoriali prima ancora che con l’assenza di periodici. Non è che un’ipotesi, certo, suffragata dalle tendenze degli ultimi decenni in cui il vecchio ruolo delle riviste è stato sostituito dalle nuove community, dal più popolare Facebook ai più sofisticati Twitter e Instagram: luoghi d’incontro o di scontro, ma privi di un disegno progettuale, privi di una linea guida che dia una sia pur minima parvenza di direttiva. Di questa dispersione siamo tutti attori e spettatori, spesso presi da pulsioni nostalgiche per una cultura che possa ricondursi a una dimensione centripeta.
Questa lunga premessa si rende necessaria quando ci si imbatte in un’esperienza d’eccezione come la rivista «FMR» (1981), una delle più eleganti e originali nel panorama degli ultimi decenni, la più bella per antonomasia, nata su impulso dell’omonimo fondatore e animata da uno spirito di ricerca inconsueto, teso a cercare il filo disperso di una eccezionalità che è dentro le notizie raccontate in forma di facezie, di curiosità, come ipotesi della mente o come lontani disegni di mondi alternativi.

Chi volesse toccare con mano questo tipo di messaggio non deve fare altro che immergersi dentro la scelta di editoriali che Franco Maria Ricci ha concepito come segni di un’appartenenza al mondo della fantasia, ora radunati e curati da Stefano Salis sotto il titolo di Farfalle agli antipodi (Edizioni Henry Beyle, p. 95, s.p.) e con il corredo di sette immagini, la più antica delle quali risalente a una miniatura del XIV secolo fino alla più recente, il progetto del Labirinto della Masone, tracciato dallo stesso Franco Maria Ricci, nel 2004, e realizzato nelle campagne di Fontanellato, vicino Parma. Il titolo, di suo, è già tutto un programma e ricorda, almeno per assonanze, il fenogliano Una crociera agli antipodi, edito da Einaudi nel 2003 a cura di Luca Bufano, che raccoglieva racconti inediti del 1959 e rimasti fino ad allora nelle carte d’archivio dello scrittore di Alba.
A presupporre un legame tra i due libri non c’è solo il titolo, ma una prospettiva comune: il fantastico, portato agli estremi, un terreno decisamente contromano per i lettori di Beppe Fenoglio, abituati a situazioni epico-resistenziali, che invece si rivela essere l’orizzonte in cui si muove a proprio agio il più giovane editore milanese, inventore – ricordiamolo – del celebre Labirinto della Masone. Le farfalle agli antipodi, di cui recita il titolo di questa raccolta, sono quelle descritte nel numero del giugno 1996 (abbondantemente prima che fossero pubblicati i testi di Fenoglio, che Franco Maria Ricci, dunque, non poteva conoscere), quelle raffigurate da una pittrice inglese, Ellis Rowan. La quale, nel 1916, a sessantasette anni, dopo una vita trascorsa a dipingere fiori, si trasferì nella Nuova Guinea e in quelle umide latitudini tropicali scoprì le tinte sgargianti che coloravano le ali di queste farfalle con cui riempì la sua tavolozza. Il tutto mentre in Europa si combatteva la prima, grande guerra del Novecento. Era già questa una latente dichiarazione di poetica: il gesto di una evasione, ma anche la scoperta che esistono mondi alternativi a quelli transitati sotto la tipologia della cronaca e, in aggiunta, l’affermazione di un’umanità che decide di non piegarsi alle dure leggi della Storia.
Cos’altro intendeva essere il viaggio di questa donna, nata in epoca vittoriana, se non una subliminale forma di protesta? Il racconto di Franco Maria Ricci può essere assunto a mo’ di manifesto di una certa letteratura che non si piega alle norme rigide della realtà e fa bene Stefano Salis a sottolineare il valore narrativo di questi testi, nati sotto le mentite spoglie di generici editoriali e invece poi perfettamente riconoscibili nella cifra dei «deragliamenti felici». Grazie a questa definizione ci è più chiaro il discorso: questi testi sono deragliamenti, cioè sospensioni di un procedere regolare, eversione dal racconto normato.
Molto suggestiva, per esempio, la riflessione a proposito dell’esploratore Matteo Ricci (omonimia con lo scrittore-editore o c’è dell’altro?) che portò con sé, in Cina, gli orologi ignorando che l’Oriente non sentisse il bisogno di misurare l’ora esatta, ragione per cui quei congegni rimasero a lungo oggetti meccanici da contemplare come giocattoli. La scrittura di Franco Maria Ricci si nutre di queste fole: agli occhi degli stolti sembrano stravaganze di una mente toccata da eccessivo libertinaggio, a chi frequenta il vangelo della fantasia – e qui la schiera si infittisce di presenze illustri: Zavattini, Calvino, Manganelli, Celati, Cavazzoni… – risultano familiari come il grano e l’olio, di cui si nutrono i popoli mediterranei.
D’altronde Franco Maria Ricci, quando racconta, ama parlare per bocca degli altri. Dichiara, per esempio, affidandosi all’autorità di un Jorge Luis Borges, che la teologia è un ramo della letteratura fantastica. Misura la profondità del tempo, ma lo fa a modo suo, calcolando quante volte in una vita media un uomo può assistere al passaggio della cometa di Halley che transita nei nostri cieli ogni settantacinque anni: generalmente una per ciascun uomo, raramente due, nelle situazioni drammatiche mai. E, come se non bastasse, da questo variopinto mondo popolato da futilità – dove le farfalle, come gli orologi, obbediscono alle correnti del vento, mutano direzione sulla base di regole mai del tutto convincenti – si esce solo dalla medesima porta da cui si è entrati, cioè i libri.
La «teca della civiltà» vengono definiti nell’editoriale del giugno 1987, il primo ad aprire questa raccolta, oggetti d’un eterno e ininterrotto discorso, nati con Dio e solo perché al cospetto di Dio diventati strumenti di una religione laica: quella che crede all’eternità realizzatasi sopra un pezzo di carta. I libri, specifica Salis nella postfazione al volume, sono oggetti che emanano una loro sacralità, da attraversare avendo cura di toccarli con polpastrelli leggeri, mai deturparli, mai scandalizzarne la natura sottoponendoli a forzature o a contraffazioni. Ma sono anche l’emanazione di un Dio che sentiva di voler raccontare le storie del mondo a qualcuno e che, non potendolo fare, essendo solo, ha creato gli uomini. Potrebbe risultare anche questa l’ennesima fola, uno scherzo del pensiero, un niente. Invece è tutto.