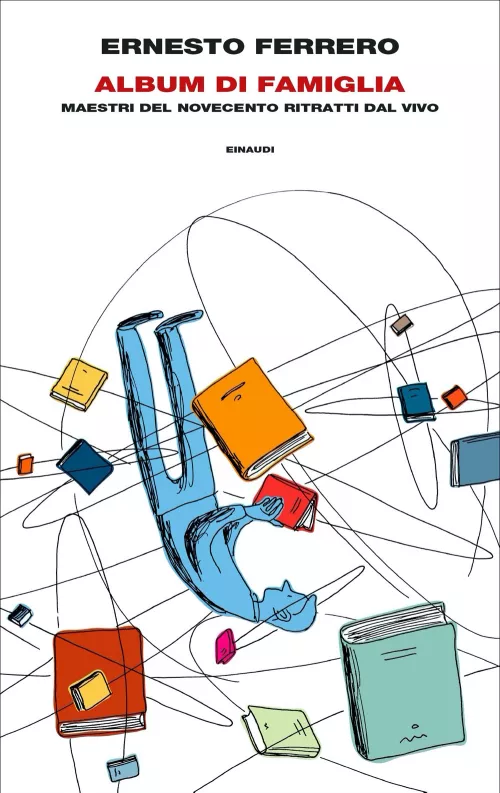Maestri del Novecento: ritratti dal vivo
Scriveva Elio Vittorini nel suo Diario in pubblico che ci sono libri di fronte ai quali si rimane sulla soglia e libri in cui si viene invitati a entrare, a mettersi comodi, a sentirsi come a casa. In questo Album di famiglia di Ernesto Ferrero (Einaudi, pag. 323, euro 21), che reca un sottotitolo esemplificativo, Maestri del Novecento ritratti dal vivo, accade di provare l’ebbrezza descritta da Vittorini, cioè di sentirsi tra le mura di una casa o, per meglio dire, in quella dimensione di ritorno alle origini, la stessa che capitava di avvertire quando, durante gli anni di università vissuti da fuorisede, si rientrava nell’orizzonte domestico per le feste comandate e ci si riappropriava dell’aria da cui si era partiti.
Leggere Album di famiglia è come tornare a casa, non per ragioni geografiche, ma perché l’orizzonte di riferimento è quello di una certa comunità novecentesca, composta di scrittori ed editori, amici e colleghi, con cui stabilire, a diversi gradi, una certa parentela. È questa la materia di cui traboccano le pagine: una nomenclatura da capogiro (da Calvino a Pavese, da Montale a Bobbio, da Foa a Revelli, da Rodari a Regge, da Fenoglio a Del Giudice, da Sciascia a Consolo, da Guttuso a Eco) che nasce sotto l’insegna del precetto di Gustav Mahler («la tradizione non è l’adorazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco») e finisce per diventare una pensosa ricapitolazione di un clima culturale a cui ci si sente di appartenere legati mani e piedi, per un vincolo d’elezione.
Una sensazione del genere è già sufficiente per autorizzare l’accostamento con la dimensione casalinga: ci si sposta sulle pagine come da una stanza all’altra di un grande e raffinato appartamento e non di rado si viene catturati dalla tentazione di non uscirne più. Sarà per quanto vi viene raccontato, per gli scorci umani che ne compongono la trama, per l’ammaliante senso di ordine che accompagna la scansione dei capitoli, suddivisi secondo aree di appartenenze parentali (I capotribù, I padri nobili, Gli zii sapienti) o per ruoli (I prediletti, I maghi e funamboli, I cari agli dèi, Gli inquieti, I compagni di banco, I mattatori).
Sarà per il fulgore che accompagna uomini e libri, per i sentimenti di condivisione e di stima, per le riflessioni sul lavoro editoriale e sul mai del tutto chiarito rapporto tra letteratura e vita; sarà per tutta questa materia densissima, ma qui siamo davvero al cospetto di quel Novecento che sopravvive nell’immaginario di chiunque abbia a cuore l’ossessione per le storie, quell’amore intramontabile che ha accompagnato i grandi lettori fino al termine del vecchio secolo e che poi chi ha potuto si è portato con sé nel nuovo millennio, come chiedeva il Calvino delle Lezioni americane, in forma di eredità testimoniale e non di zavorra.
Intendiamoci bene: Calvino faceva appello a precise categorie teoretiche là dove, invece, Ferrero chiama a raccolta gli individui per nome e cognome, ne elenca i dati esemplari senza cadere nel vezzo del ritratto agiografico, aiuta a ricostruire i tanti perché di una stagione forse irripetibile, osservata dal di dentro e senza i fronzoli della retorica. Stiamo parlando del Novecento einaudiano, appunto, quello che ciascuno di noi ha sognato di attraversare da attori, da comparse, da sparring partner, perché dalla sigla dello Struzzo – da quel magnifico appartamento composto di collane, di iniziative culturali, di teoresi sulla necessità di capire il proprio tempo, che è stata la storica sede torinese di via Biancamano – trapela un’umanità che assume una fisionomia fin troppo familiare per farci sentire estranei.
Chi non ha varcato almeno una volta, nei sogni, la soglia dov’era la scrivania di Giulio Einaudi? E, sempre attingendo ai desideri, non ha voluto sbirciare almeno per un attimo su quella scrivania? Il libro di Ferrero vive di queste accensioni, disegna ritratti e non caricature, schizza profili di persone mitigati da un sentimento di misura interiore in cui progettare cultura diventa intelligenza morale e viene a rappresentarsi dinanzi agli occhi mediante i titoli dei libri, mediante le copertine disegnate da Albe Steiner o da Bruno Munari, mediante le riunioni del mercoledì a cui nessuno, credo, si sia mai salvato dalla tentazione di essere presente.
È questo il Novecento che si passa in rassegna leggendo Album di famiglia ed Ernesto Ferrero ce lo racconta con la metrica di un’epopea pronunciata a bassa voce, «per vedere come sono certe vite al naturale» ammetterà nel congedo finale, eppure sontuosa per l’altezza dei profili, a cominciare da chi sta al vertice di tutto, Giulio Einaudi, padre-padrone di un’editoria «come conoscenza degli uomini» (così titola il capitolo a lui dedicato), uomo dal carattere controverso, ostinato persecutore della banalità e sempre a caccia di idee nuove, protagonista più in controluce che in primo piano di quel particolare modo di essere “chierici” che Ferrero aveva attraversato, anni fa, in I migliori anni della nostra vita (2005) e che ora, con questo viaggio nelle fotografie di un’epoca in bianco e nero, affida alla consacrazione della Storia.
D’altra parte, per sentirsi veramente in famiglia, bisogna vantare una speciale appartenenza alle liturgie private di una casa-mondo com’è stata la Einaudi, ma per farlo bisogna avere avuto il privilegio ineguagliabile di essere lì, presente in corridoio, quando arrivava in via Biancamano Mario Rigoni Stern, lo «zio montanaro dalla barba ben curata, che profumava di neve e di aria di bosco», oppure di accompagnare un ancora spaesato Primo Levi all’edizione d’esordio del Premio Campiello, che poi il chimico-scrittore avrebbe vinto con l’odissea post-lager che è La tregua (1963). Sono almeno sei decenni, vale a dire dai primi anni Sessanta, che Ferrero ha le carte in regola per pronunciare la frase che vorremmo dire tutti: io c’ero.
Ciò spiega le ragioni di certe folgoranti definizioni, che disegnano il cartamodello di un abito cucito sulle spalle di chi lo indosserà: Livio Garzanti era «intelligentissimo, timido, aggressivo, geniale, dispotico, imprevedibile, coltissimo, saturnino», Massimo Mila «poteva dire cose durissime con il finto candore di chi recitava la parte del socio di una bocciofila lungo il fiume», Peppo Pontiggia pareva «uno di quei meravigliosi dottori di famiglia di una volta», Bruno Munari era il «maestro del riuso», Franco Lucentini appariva un «candido innocente» e il suo sodale, Carlo Fruttero, era considerato dai due Giulii (Einaudi e Bollati) un «cinico qualunquista», Goffredo Parise «aveva la passione dell’entomologo e l’occhio dell’impressionista», Gianni Celati «viveva sempre con una valigia in mano, nel mondo atemporale della fabula», Pier Paolo Pasolini era «un marxista segnato dall’educazione cattolica, un mistico sconfitto ogni giorno dalla propria sensualità».
L’elenco potrebbe continuare. È fin troppo breve il passo che separa le persone dai personaggi (due termini da non sovrapporre) e, se ormai è diventata totalizzante la cattiva abitudine di volgere a sagoma di personaggio chi invece dovrebbe essere ritenuto semplicemente ed esemplarmente una persona, fa riflettere la maniera in cui si pone chi racconta, cioè Ferrero: mai sul piedistallo del protagonismo e sempre con il piglio dell’umile osservatore che compie uno sforzo nel soppesare bene le parole, nel mettersi al servizio dell’altro e, come se non bastasse, senza mai pronunciare la parola “io”. Può essere che Album di famiglia sia un esercizio di moralità in tempi in cui con troppa facilità si innalzano monumenti e si intonano inni gloriosi a chi ha ancora tanta strada da percorrere prima di arrivare al traguardo.
E può essere pure che comporre quest’opera sia stato un modo attraverso cui, tracciando il riassunto di una parentela, elencando l’organigramma di una comunità che ha creduto in un progetto di vita prima ancora che culturale, Ferrero abbia inteso consegnarci una sorta di «romanzo della scrittura, di tante scritture, del loro farsi, e incrociarsi e nutrirsi reciprocamente». Così facendo, ci ha offerto la “sua” idea di scrittura senza l’arroganza precettistica di chi elargisce segreti nell’usare i ferri del mestiere, ma con l’eleganza di chi cerca conferma negli altri, quasi il segreto di una pedagogia costruttiva fosse nel mettersi da parte, nel recitare il ruolo dello spettatore non passivo, testimone di un tempo gravido di passioni.
Ne viene fuori un umile ed epico manifesto di estetica autobiografica o di autonarratologia, nel segno di un’idea di cultura che rimane inalterata per l’intero sessantennio, dove si fa continuo il rimando (mai nostalgico, semmai malinconico) per quel che oggi consideriamo una stagione di irripetibile fervore intellettuale e dove, a lungo andare, si professa la stessa regola che apparteneva ai chierici: la passione, lo studio, lo sforzo di inseguire il meglio possibile, che poteva essere tanto un magistero espresso in mille pagine quanto la levigata docilità di una costruzione sintattica.
Se è vero che ogni scrittura non è che una maniera per disegnare una cattedrale o un qualsiasi altro edificio, le stanze della letteratura dove hanno vissuto i protagonisti di questo libro esprimono non soltanto la meraviglia dei luoghi perfetti, ma la sorpresa che è esistito un secolo in cui non è stato vano cibarsi di narrazioni e nemmeno accarezzare l’orgoglio di un mestiere che conserva pur sempre caratteri artigianali e mercantili, così come chiedeva quel genio di Walter Benjamin prima di morire. «Con questi famigliari elettivi parlo tutti i giorni» – confessa Ferrero in coda al suo Album di famiglia –. «Sono contento che non possano vedere questo interminabile tramonto d’Occidente, una crisi di civiltà fatta d’ignoranza, appiattimento verso il basso, arroganza, conformismo di massa, frustrazione che diventa violenza verbale e fisica, uso sempre più sciatto e truffaldino del linguaggio».