Il realismo possibile
Abituati come siamo, oramai da troppo tempo, a relegare la virtualità esclusivamente negli spazi futurologici spalancati dai dispositivi di una tecnologia sempre più sofisticata, ci sfugge del tutto che la dimensione plastica della quale la virtualità è intrinsecamente impregnata può realizzare sovrapposizioni e intrecci impensati. Può accadere, per esempio, che nel cuore della pulsante modernità sopravvivano le tracce di un passato arcaico, quasi fermo a una sorta di grado zero della storia. Un impasto temporale del genere risulta talmente «straniante» – direbbe Viktor Šklovskij – da proiettarci in uno scenario dominato da imprevedibili connessioni: tutte virtualmente coesistenti. Dal momento che – come ci ricorda Pierre Lévy in un saggio del 1995, intitolato appunto Il virtuale, che rimane tra i contributi più equilibrati sul tema – la virtualizzazione non coincide con uno scarto dalla realtà, con un suo scivolamento verso imprecisate frontiere alternative; rivelandosi, al contrario, uno tra i principi che generano la realtà stessa:
La virtualizzazione – scrive, infatti, Lévy – passa da una soluzione data a un (altro) problema. Essa trasforma l’attualità iniziale nel caso particolare di una problematica più vasta. […] Così operando, la virtualizzazione fluidifica le differenze istituite, aumenta i gradi di libertà, fa del vuoto che scava un elemento motore.[…] La virtualizzazione è uno dei vettori più importanti della creazione di realtà.
L’ultima affermazione di Lévy – raramente recepita – riveste una funzione decisiva nel liquidare i più diffusi stereotipi riguardo ai presunti scenari sconosciuti che la virtualità dovrebbe portare alla luce. Essa, ribadisce Lévy, coincide, al contrario, con uno dei dispositivi più potenti ed efficaci nel processo di creazione della realtà. L’estensione, dunque, della virtualizzazione coincide sempre con un incremento di realismo. Anzi, incarna la quintessenza del realismo: di una realtà, cioè, che si manifesta nella sua connaturata incompiutezza e indeterminazione.

Peccato che proprio questo inestricabile intreccio tra virtualità e realismo sia del tutto assente nel breve saggio di Walter Siti – accolto forse con eccessivo fervore –, Il realismo è l’impossibile, recentemente pubblicato da nottetempo. A numerosi lettori è apparso come un definitivo, e accattivante, bilancio sulla questione, da qualche anno rilanciata al centro del dibattito estetico, del realismo: sul suo statuto e sulla sua variegata fenomenologia riproposta negli ultimi tempi da vari fronti della creazione letteraria e artistica.
Come tutti i bilanci, però, il saggio di Siti corre il rischio di risultare – nonostante l’abile montaggio di citazioni – una ricapitolazione generica dei più diffusi luoghi comuni riguardanti il problema del «realismo» letterario, molti dei quali già accantonati dallo stesso autore nel corso della sua produzione narrativa: di ben altro spessore e qualità rispetto a questa sorta di “ammissione poetica”, come Siti esplicitamente la presenta.
C’era davvero bisogno, infatti, di ribadire – con un semplicismo davvero sconcertante per uno scrittore smaliziato quale Siti – che «si giunge […] a riconoscere un’orma realistica in quelle scritture non mimetiche (non ingannevoli quanto al loro statuto di finzione) che hanno però come obiettivo ultimo quello di illustrare qualche strato profondo della realtà»? O di puntualizzare, ancora una volta, che la «tecnica realista è un inseguimento infinito a rappresentare zone sempre più nascoste e proibite della realtà, impiegando artifici sempre più sofisticati e illusionistici»?
Ci troviamo di fronte, appunto, ai resistenti luoghi comuni di una tradizione epistemologica – prima ancora che estetica – rivolta a considerare la realtà come qualcosa di già dato, di già compiuto una volta per tutte: a cui la raffigurazione artistica può scegliere di aderire mimeticamente o, viceversa, secondo l’indicazione di Siti, può opporre uno scavo analitico condotto al suo interno, che renda visibile quanto sfugge ai modelli percettivi conformati sull’abitudine. Ma, in entrambi i casi, non cambia assolutamente lo statuto della realtà: del tutto assimilabile a un dato pre-esistente all’atto che la rappresenta, la raffigura. Anzi, la crea, si potrebbe dire (come, ripercorrendo una lunga e ramificata tradizione, ho tentato di ricostruire nella Potenza del falso, Donzelli 2004, prima di addentrarmi nello scenario letterario e mediatico della contemporaneità attraverso Politiche dell’irrealtà, Bollati Boringhieri 2011).
Il conflitto teorizzato da Siti quale presupposto di un realismo non di maniera, ma radicalmente eversivo nei confronti della medesima realtà che vorrebbe rappresentare, rimane, di conseguenza, completamente interno al perimetro conoscitivo che egli aspirerebbe a superare. Non basta, infatti, «sospendere e battere in breccia gli stereotipi» (parola d’ordine di tutte le poetiche dello «straniamento»: da Šklovskij a Brecht) per allargare l’orizzonte del senso. La portata critica di un simile gesto si è ampiamente consumata nel corso delle sue innumerevoli riproposizioni che, nei vari ambiti della creazione artistica, si sono succedute lungo il Novecento: fino a diventare oggi un atto decisamente sterile, privo di qualsiasi funzione conoscitiva.
Ma perché non tentare di affrancarci dall’ineliminabile angustia che il concetto di realismo comporta? Perché non spostare l’epicentro della creazione artistica verso una realtà raffigurata nel suo continuo, fluido, divenire? Una realtà animata dal battito inquieto e incessante del dispositivo virtuale. Ricordandoci, appunto – secondo le parole di Lévy riportate in apertura –, che «la virtualizzazione è uno dei vettori più importanti della creazione di realtà».
Che un processo del genere non dipenda necessariamente da sofisticati circuiti tecnologici, anzi venga esaltato dal contatto con la realtà più povera e dimessa, regolata da leggi arcaiche, immobili nel tempo, lo dimostra con particolare vigore l’ultimo romanzo di Paolo Di Stefano, Giallo d’Avola, appena pubblicato da Sellerio.

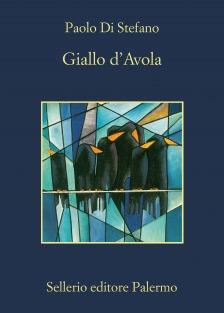
Come nel precedente romanzo-inchiesta La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 1956 – pubblicato da Di Stefano nel 2011 –, nulla ha i caratteri della consistenza; la stabilità è solo una fugace impressione, tutto è reversibile; ma insieme reale, terribilmente reale: quanto la lunga detenzione di un innocente. Ecco l’esito al quale giunge la narrazione di Di Stefano, confrontandosi con le sconcertanti mutazioni di una realtà che, a ogni passo, rivela la propria incompiutezza, virtualmente inesauribile. Eppure lo scenario solcato dalla scrittura di Di Stefano – lo abbiamo appena sottolineato – non potrebbe essere più reale. Il romanzo rievoca, infatti – analizzandolo con la massima puntualità documentaria –, un episodio giudiziario effettivamente avvenuto in Sicilia nei primi anni ’50 del secolo scorso.
Ad Avola, un paese in provincia di Siracusa, l’antica faida che vede coinvolte le famiglie dei fratelli Salvatore e Paolo Gallo sembra improvvisamente concludersi con la scomparsa di Paolo. Anche se non si trova il cadavere, tutto lascia supporre che si tratti di un omicidio il cui autore, naturalmente, non può che essere il fratello Salvatore, nel giro di poco tempo condotto agli arresti. Ecco il prologo della vicenda, pazientemente ricostruita da Di Stefano consultando atti giudiziari, testimonianze orali e cronache di giornale. Ma non solo: perché – egli stesso avverte – «essendo un romanzo», l’autore «si prende la libertà di usare anche la fantasia». Adoperata in parte come una sutura tra i vari ordini di fonti consultate, ma considerata principalmente (alla stregua di Truman Capote in A sangue freddo, di Leonardo Sciascia in La scomparsa di Majorana e L’affaire Moro o di James Ellroy nei Miei luoghi oscuri) nei termini di una chiave esegetica indispensabile per orientarsi nei labirinti di un episodio di cronaca tutto ipotetico, che si svolge all’insegna della pura virtualità. Subito dopo l’arresto di Salvatore Gallo, infatti, una folla di indizi contrastanti si addensa intorno alla vicenda del «morto-vivo di Avola», come viene ben presto definita. Mentre si continua a cercare il cadavere del presunto morto, l’evidenza è un criterio unanimemente liquidato dalla folta comunità di avvocati, giornalisti, parenti e, soprattutto, dal coro di voci popolari: pronte – nella loro ancestrale ritrosia – a confermare, per poi ritrattare senza scrupoli, le testimonianze più sconcertanti.
Di Stefano ha compreso pienamente – ed è il suo merito principale – che il ricorso alla fantasia del narratore risulta obbligato dai fatti stessi oggetto del racconto: dalla loro iscrizione in una cornice che scivola fin dall’inizio verso una dimensione fantastica. Come giudicare altrimenti l’incredibile sequenza di capovolgimenti giudiziari che si susseguono nel corso della vicenda? Dopo lunghe ricerche il presunto morto verrà trovato vivo, in preda a un’ansia persecutoria che lo ha portato per anni a nascondersi. A questo punto sostituirà in carcere il fratello innocente. Ma non è finita. Quando oramai il «caso d’Avola» è balzato nella cronaca politica e di costume nazionale, si riapre – in base a una nuova norma giudiziaria – il processo, che decreterà nuovamente la colpevolezza di Salvatore per lesioni gravi ai danni del fratello.
Accanimento giudiziario? Non proprio. Più semplicemente si tratta di una esemplare dimostrazione dell’implausibile connubio tra realtà (anche quella realtà nascosta, profonda, che Siti vorrebbe portare alla luce) ed evidenza. Ben presto, trascinati dal flusso di ipotesi che si sovrappongono, dalle «molteplici versioni» in circolazione, i personaggi si trasformano in ombre, in sagome sfuggenti: capaci di sflilare tra gli interstizi di una realtà che essi stessi stanno contribuendo a creare, nell’atto di renderla un campo di tensioni virtuali. All’interno del quale il «vago» e l’«incerto», le «scorribande fra le nuvole» - come le definisce Di Stefano – costituiscono l’unico contrassegno della realtà. La sola alternativa per un realismo davvero possibile.









