Giulio Bedeschi / L'8 settembre degli Alpini
8 settembre 1943: Badoglio, successore del da poco deposto Mussolini, annuncia in modo ambiguo l'armistizio con Stati Uniti e Gran Bretagna e la conseguente ostilità verso l'ex-alleato tedesco; una data capitale della nostra storia che i militari interpretarono in senso opposto: nel generale sfaldamento dell'esercito, attraversato dalla prepotente spinta dei soldati al ritorno a casa, ci fu chi seguì, magari in modo contraddittorio come a Cerfalonia, le indicazioni del governo, pagando con la vita, e chi ritenne di restare fedele al Patto d'acciaio, per esempio Junio Valerio Borghese e la sua X Mas. L'interpretazione opposta prevede una fine contro un inizio. La Monarchia fornisce al fascismo una straordinaria occasione per rifondersi artatamente alla patria, morta seconda una lunga tradizione che va da Salvatore Satta a Galli Della Loggia, e farsi portabandiera della sua rinascita rinascendo esso stesso a Salò sulle ceneri del tradimento e il mito del riscatto. In quei giorni Duccio Galimberti a Cuneo chiede di poter arruolare i suoi volontari tra gli Alpini, usando subito contro i Tedeschi le armi dei magazzini, ed offre agli alti ufficiali il comando delle formazioni pronte alla resistenza, ricevendo risposte negative che oscillano tra la stanchezza e la diffidenza altezzosa per gli irregolari; il sodale Dante Livio Bianco, nelle sue memorie dal titolo Guerra partigiana, nota la paralisi e il disorientamento e ripaga con un certo sprezzo: “restava ancora una maschera di albagia e di sufficienza militaresche, di tenuta esteriore; ma dietro già si poteva scorgere, realtà paurosa, il vuoto e l'inconsistenza morale”. Di qui la scelta, nata su una visione dinamica della data fatale, di costituire la banda «Italia libera» ispirata all'idea di Resistenza come Secondo Risorgimento.
Giulio Bedeschi, di cui ricorre l'anniversario dei trent'anni dalla morte, è ormai cristallizzato, specie a livello di antologizzazione scolastica, nella catastrofe degli Alpini in ritirata dalla Russia, resa nel romanzo autobiografico Centomila gavette di ghiaccio (1963). E tuttavia dello scrittore, che curiosamente era nato ad Arzignano nell'anno dell'inizio per l'Italia della Grande Guerra, fulcro dell'epopea alpina, vorremmo parlare attraverso un altro romanzo, Il peso dello zaino (Mursia 1978), capace di incrociare anche una rievocazione dell'8 settembre. Siamo ancora tra gli Alpini, reduci di Russia, che mostrano nel fitto dialogato idee diverse sulla data cruciale del 1943 (per esempio sul comportamento che assumeranno i Tedeschi e la legittimazione a combatterli), permettendo di dar conto dell'incertezza e tenendo in posizione neutrale il narratore. Il quale tuttavia, registrando il caos attraverso la figura retorica dell'accumulazione, ne sottolinea il sacrilego mercato, il travestimento dei soldati, il saccheggio causato dalla fine di ogni regola; così dolorosamente si svela il sentimento di Bedeschi, con una eco del Gadda del Giornale di guerra e prigionia nei giorni di Caporetto quando appuntava “gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate)”.
Dal quadro convulso a tinte fosche si isolano poi singoli episodi, come la vendita a prezzo di saldo d'un cavallo dell'esercito, che va in mano ad un ragazzino inesperto presto disarcionato, o come le risse fra chi ha già trafugato e chi è ancora a mani vuote, e infine gli insulti ai soldati: “– Non ne avete ancora abbastanza di guerra, disgraziati? – urlò un'altra voce. – Andatevene a casa vostra, che è ora! – rincalzò una terza.” Con visione caleidoscopica Bedeschi fa il giro dell'Italia, raccontando vicende della giornata fatale a La Spezia e a Platischis, e soffermandosi in particolare sul pericolo della subdola avanzata titina: “Gli iugoslavi ci vengono incontro cantando, ci abbracciano, poi all'improvviso ci saltano addosso, ci spogliano, ci portano via le armi, ci catturano, ci fucilano...”. In questo frangente, particolarmente sensibile per tutti gli italiani e in particolare per gli Alpini, in quanto mette a rischio le conquiste della Grande Guerra e lo stesso suolo patrio, ancora meglio si coglie il dramma della crisi e la ferita nascosta del narratore: “Trecento soldati mi sono rimasti, trecento fantocci, l'altra metà se la sono tenuta gli iugoslavi per ricordo dell'otto settembre! Li vedete? Pezzenti sono diventati, vagabondi! Roba da farci prendere a sassate!” Sempre con cautela per sé, dando cioè voce ai personaggi, anche quando più accesi e disperati, il narratore è comunque univoco nell'indicare che le responsabilità vengono dall'alto. Si comincia alzando ipotesi ancora fondate sulla buona fede (“Ma perché dopo il proclama del giorno otto non si sono più fatti vivi? Che siano prigionieri di qualcuno?”), o di reazioni in attesa solo di una parola (“Qualcuno che si faccia sentire, che dia gli ordini anche se la guerra è perduta.
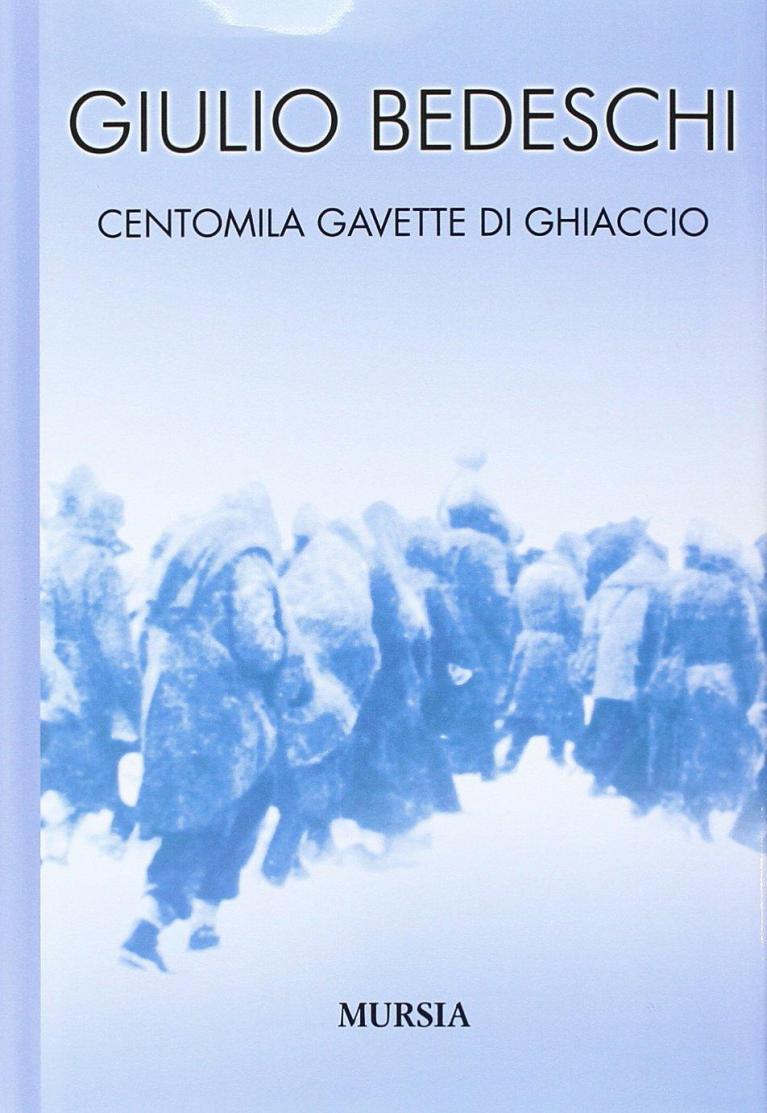
Perché, se adesso arriva finalmente un ordine di stare uniti e ci accorgiamo che c'è chi pensa anche a noi, non ti alzi anche tu, non ci alziamo tutti qui dentro?”), per passare alla constatazione dello sfacelo: “Finito tutto. Non abbiamo più Comando di reggimento. Sciolto, da stanotte. […] Hanno cominciato a catturare anche gli alpini, in località diverse. Conclusione: non esiste più una organizzazione militare che tuteli i soldati in divisa.”
Gli sviluppi successivi vengono ugualmente considerati con sguardo panoramico che abbraccia i vari esiti possibili attraverso i differenti destini dei personaggi. L'alpino Scudrera, già seguìto nelle sue vicende ospedaliere dovute al congelamento in Russia, avendo ricevuto il foglio di licenza illimitata per smobilitazione da un coraggioso superiore, si dirige verso casa con la fida mula, così come faticosamente si avvia il medico militare Serri, nel suo caso verso sud. Incisivo, seppur rapido, lo schizzo di un gruppo, guidato dal sottufficiale Bortolan che, impedito nel ritorno dai Tedeschi, per opportunità e per reazione sceglie la Resistenza: “– Bene – aggiunse poi con improvvisa energia – lo hanno voluto loro, li avete visti. Ci fanno prigionieri? Non si può camminare sulla nostra pianura? Andare a casa nostra? E io vado in montagna! Vengano là a beccarmi, se sono capaci. Le armi sappiamo dove sono, li voglio vedere!” Ma certo più a cuore stanno a Bedeschi il soldato semplice Pilòn e il capitano Reitani, su cui costruisce sapientemente una mitologia del sacrificio in piena continuazione con Risorgimento, Grande Guerra e campagna di Russia, fuori dalla guerra civile, in una disperata, e un po' mistificatoria, prospettiva nazionale centrata sul corpo degli Alpini.
Pilòn, puro alpino dell'eterno dovere, è alla ricerca, testarda e accorata, di un ordine superiore a cui attenersi: “doveva pur esserci un Comando supremo che riuniva le fila, un esercito non si può distruggere senza combattere un bel po'.” Egli non accetta una fine così imprevista e chiedendo qua e là come il viandante nella bufera, magari ai sióri ufficiali perché “più su si va più c'è gente che capisce”, alla fine si dirige, come un mistico dell'altezza, a Udine, dove forse ancora ci saranno i riferimenti della Divisione e del Corpo d'Armata. Nella città in subbuglio il conducente di muli trova finalmente la sede, vasta e deserta di sentinelle, con qualche soldato scamiciato nel cortile che lo guarda con ironia perché ancora affardellato e armato di tutto punto; lo scalone d'onore è silente, le porte che apre intimidito e chiedendo il permesso rivelano il vuoto. È la scena bloccata di un crimine, di un maniero per fantasmi, di un’apocalisse misteriosa che ha lasciato intatti rastrelliere con le armi, portacenere con le cicche, ricchi oggetti lucidati, risucchiando chissà dove la presenza umana. L'ufficio del CAPO DI STATO MAGGIORE, IL GENERALE COMANDANTE è proprio l'approdo tanto ricercato, quello della speranza e della risposta sul luogo dove presentarsi dopo tanto girovagare; si ferma davanti alla fotografia del re, che gli ricorda il vecchio nonno comprensivo, e non può far altro che restare sull'attenti di fronte a quel simulacro di umanità e di autorità. Poi risponde a una telefonata incomprensibile, dicendo che lì non c'è più nessuno, e sentendo il crepitio di una raffica si affaccia alla finestra.
Lo troveranno i Tedeschi che stavano appunto prendendo possesso dell'edificio. L'integrità quasi assurda dell'Alpino, simile a quella degli eroi asburgici travolti dal tracollo di un mondo, grida muta lo sdegno dell'Italia povera e migliore, ma tradita e sacrificata. Campione del sacrificio come il padre nella Grande Guerra, Pilòn non è stato però ripagato dalla nazione, né dopo la Russia né dopo l'8 settembre o il '45, se non dal monumento che Bedeschi consapevolmente gli erige in memoria: “il grande pubblico aveva chiaramente inteso che io non avevo voluto fare una esaltazione del militarismo né tanto meno di una guerra addirittura perduta, ma mi battevo invece per contribuire al riscatto e al riconoscimento di una dignità individuale che in due decenni di dopoguerra da molte parti si tendeva grossolanamente e improvvidamente a far stemperare e dissolvere nel grande calderone della sconfitta.” Così chiosa nella sua introduzione intitolata Il perché di un libro.
Se la morte di Pilòn rappresenta l'olocausto dell'ingenuità, quella di Reitani si basa sulla precisa volontà di restare fedeli al patto italo-tedesco e nel contempo sottrarsi al prevedibile spargimento di sangue fraterno causa il “richiamo dei due marescialli, a nord e a sud”. L'obiettivo dichiarato, ma fallito, da tanti memorialisti repubblichini coinvolti nella lotta antipartigiana, trova l'uovo di Colombo nel reduce della ritirata dal Don che chiede di essere rimandato a combattere nella steppa: “il maggiore che ascoltò la sua richiesta riteneva la cosa difficile ma non impossibile: allora Reitani compilò un modulo, firmò la domanda d'essere inviato come volontario a quel battaglione misto che stava combattendo in linea sul fronte russo.” La patria lacerata dalla storia viene quindi disconosciuta con freddo raziocinio a favore della patria del cuore, quella dei compagni morti; “sento che ormai per me esiste soltanto un posto dove mi sia possibile continuare a vivere: il più vicino ai miei artiglieri alpini rimasti sul fronte russo.” Quel continuare a vivere vuol dire in realtà raggiungere la schiera sventurata e gloriosa dei caduti. Il recente ricordo si trasforma allora in una febbrile visione bianca, degna del finale del Gordon Pym di Poe, che torna a rianimare di vivi fantasmi il vuoto accecante:
– Sono arrivato – pensò Reitani nel raffrontare quella vista all'eguale ricordo: e subito intravvide le tane nevose degli alpini del Tolmezzo infittire le buche, e dietro a queste, schierati fra i pezzi, gli uomini della sua tredici come al tempo di Novo Kalitwa, prima che il gelo li separasse disperdendoli sulla neve d'Ucraina. […]
il prepotente richiamo cominciò a popolargli d'alpini la neve, e sulle slitte immobili i congelati e i feriti spasimavano di speranza, affissavano lo sguardo sui combattenti bloccati dai russi sul pendio oltre la ferrovia.
Il silenzio ed il bianco sigillano come un sarcofago il corpo di Reitani abbracciato ai suoi e la neve lo purifica dalle contraddizioni della storia: “Ingoiava la vita degli uomini e restava candida, intatta”. Il turbinio mortuario della neve sulla Grande Guerra, sulla spedizione dell'Armir e sulla sua ultima coda “conclude”, anche se “non risolve”, il cerchio dell'epopea degli Alpini, tutta sacrificio e solidarietà, consegnata in piena luce acritica da Bedeschi. Il quale così tramanda anche sé stesso soltanto come testimone e cantore di quella dolorosa e incolpevole vicenda, tralasciando la sua oscura partecipazione alla Brigata Nera «Arturo Capanni» di Forlì, operante con particolare accanimento nel vicentino, che infatti non viene minimamente accennata nella biografia di due pagine al fondo del libro (Mursia edizione 2018), dove campeggia invece la foto dell'autore con penna in mano e penna nera sul capo.









