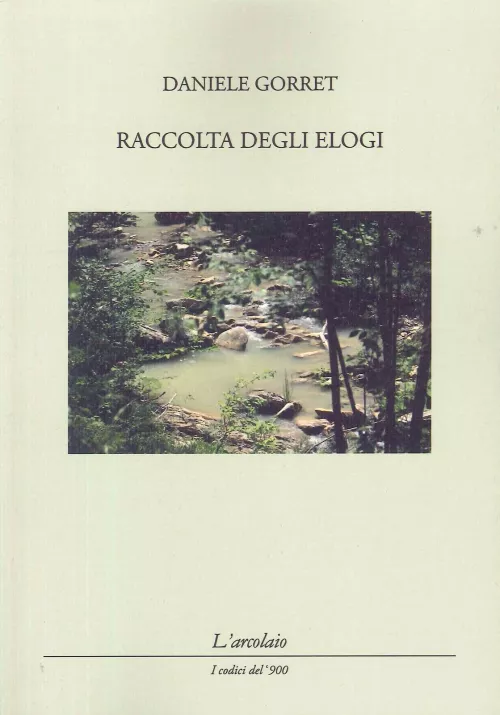La celebrazione dell’inconsistente di Daniele Gorret
Daniele Gorret è una figura appartata quanto originale che da quarant’anni e più sta costruendo un’opera complessa e unitaria pur nella varietà di generi toccati (narrativa, poesia, testi teatrali e di altra natura, tutti segnati da un forte accento poetico e, in senso profondo, etico e civile).
Nato ad Aosta nel 1951, Gorret ha esordito come narratore nel 1984 con Sopra campagne e acque (Guanda) a cui è seguita una quindicina di testi in prosa, tra i quali Avventure di vita e avventure di morte di Silvano Ligéri (Manni, 1998), Eventi in un giorno di Emilio Tissot (Mobydick, 2000) e la trilogia dedicata al personaggio di Anselmo Secòs.
Tra i suoi libri in versi citiamo Ballata dei tredici mesi (Garzanti, 2003), Che volto hanno (LietoColle, 2011, Premio “Il Meleto-Guido Gozzano”), Quaranta citazioni per Anselmo Secòs (LietoColle, 2015, Premi “Carducci” e “Rubiana-Dino Campana”: vedi la recensione di Franca Alaimo) e Carni (Pequod, 2021).
A lui si devono anche importanti traduzioni di autori francesi classici e del secolo scorso, da Sade a Céline, Gide, Caillois, Malraux, Blanchot.
L’ultimo suo libro è Raccolta degli elogi uscita da poco presso L’arcolaio editore, (Forlimpopoli, 2022).
Il libro inizia con l’emblematico La fatica del fiore: un seme, messo in un vaso, diventa fiore. L’umano, l’essere umano, aiuta a far nascere e crescere il fiore, versandogli dell’acqua nel vaso. Altro non può fare se non esprimere riconoscenza per questo sforzo del seme che preme da sotto la superficie della terra e punta a diventare fiore.
In La panettiera resistente, l’anziana panettiera continua con amore a creare il pane. Resiste, nonostante lo scetticismo dei compaesani e nonostante intorno a lei proliferino i supermarket, dove la panetteria è solo un reparto.
In Il sonno pomeridiano, qual è il sonno più bello? Vuoto, senza sogni e brevissimo, è il sonno pomeridiano, più riposante del travagliato e interrotto sonno notturno.
In L’ambulante e il suo furgone, l’ambulante viaggia e vive con il suo furgone, nel suo furgone. Si nutre dei frutti, delle verdure, delle marmellate, delle conserve che non ha venduto. La notte dorme beato nel furgone come in una casa prestigiosa, fino a quando la luce del sole non lo sveglierà. È una condizione autarchica e regale, al di là e al di sopra dei commenti sprezzanti del prossimo.
In Il merlo morente c’è l’incanto per la prova di perfezione che dà l’animale morente.
In Il ghiacciaio ostinato, in un angolo appartato delle montagne, c’è un piccolo ghiacciaio senza nome che, nonostante sia offeso dalla polvere e dal fumo, non si arrende. Non si estingue, resiste, anche lui come la panettiera, come un vulcano che dovrebbe essere spento e invece erutta ancora lava.
In L’auto addormentata, invece, si fa l’elogio dell’automobile che dorme un suo sonno di cofano e bulloni e da sei anni attende paziente nel garage.
In La tomba disadorna, il viandante si ferma e depone sulla tomba di uno sconosciuto una margherita di plastica e qualche foglia di edera, sottratta alla tomba vicina. È una tomba abbandonata, di cui non si decifra più nemmeno il nome. Si riconosce solo la foto di un uomo con i baffi e la barba.
In Il coniglio straziato e in Il vitello al macello c’è la pietas e lo sdegno per il maltrattamento e per l’uccisione degli animali da parte dell’uomo che sfociano nell’esclamazione: «è cristo messo in croce.» (p.40). Ed è uno scandalo: a essere paragonato a cristo (con la c minuscola) non è un essere umano ma un coniglio! Un coniglio massacrato dalle torture somministrate per gioco da tre bambini.
E poi l’elogio dell’albergo abbandonato, del biancospino d’inverno, della bambola senzanome, del vecchio diario, della viola di montagna, dell’insegnante appassionata, della maialina mascotte, del bambino down, della notte contemplata dal terrazzo, ma anche della probità, del senso del dovere, della nostalgia, e così via, di elogio in elogio, fino a concludere con La pratica del suicidio, che non è un elogio del suicidio, ma la rievocazione funebre, intensa e delicata, di una serie di persone che si sono suicidate: Giuseppe lo spazzino, Piera casalinga e non poche altre.

Mancano le precise coordinate spazio-temporali (nomi di località, date). Dai riferimenti testuali si può dedurre che ci troviamo in un borgo di montagna. Gli elogi mettono sotto i riflettori e rivelano un microcosmo di cose e di persone, isolate, confinate, anomale, perdenti, a volte reiette ma più vive di quelle vincenti, conformi ai modelli e ai valori dominanti che restano come un coro crudele sullo sfondo della scena. Non prive di una loro specifica resilienza resistono in un ambiente ostile. C’è una sorta di filosofia che l’autore espone ne Il concetto di cosa dove, tra cose e persone, a volte sono le cose abbandonate (un ferro vecchio, un abito tarlato) a risultare più umane, significative e autorevoli, di certi viventi e importanti uomini.
Cose si alternano a persone e animali, in questa Raccolta degli elogi di Daniele Gorret, ma non c’è differenza sostanziale tra le une e le altre, se non che le cose e gli animali si rivelano più umani dell’uomo. Tutte sono vive e con una intensità direttamente proporzionale alla loro marginalità sociale. Le più rilevanti sono quelle considerate meno importanti, le più emergenti quelle oscure, come il seme nella terra.
È, anche, il mondo del passato che, attraverso oggetti dimenticati nei cassetti, o abbandonati negli angoli del mondo o nelle discariche della memoria, riaffiora e ci fa rivedere e risentire con forza. Paradigmatico è Il vecchio diario, un diario di quarta elementare, ritrovato tra quaderni di compiti e pagelle. Il settantenne che lo rinviene prova la stessa vertigine dell’archeologo che scopre una tomba e nella tomba il corpo intatto dell’imperatore o del faraone, testimonianza viva di un antico vissuto.
È ineludibile il collegamento con la poesia crepuscolare, in particolare con la poesia di Gozzano sia per le tematiche sia per la prosodia. Anche in Gorret c’è il predominio di un endecasillabo dal ritmo ternario, con un andamento prosastico, descrittivo, con una presenza non esibita, ma diffusa, mimeticamente e ironicamente nascosta nella colloquialità, di anafore, rime, assonanze, consonanze, paronomasie. Come notava Montale, l’ironia di Gozzano mandava scintille facendo cozzare l’aulico con il profano. Famigerata la rima di nietzsche con camice. Solidale con il microcosmo che descrive, l’ironia di Gorret è meno vistosa, più recondita, stranita e inquieta, ma non meno penetrante di quella di Gozzano.
Le assonanze e le consonanze prevalgono sulle rime: «Pur avendone forte desiderio/ (desiderio di viscere e cervello),» (p.14), «questa mia/ riconoscenza per la sua fatica:» (p.14), «è solo un reparto; nel resto c’è di tutto…/ Lei sopravvive o forse vive sotto:» (p.18), «tutto oramai è fatto industriale,/ lei è legata, lei non sa avanzare,» (p.18), «una cosa che piace e che s’aspetta./ Tempo mezz’ora e questa cosa bella» (p.20), e la strategica assonanza di cosa/parola (p.58).
Non mancano gli anagrammi: «Veranda veneranda» (p.22), «spiazzo spazio» (p.26), «bambina bimba» (p.60) e non mancano certo le rime, soprattutto rime identiche, e le paronomasie. In Il concetto di cosa (p.58), ad esempio, la rima interna di cosa con qualcosa nel primo verso e nei versi successivi. In La bambola senzanome: bambina che rima con Marina, azzurrina e la paronomasia «bambina bambola» (p.60).
In tutto il volume sono frequenti le anafore e le riprese dello stesso vocabolo nello stesso verso o in quello successivo. Per esempio in Il merlo morente, la voce morte, si ripresenta identica e in varie declinazioni: mors, morire, muore.
Queste figure del suono costruiscono un fitto tessuto di rimandi fonetici, di ripercussioni, di echi, che richiamano, alla lontana, cantilene, nenie dei canti funebri. È Cicerone a proporre la derivazione del latino nenia dal greco nenìa, elogio funebre del morto, accompagnato dal flauto. Elogio del morto che si può trovare nelle nenie delle prefiche. In latino, elogium, significa iscrizione sepolcrale, epitaffio.
Insomma, si percepiscono, in una versione nuova, tracce di un’antica vocalità che passa anche attraverso la tradizione poetica medievale del plazer.
Il vocabolo elogio, nell’uso moderno, è una voce dotta, con una patina vagamente obsoleta e altisonante. Fare l’elogio vuol dire celebrare, fare l’encomio, il panegirico, la glorificazione di qualcuno o qualcosa, di solito dell’uomo potente o del vincitore.
La Raccolta degli elogi di Gorret recupera e capovolge questi usi e costumi, antichi e moderni, dell’elogio. Le cose e le persone che salgono sul podio e vengono intervistate e incoronate sono, cristianamente, gli ultimi, quelli che di solito non vengono elogiati, ma sono tenuti nascosti o segregati o dimenticati o, se ricordati, vituperati o messi alla berlina.
Ed è quanto, con maieutica consapevolezza, dichiara l’autore medesimo nella Premessa prosaica. Lode dell’elogio: «Pensare l’elogio d’un qualcosa (un altro da sé, uno di fronte) vuol dire volerlo carezzare e, volendolo fare, farsene carezza. […] formulare un elogio vuol dire: stare in colloquio col silente, udire ciò che il messo a tacere o lo scordato avrebbero, dentro di sé, da far sapere… E insieme vuol dire dare la parola, fargli – da lontano – comprendere “Ti ammiro”. […] Vuol dire rovesciare maggioranze, detti sicuri, larghe convinzioni; non temere di stare con i pochi, gli umili sulla terra, i sempresoli. Anche vuol dire: amare il rifiutato, il pensato immondizia, colui che per i più non vale niente.» (p.11).