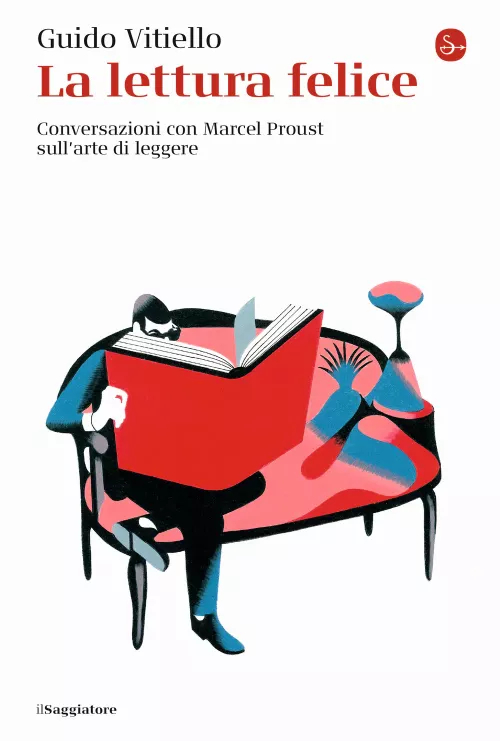La lettura è inevitabile
L’ultimo libro di Guido Vitiello La lettura felice. Conversazioni con Marcel Proust sull’arte di leggere (Il Saggiatore, 2024) appartiene a un genere quasi inclassificabile: rappresenta insieme un commento, una risposta e una digressione a partire da uno dei più famosi saggi di Proust, Giornate di lettura, uscito per la prima volta nella Reinassance latine il 15 giugno 1905, e dall’articolo dallo stesso titolo dedicato alle Memorie della contessa di Boigne, pubblicato invece su «Le Figaro» il 20 marzo 1907. Entrambi i testi sono compresi in questo volume, stampati in azzurro, come in azzurro sono le citazioni dalla Recherche, mentre le pagine di Vitiello sono scritte in nero. Il sottotitolo è preciso e apparentemente infedele perché per Proust, e a differenza di ciò che hanno creduto Machiavelli e Cartesio, la lettura non è affatto una conversazione, ma la comunicazione di un altro che ci arriva senza toglierci dalla nostra solitudine, ossia dalla condizione in cui conserviamo la nostra maggior forza intellettuale. Potremmo sostenere che la conversazione non è data quindi dalla lettura ma, appunto e idealmente, proprio dalla scrittura: è questa scrittura ravvicinata in risposta al testo che ci permette di sperimentare in concreto l’illusione di condividere lo stesso tempo dell’autore.
Il saggio di Proust apparve come prefazione alla traduzione francese di Sesamo e i gigli di John Ruskin – che aveva curato con Marie Nordlinger – e comincia con buone sedici pagine di ricordi delle letture d’infanzia, dove compaiono la casa della prozia e i suoi giudizi inappellabili, la passeggiata per Méséglise, gli amati biancospini e infine la camera del narratore, tutti dettagli che ritorneranno nel romanzo proustiano. Le pagine successive dedicate alla lettura ricordano dettagliatamente come questa ci mantenga vicini a noi stessi mentre la conversazione disperde la nostra concentrazione e, nello specchio degli sguardi, ci espone al rischio di tener conto più dell’effetto delle nostre parole, che dell’intento comunicativo. Anche nel caso dell’amicizia la conversazione si rivela frivola. Varrebbe la pena di sottolineare come Proust, che descrive in modo supremo gli infortuni della conversazione dei salotti, riconosca più raramente che in un contesto meno prestigioso e più povero – nel quale i vantaggi delle informazioni custodite o meno si rivelano quasi inconsistenti – l’amicizia riesce ad assumere un carattere concreto (in questo senso nella Recherche ricorderei la franchezza di Jupien o per altri versi di Elstir).
Vitiello riferisce di aver letto Alla ricerca del tempo perduto durante il lockdown, dopo aver cercato per anni di sfuggire alla necessità di affrontarlo, destinandolo ai giorni indefiniti della pensione. Eppure, ci racconta che fin da bambino coltivava precoci interessi di lettura, un rapporto stretto con la madre – il padre andava a dormire presto – e rituali di coricamento elaborati e rigidi quanto quelli la cui infrazione tormentava il piccolo Marcel. Commentando Giornate di lettura (il più lungo dei due saggi omonimi) Vitiello distingue la lettura felice dalla lettura infelice del geloso, un detective per cui l’indagine conta più della soluzione, poiché ogni scoperta non è che una conferma della sua inadeguatezza. Nel romanzo di Proust la gelosia di Swann, l’ossessione delirante davanti alla finestra del palazzo dove abita Odette si riflette su un piano diverso in quella del Narratore per l’infedeltà di Albertine che questi vive in modo più concreto e conseguente (la sua vicenda non è che una replica più definita di quella sterile di Charles Swann). E il percorso con cui Vitiello segue alcuni temi ricorrenti della Recherche, il wagnerismo, o il ruolo dei quadri e di ciò che la lettrice vede alla finestra – sia questo ciò che resta fuori scena in un dipinto di Vermeer, sia invece ciò che appare nel magnifico precedente dato dal Maestro di Maria di Borgogna – lo porta a scrivere alcune delle pagine più convincenti del saggio, a partire da un’intuizione generale la cui verifica lo ha condotto a seguire una nutritissima letteratura secondaria. Per lui, quando nella modernità gli esseri umani hanno affidato le proprie speranze di redenzione non più a Dio ma all’amore romantico, la vita di relazione si è fatta quotidianamente più infelice.

«In questa nuova religione ben più spietata dell’antica, l’innamorato corrisposto e quello respinto presero il posto dell’eletto e del reprobo; l’oscillazione indecidibile della salvezza e della dannazione volle chiamarsi civetteria; e i testi sacri da interrogare per conoscere il destino eterno dell’anima, una volta scesi dai messali e dai leggii, poterono presentarsi in abiti borghesi e mimetizzarsi in forme più quotidiane: per esempio, nel manoscritto striato d’oro di una finestra a gelosia». (p. 166)
Si potrebbe osservare che la menzogna romantica continua a tormentare trasformando le relazioni di cui siamo testimoni in quelle di modelli/rivali che ci circondano. In questa prospettiva la gelosia diventa una modalità operativa dell’amore che porta a invidiare continuamente il posto occupato da un altro o da un’altra. L’amore, che era un mezzo per comprendere l’assoluto – con tutta la tradizione dell’intelligenza d’amore – nella modernità è diventato fine a se stesso, inesauribile e incerto perché privo del vertice superiore del triangolo, che garantiva stabilità ai due angoli inferiori della relazione. Come aveva ben compreso Schopenhauer, questo inganno della natura sopravvive e assume una vera durata nel tempo solo se si affianca e cresce nella stessa relazione accanto alla sua versione disinteressata, ossia all’amicizia (di nuovo, nella Recherche penso al rapporto fra Jupien e Charlus, o quello fra Andrée e il marito).
Diversamente, rischiano di durare solo forme patologiche, come per Schopenhauer lo diventano spesso certi matrimoni costruiti solo sull’attrazione; oppure come l’érotomanie di cui parla Vitiello ricordando le osservazioni dello psichiatra francese Clérambault su una paziente il cui problema partiva da un postulato fondamentale e indiscutibile «il re mi ama». A questo principio era appeso un delirio inespugnabile: il re l’ha prescelta ma non lo dice perché non può mostrarlo apertamente; tutte le persone che lei incontra sono «emissari dell’uomo amato», tutte le parole sono sue missive travestite. L’universo intero congiura contro di loro, ma naturalmente il bene dovrebbe trionfare.
Nella sua storia di genere multiforme e inafferrabile il romanzo è stato a lungo un antidoto contro tutto questo, prima di reificarsi nella versione vagamente ottocentesca e affettuosamente intramontabile della letteratura editoriale. Vitiello riporta le pagine del Tempo ritrovato in cui Proust precisa che ogni avvenimento, ogni novità del giorno non è che una distrazione, una scusa per non decifrare il nostro libro interiore, quello dettato dalla nostra realtà, dalle impressioni che hanno lasciato in noi un’impronta definitiva e che rappresentano il più attendibile criterio di verità da seguire. Poiché il tempo passa inesorabilmente, pur senza assumere le fattezze dei vari investigatori amati da Vitiello, da Padre Brown a Maigret, da Philo Vance a Poirot, chiunque intenda scrivere prima o poi dovrà fare i conti con questa decifrazione.
In fondo, chi scrive non è che un esploratore o un detective. Se la lettura è l’atto con cui, prima ancora che le lettere di un libro, interpretiamo ciò che ci circonda – ossia se diventa il nostro strumento di indagine – scrivere in risposta a ciò che si è letto risulta un gesto inevitabile: siamo sempre davanti al palinsesto di qualcuno che cerchiamo di decifrare e poi di riscrivere di nostro pugno per offrirlo nuovo ai lettori. Altre volte, invece, il fine dell’indagine si chiarisce per lo più strada facendo perché, a differenza del detective, l’esploratore non sa già cosa cercare e si incammina un po’ come Sterne che sosteneva di essere profondamente religioso perché scriveva la prima frase e si affidava a Dio per la seconda. D’altronde sulla questione Marcel Proust si è pronunciato in modo perentorio: non possiamo impigrirci al punto di affidare interamente alla lettura la nostra vita spirituale perché i libri non ci mettono nel mezzo di una verità, ci incoraggiano solo a prendere la parola.
Vitiello ci accompagna con intelligenza fra ipotesi di lettura inedite, la più singolare e inattesa delle quali è forse quella che coinvolge il mistico russo ortodosso Pavel Florenskij e che vede nel ritorno imprevisto della memoria involontaria narrato da Proust non tanto la possibilità di rivivere un momento psicologico e la certezza di una dimensione extratemporale, quanto – nelle parole di Florenskij – quella di «attingere di nuovo una realtà mistica che è stata già sperimentata», che vibra un’altra volta con la stessa intensità «come i sottili bracci metallici sulla forcella di un diapason», come scrive Vitiello. Per Florenskij e la tradizione cristiana d’Oriente l’ascesi è «l’arte delle arti», per Proust invece l’arte è la sola religione. Pur senza avvertirla come una sentenza definitiva, Vitiello ritiene che, come la strada di Méséglise e quella di Guermantes, non è detto che «non siano destinate a ricongiungersi in qualche punto». Certo, come al giovane Marcel, a libro chiuso la vittoria sul tempo può sempre sembrare deludente, ma è appunto uscendo dal libro che il lettore, e ancor di più lo scrittore, sono tenuti a fare la loro parte.