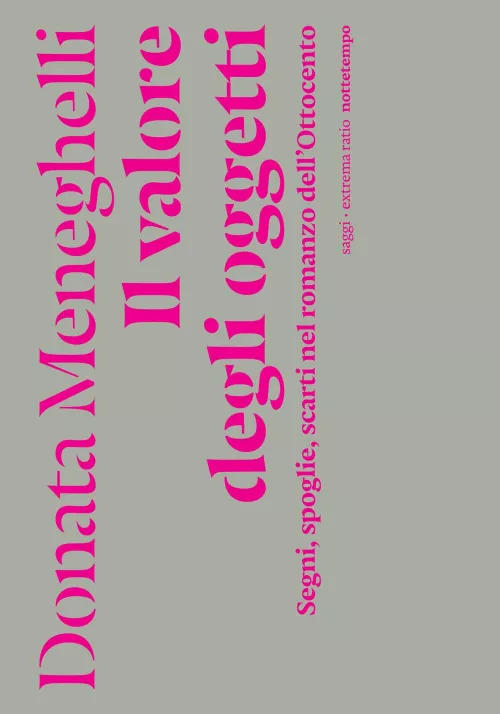L’autonomia irriducibile delle cose
Tra i molti cliché accolti – quantomeno in “occidente” – come verità autoevidenti vi è certamente il miraggio della smaterializzazione, come se le cose potessero asceticamente svestirsi della loro concretezza per trovare un’epifania igienica nella dimensione digitale. Non è difficile confutare una simile narrazione ideologica, niente affatto connaturata alla contemporaneità bensì antica (basti sostituire “digitale” con “ideale”) e orientata alla rimozione dei processi produttivi e dei rapporti di forza sociali, frammentati oggi nei mille rivoli delle catene del valore globali e divenuti come fantasmatici.
Non è una narrazione nuova, dunque. Il XIX secolo, con l’affermazione a larga scala del capitalismo industriale, la rapida espansione della capacità produttiva e conseguentemente dei consumi ha rappresentato uno dei periodi, per alcuni aspetti meno lontano dal nostro di quanto ci parrebbe intuitivo, durante i quali lo statuto degli oggetti ha visto un’intensa sollecitazione del rapporto tra valore materiale (d’uso) e valore simbolico (di scambio). È un attrito che, com’è noto, fornisce uno degli spunti a partire dai quali Karl Marx descrive e critica l’economia politica del mondo capitalistico a lui contemporaneo: l’oggetto-merce è, in fondo, il manufatto che raccoglie e testimonia il tempo di lavoro umano (insieme al suo sfruttamento e alla sua alienazione), scolpito plasticamente, per così dire, nella materia. È per queste ragioni, tra le altre, che, mentre pone al centro delle proprie indagini alcune rappresentazioni oggettuali del passato, Il valore degli oggetti. Segni, spoglie, scarti nel romanzo dell’Ottocento (Nottetempo, collana Extrema ratio, pp. 288, € 19) di Donata Meneghelli dialoga vivamente con la nostra epoca.
L’autrice intende problematizzare alcuni aspetti della «vita sociale delle cose», cogliendo «gli oggetti attraverso i contesti che essi abitano, le reti di relazioni in cui sono presi, i domini nel senso più ampio del termine – siano essi politici, estetici, economici o retorici – all’interno dei quali si collocano, i nomi che vengono loro attribuiti, gli usi a cui si piegano o a cui resistono». Per farlo sono presi in esame tre “classici” della letteratura realista, grazie ai quali è possibile osservare il sistema degli oggetti da tre punti di vista differenti. Il primo capitolo analizza Illusioni perdute di Honoré de Balzac concentrandosi sul tentativo di scalata sociale del protagonista Lucien de Rubempré. Gli oggetti sono qui considerati nella loro funzione semiotica, ossia nel circuito comunicativo interno al testo (tra i personaggi, come elementi distintivi di un certo habitus sociale) ed esterno ad esso (con il lettore, come elementi interpretativi e caratteristici del realismo). Nel secondo capitolo viene letto La principessa Casamassima di Henry James e gli oggetti sono considerati nella loro dimensione di patrimonio culturale, in quanto cioè elementi del “bottino” storico a partire dal quale, dopo i rivolgimenti rivoluzionari dei rapporti di forza, la classe sociale che prevale dà forma, ai danni della classe soccombente, alla propria politica sociale della cultura. I contesti, i mezzi e i processi di trasmissione dell’insieme di oggetti che consideriamo “patrimonio” sono allora, in una prospettiva benjaminiana, “spazzolati contropelo” seguendo da presso le vicende dell’anarchico rivoluzionario (fallito) Hyacinth Robinson, che attraversa differenti “zone di pertinenza” degli oggetti, nelle quali si articolano le differenze di classe e, soprattutto, si trasforma il valore ideologico, l’“aura” artistica delle cose. Infine, nel terzo capitolo, che ha al centro la storia de Il nostro comune amico di Charles Dickens e il passaggio di eredità (costruita sul business dei rifiuti) del vecchio Harmon, gli oggetti sono colti al termine della loro vita funzionale, nel passaggio da elemento strumentale a rifiuto. Posto in dialogo con la celebre inchiesta del giornalista Henry Mayhew sulla trasformazione del lavoro povero a Londra durante gli sconvolgimenti industriali ottocenteschi (London Labour and the London Poor, 1849-50), il romanzo di Dickens mette in scena le complesse dinamiche secondo le quali lo scarto oggettuale assume un differente statuto ontologico: se prima della rivoluzione industriale l’oggetto guasto o usurato tentava di essere riparato o rifunzionalizzato, e dunque manteneva il più a lungo possibile il proprio valore d’uso, con l’affermazione della logica capitalistica e il moltiplicarsi delle merci esso diviene preda di una fiorente economia del rifiuto, che sottrae il tratto funzionale per affermarne invece il valore di scambio.
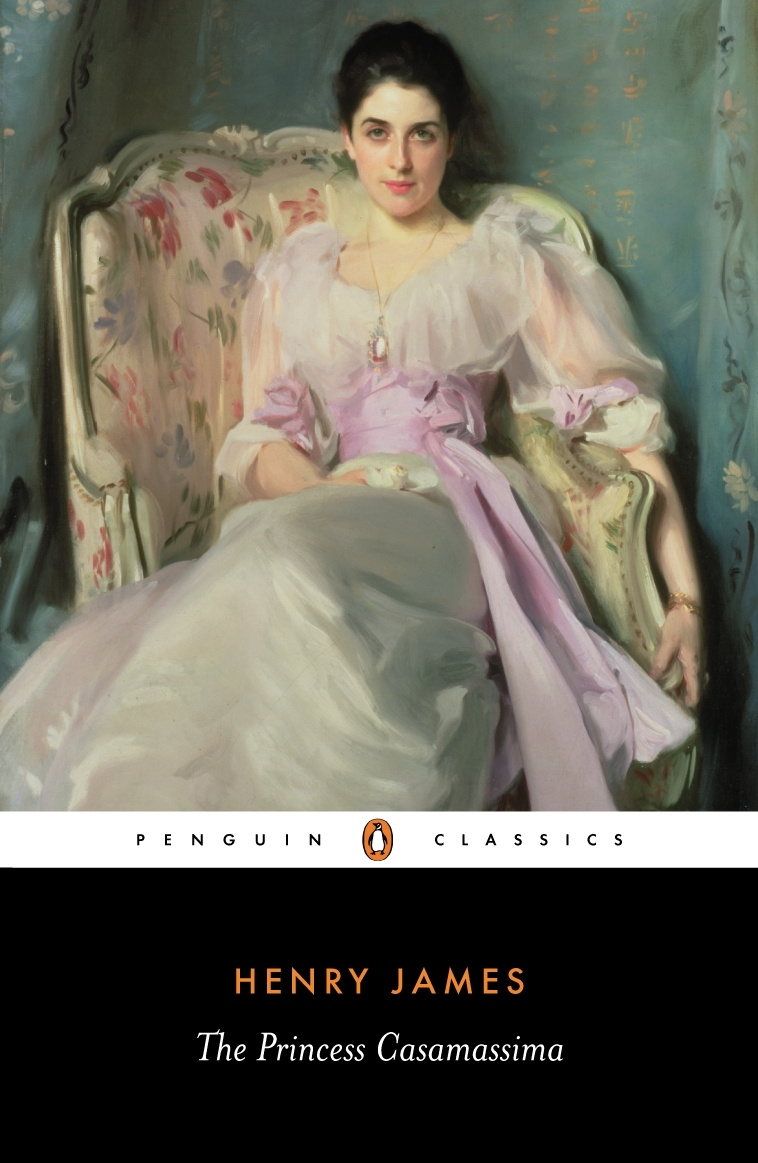
Come si vede da questa breve sintesi, il volume è uno strumento di studio letterario e culturale, che, con l’obiettivo di tracciare una fenomenologia e una storia degli oggetti, utilizza gli utensili classici dell’analisi critica del testo: lettura, discernimento, interpretazione; d’altra parte, la forza più evidente della riflessione complessiva sta proprio nell’inattualità, in grado di intessere un dialogo fecondo con i problemi più urgenti dei nostri giorni senza però che l’ansia presentista, come talvolta accade, sopraffaccia l’intelligenza e la finezza dello sguardo sulle cose. Così, secondo la lezione foucaultiana, l’impostazione archeologica di Meneghelli «è un modo di osservare il presente “da lontano”, di tirarsene fuori per decostruirne gli automatismi percettivi e l’impressione schiacciante di assolutezza, di indiscutibilità che esso trasmette.» Il testo fornisce infatti diversi spunti su problemi aperti ancora nel presente, e suggerisce che i tre campi di articolazione sociale degli oggetti (segno, patrimonio, rifiuto) siano prospettive valide per osservare le trasformazioni che ancora scompigliano il presente. Pertanto, in un certo senso, esorta all’attualizzazione: secondo quali traiettorie cambia forma quel sistema di oggetti-segni che Rancière ha chiamato partizione del sensibile (la percezione sociale, cioè, che traccia i confini distintivi delle classi attraverso l’esibizione di alcuni oggetti)? Cosa succede quando il “patrimonio culturale” e le forme di produzione artistica sono soggette, sempre più, ad un’obliterazione economica che, in ultima analisi, ne riduce gli spazi di autonomia? Gli oggetti artistici divenuti merce sono ancora arte o sono solo, irrimediabilmente, lusso? E ancora: cosa dice del presente – smaterializzato?! – la massa informe (eppure composta di oggetti singoli, talora individuabili, talora in frammenti) di rifiuti che costituisce le colline di Harmony jail (in Dickens) e che oggi galleggia, con proporzioni ben più minacciose, nell’oceano Pacifico?
La continuità attraverso la quale possiamo interpellare il presente con alcune prospettive buone per il passato ottocentesco e la dicotomia relazionale tra soggetto e oggetto che, pur problematizzata, forma il nesso fondamentale al centro dell’indagine sono due tratti eloquenti dell’impostazione teorica complessiva dell’autrice (che peraltro è espressa, in termini espliciti, nell’introduzione). L’andamento dialettico dell’argomentazione, organizzato per ragionamenti contrastivi che fanno del conflitto di idee il metodo per arrivare a una conclusione sintetica (ma provvisoria), respinge con ottime ragioni l’irenismo pacificante di molti studi della cosiddetta “thing theory” – che oggi hanno particolare slancio accademico e una buona propensione alla divulgabilità. Tutta una serie di ricerche contemporanee, in effetti, in un ampio spettro di discipline (filosofia, politica, estetica), ha tentato di reagire all’ideologia della “dematerializzazione” affermando con forza la materialità e per certi versi l’autonomia irriducibile delle cose, spesso contrapponendosi al materialismo marxista, irrimediabilmente impantanato nell’aspetto umano – troppo umano – della costruzione sociale degli oggetti. La materia, secondo (ad esempio) Bruno Latour, ha in qualche modo una capacità senziente e una agency: una prospettiva che, sebbene non priva di seduzione narrativa, è ascrivibile forse a una delle tante forme di “nostalgia della presenza” che percorrono i nostri giorni. Pertanto, non solo ha carattere essenzialmente reattivo, ma trova il suo presupposto fondamentale nella (involontaria?) sanzione dell’idea di sparizione della materia che, come è stato mostrato (da Derrida, tra gli altri), è un’idea intimamente mistificatoria. Gli oggetti cambiano, certo, e forse simulano la propria estinzione: una messa in scena che però segue una sceneggiatura sociale tutta umana, della quale è possibile indagare, ed è ciò che Meneghelli fa, la genealogia.