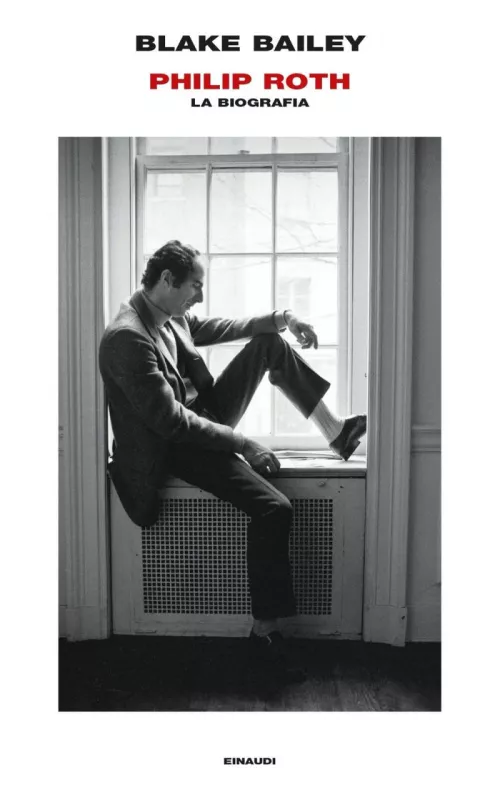Le molte vite di Philip Roth
«Non voglio che mi riabiliti. Solo che mi rendi interessante» («I don't want you to rehabilitate me. Just make me interesting»). È con queste frasi che comincia la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey (1963): Philip Roth. The Biography (2021), uscita da pochi mesi per Einaudi, nell’ottima traduzione di Norman Gobetti (la ‘voce’ italiana dello scrittore, che negli anni si è affiancata a quella dell’altro grande traduttore di Roth, Vincenzo Mantovani). A dire il vero, anzi, la richiesta di essere reso «interessante», rivolta dallo stesso Roth a Bailey, si legge in epigrafe, ancora prima cioè che prenda avvio la narrazione biografica. È come se il biografo mettesse le mani avanti, assicurandoci che sta adempiendo a un dovere nei confronti dello scrittore, e insieme promettendoci ‘tutta la verità’ su di lui; Philip Roth – sembra dire quella citazione – sarà raccontato come mai prima è stato fatto e la complessità della sua vita, la particolarità della sua storia umana, lo renderanno interessante di per sé, al di là di ogni giudizio.
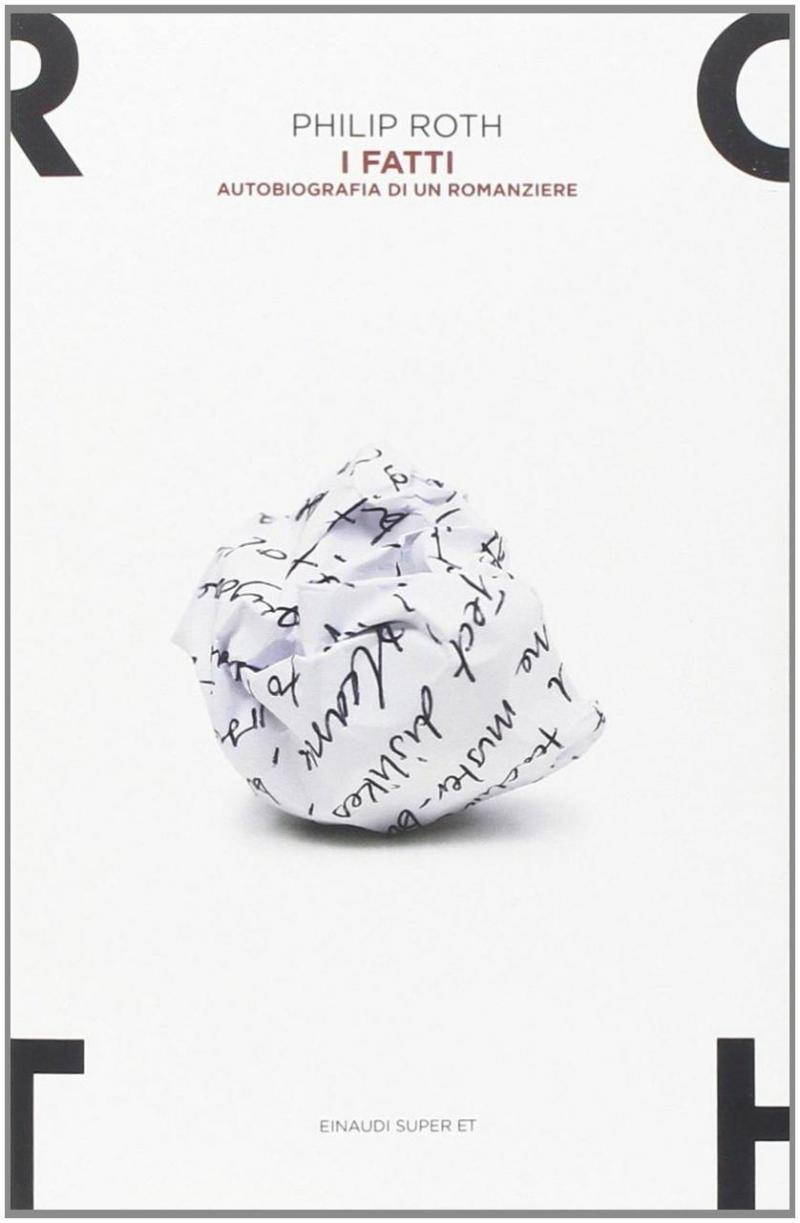
Ma arrivati alla fine del volume, eccezionale per mole (1056 pagine nell’edizione italiana) e per impegno, si viene presi da molti dubbi. La promessa è stata mantenuta? Personalmente ne dubito, anche se a ogni pagina s’impara o si scopre qualcosa su uno degli scrittori più importanti del Novecento. È vero che Roth non era mai stato raccontato così, cioè con tanta dovizia, ma non per questo la sua figura risulta interessante; non più interessante, almeno, né del Roth ‘empirico’ restituitoci da altre biografie o interviste, né tantomeno dell’autore implicito consegnatoci romanzo dopo romanzo dalla sua opera. Ciononostante, Philip Roth. La biografia (la scelta dell’articolo determinativo in questo caso è quasi più importante del sostantivo) è indiscutibilmente un ‘monumento’. Ma non come opera narrativa. La monumentalità, piuttosto, è materiale e editoriale, specialmente nella veste einaudiana: il volume, che esce nella collana “Frontiere”, sigilla con soddisfazione lo scaffale rothiano delle nostre librerie, pareggiando il formato dei “Supercoralli” in cui hanno visto la luce negli anni i romanzi dello scrittore.
Il libro, uscito negli USA nell’aprile del 2021, è diventato subito un ‘caso’; l’editore W.W Norton & Co. ha infatti deciso di mandarlo al macero, in seguito alle accuse di molestie sessuali rivolte contro Bailey, per fatti accaduti quando insegnava in un college a New Orleans. Il fatto che Bailey abbia negato la veridicità delle imputazioni non lo riscatta né dalla disgrazia in cui è caduto né, sul piano degli effetti di riverbero tra opera e autore, da almeno due paradossi: il primo consiste nel fatto che a doversi riabilitare non è l’autore, ma il biografo stesso; il secondo è che Bailey finisce per assomigliare al personaggio di un romanzo di Roth.
Ora che il libro interdetto ‘rinasce’ in italiano, abbiamo la possibilità di vederne meglio le qualità e i limiti, confrontandolo con altre opere su e di Roth più o meno affini. La biografia dell’autore della Controvita (il romanzo rothiano del 1986) è infatti ormai un filone letterario, parallelo ma in gran parte autonomo rispetto alla sua opera. Le ragioni di questa fortuna sono numerose: innanzitutto la fama e il prestigio (la litania annuale intorno al Nobel mancato, su cui lo stesso scrittore aveva preso a ironizzare, altro non era che la periodica, giustificata riconferma di Roth come il ‘più grande romanziere degli Stati Uniti’ se non ‘del mondo’), che trasformano quasi spontaneamente l’autore in personaggio.
Questa tendenza, del resto, è favorita da una caratteristica dei romanzi di Roth, i cui protagonisti o narratori sono spesso personaggi dai connotati fortemente autoriali, quasi eteronimi dello stesso scrittore: Nathan Zuckerman, David Kepesh e perfino ‘Philip Roth’, titolare di un ciclo che include, tra gli altri, Operazione Shylock, in cui si mette in atto un complesso gioco di corrispondenze e sdoppiamenti. L’interferenza autore/narratore/personaggio è uno stigma che ha riguardato l’opera e soprattutto la ricezione di Roth fin quasi dalle sue origini, in particolare dal romanzo che lo ha consacrato: Lamento di Portnoy (1969). Ma l’effetto aumenta nella trilogia formata da Pastorale americana (1997), Ho sposato un comunista (1998), La macchia umana (2000), in cui Zuckerman diventa narratore per conto di altri personaggi, avvicinandosi così al ruolo dell’autore, a Roth stesso insomma.
La proliferazione di opere a sfondo biografico su Roth può dipendere anche da quest’interferenza. Si tratta comunque di libri diversi per categoria narrativa, per forma e stile e soprattutto per attitudine e sentimenti nei confronti dello scrittore. Per esempio, affermando di non voler essere riabilitato, Roth alludeva probabilmente a uno di questi libri, Leaving a Doll’s House: A Memoir (1996) di Claire Bloom. Seconda moglie dello scrittore, da cui aveva divorziato nel 1995, Bloom aveva dato un ritratto umanamente desolante di Roth e della loro relazione. È proprio sulla scia di quel memoir che Roth avrebbe deciso di consegnare a un biografo la ricostruzione ‘autentica’ della propria vita.
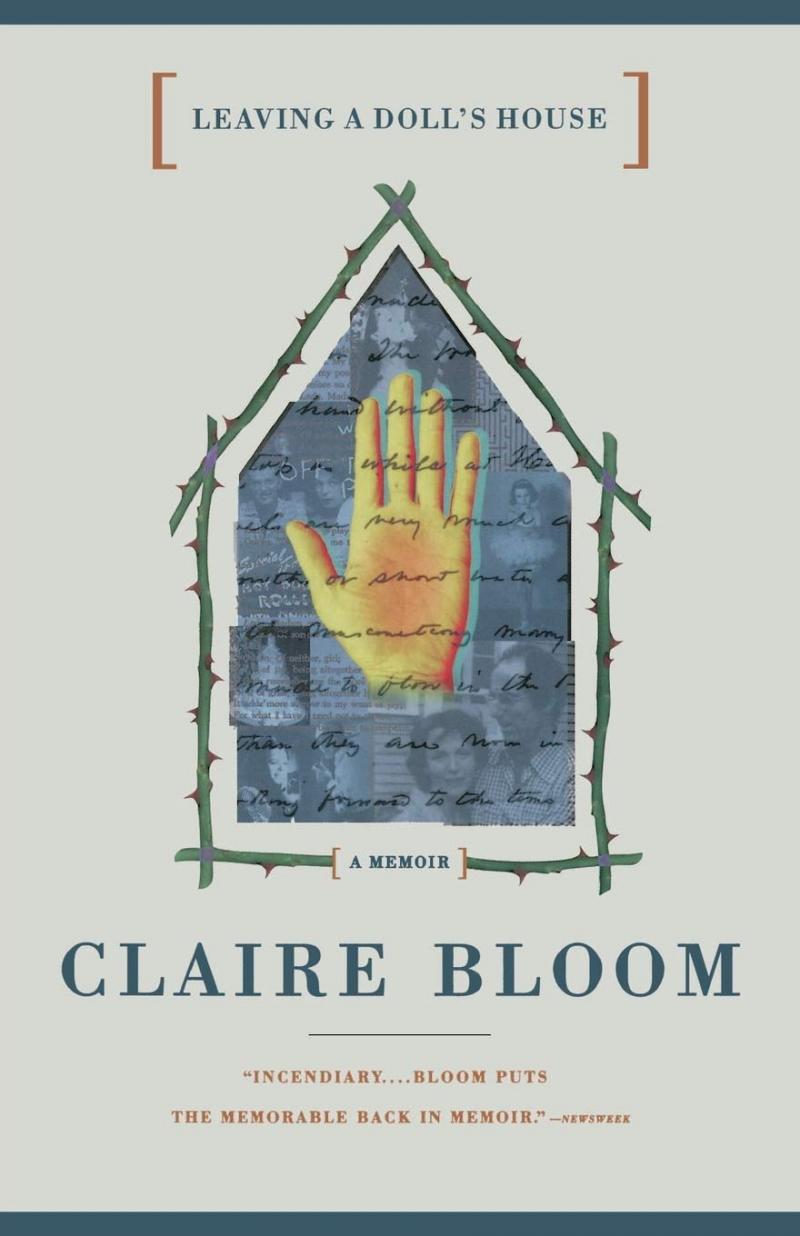
Così, a partire dal 2012, è cominciato il lavoro di Roth con Bailey (già autore di una biografia di John Cheever), che ha avuto accesso a un’enorme quantità di notizie e documenti dall’archivio privato dello scrittore, confluiti in una minuziosa cronaca. Proprio nell’ottobre del ’12, all’indomani dell’uscita della traduzione francese di Nemesi (il libro con cui Roth si congedava dalla scrittura, pubblicato in edizione originale due anni prima), aveva rilasciato un’intervista a «Les Inrockuptibles», in cui aveva dichiarato:
J’ai préféré travailler à mes archives pour les remettre à mon biographe. Je lui ai remis des milliers de pages qui sont comme des mémoires mais pas littéraires, pas publiables tels quelles. Je ne veux pas écrire mes mémoires, mais j’ai voulu que mon biographe ait de la matière pour son livre avant ma mort. Si je meurs sans rien lui laisser, par quoi commencera-t-il ?
[Ho preferito lavorare ai miei archivi e consegnarli al mio biografo. Gli ho dato migliaia di pagine che sono come memorie, ma non letterarie, non pubblicabili così come sono. Non voglio scrivere le mie memorie, ma volevo che il mio biografo avesse materiale per il suo libro prima della mia morte. Se muoio senza lasciargli nulla, da dove comincerà? (traduzione mia)].
A più di venti anni dall’uscita del libro di Bloom, un’altra autrice, Lisa Halliday (1976), ha scritto della propria relazione con Roth; la prima parte del libro di Halliday (Asimmetria, ‘Asimmetry’, 2018; tradotto nello stesso anno da Federica Aceto per Feltrinelli), intitolata Follia, racconta in chiave autofittiva l’incontro amoroso con l’anziano e celebre scrittore Ezra Blazer, ispirato proprio alla figura di Roth. Il genere letterario (romanzo e non autobiografia) e gli animi della narrazione di Halliday sono diversi da quelli di Bloom, ma i due libri fanno parte della stessa costellazione biografica in cui rientra anche un’altra opera recente: Siamo ancora qui. La mia amicizia con Philip Roth (‘Here We Are. My Friendship with Philip Roth’, 2020; tradotto da Nicola Manuppelli per Nutrimenti nel 2021) di Benjamin Taylor (1952), che si era già misurato con un grande scrittore pubblicando una biografia di Marcel Proust (Proust: The Search, Yale University Press, 2015). Il memoir di Taylor si sofferma sulla stagione estrema della vita di Roth e lo fa con le migliori intenzioni, assumendosi un rischio che l’amicizia contempla, quello cioè di trasformare il racconto in commemorazione.
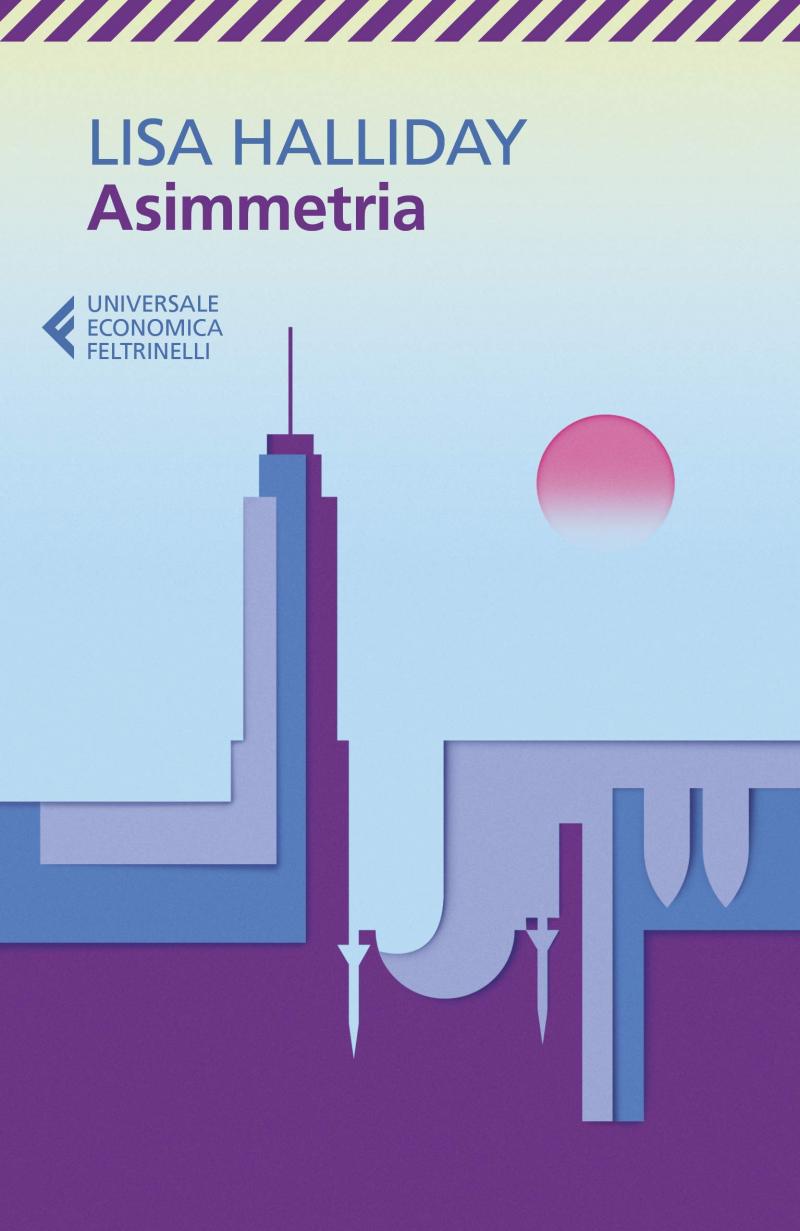
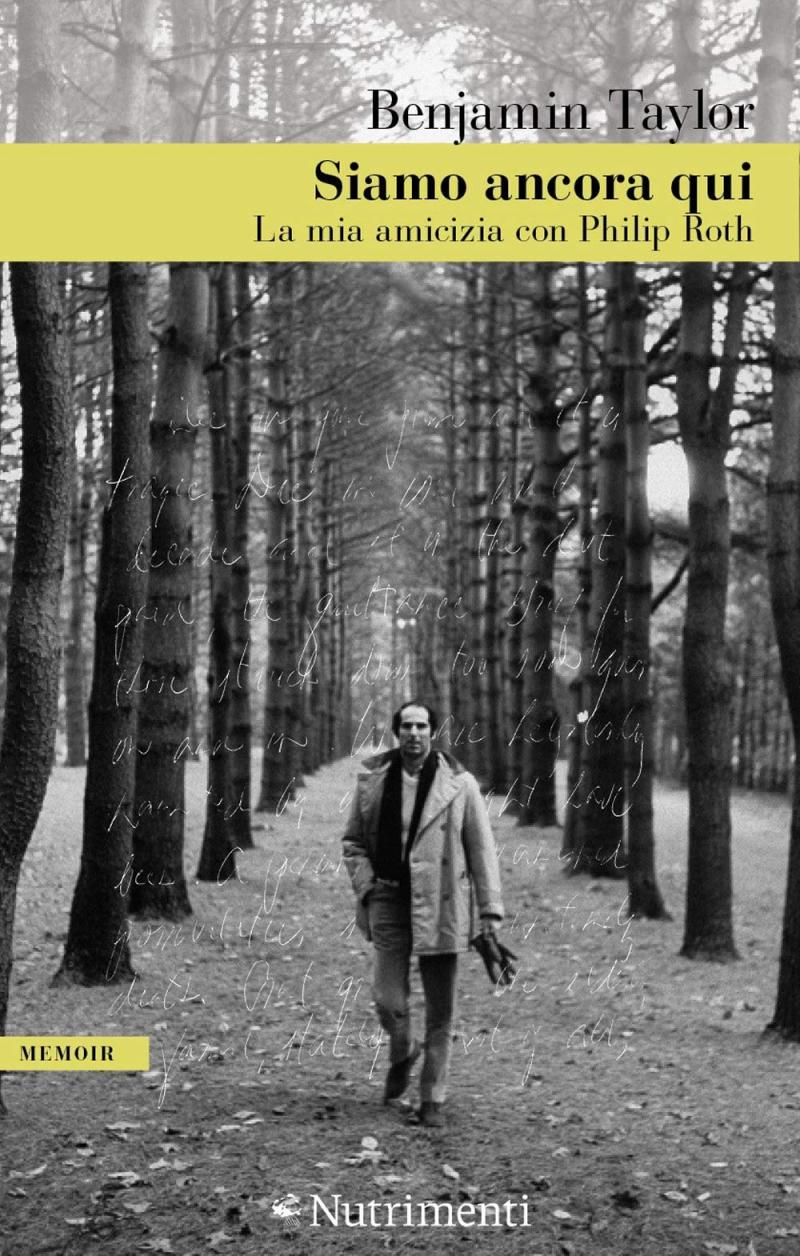
Di altro tenore è il libro Roth scatenato. Uno scrittore e i suoi libri (‘Roth Unbound. A Writer and His Books’, 2013; tradotto da Anna Rusconi per Einaudi nel 2015) di Claudia Roth Pierpont – nessuna parentela con lo scrittore, come la stessa autrice precisa. Nel complesso, Roth scatenato è la migliore opera a sfondo biografico su Philip Roth, almeno tra quelle uscite in Italia; lo è proprio perché non è una biografia del Roth privato ma del Roth scrittore; è cioè un racconto della vita attraverso le opere, che restano il centro e il fine della ricostruzione: «Se, in assoluto, il mio libro ha quindi tratto immenso beneficio dalla frequentazione diretta» scrive Claudia Roth Pierpont nell’Introduzione «in fase di stesura il mio senso critico ha tenuto Roth decisamente a distanza»; a maggior ragione visto che la «componente biografica è più rilevante in certi periodi che non in altri» ed è usata «soprattutto per illuminare il contesto» (pp. 6-7).
L’efficacia di Roth scatenato dipende appunto dalla capacità e dalla scelta di mettere in relazione, ma lasciandole separate come poli di un’opposta tensione, circostanze e scrittura, persone e personaggi. È in fondo la stessa dialettica che percorre l’opera più vicina a un’autobiografia che Philip Roth abbia scritto, I fatti. Autobiografia di un romanziere (‘The Facts. A Novelist’s Autobiography’, 1988; uscito in Italia già nel 1989 per Leonardo editore, nella traduzione di Pier Francesco Paolini, poi per Einaudi nel 2013 e nel 2014 nella versione di Vincenzo Mantovani). Per giustificare il passaggio – temporaneo e piuttosto parziale – dal romanzo alla rievocazione della propria vita Roth fa precedere al racconto una lettera aperta al suo principale alter ego narrativo, cioè Nathan Zuckerman, in cui spiega di doversi «trasformare in sé stesso», «rendersi visibile a sé stesso» dopo aver reinventato la propria storia a nome di altri, dei suoi personaggi.
L’autore in cerca di sé ricorre, con gesto novecentesco, al ristoro della memoria, più per negarne la possibilità che per affermare la stabile riconquista del tempo perduto; in questo senso, Roth somiglia più a Italo Svevo (evocato due anni prima nel dialogo con Primo Levi, uscito poi in Chiacchiere di bottega) che a Marcel Proust. Così come ha un sapore pirandelliano il botta e risposta tra lo stesso Roth e Zuckerman, che replica alla lettera iniziale con una lunga riflessione conclusiva:
Ciò che scegli di dire in un romanzo è diverso da ciò che puoi permetterti di dire quando non c’è nulla di inventato, e in questo libro non puoi permetterti di raccontare ciò che racconti meglio: gentile, discreto, prudente – cambi i nomi delle persone perché non vuoi urtare i loro sentimenti – no, questo non è il tuo lato più interessante (p. 168).
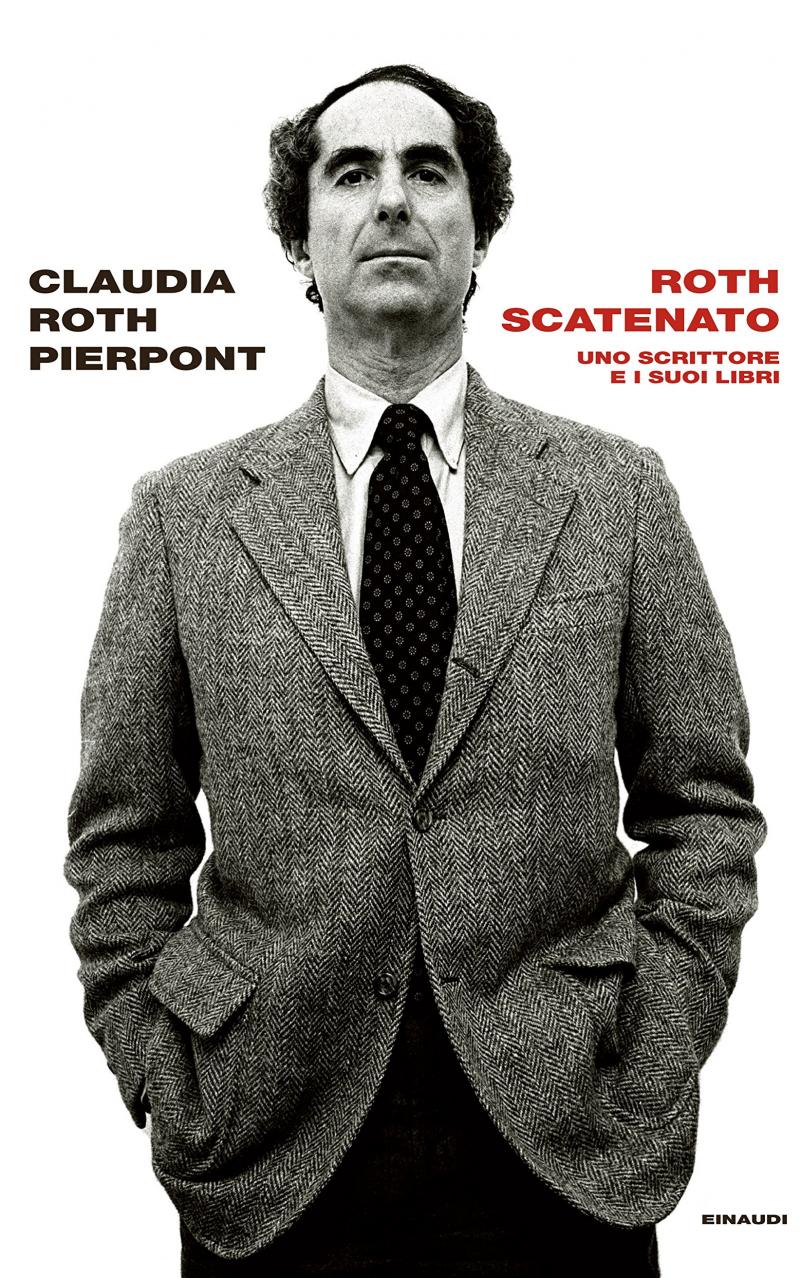
«Interessante», ancora quell’aggettivo. Si direbbe che qui, attraverso la voce del suo personaggio, Roth intenda dire che l’interesse del racconto sta nel dare un ritratto sincero delle figure implicate, senza censura o ritegno. Se era questo il senso della frase rivolta da Roth al suo biografo, dobbiamo riconoscere a Bailey di essere andato abbastanza vicino a quanto l’autore chiedeva: nessun nome è nascosto o cambiato, nessun vizio o difetto, comportamento meschino o motto sprezzante viene taciuto. Il problema della biografia-monstre è che non sceglie, mentre la condizione quasi preliminare posta da Roth/Zuckerman perché un’opera riesca interessante sta proprio nella scelta di dire o di non dire.
La biografia di Bailey non è solo molto lunga, è anche molto gremita di nomi, date, luoghi, che frammentano l’esperienza, la parcellizzano in tante microscopiche circostanze, finendo così per appannare anziché definire la figura dello scrittore, allontanandolo dai lettori, soprattutto da quelli non statunitensi che faticheranno ancora di più a identificarsi in un mondo così specifico. Non avrebbe senso rimproverare a Blake Bailey di non essere Philip Roth, ma non si può fare a meno di pensare che la grandezza del secondo sta proprio nell’universalità che conferisce alla specificità dei suoi personaggi e dei loro ambienti. Si potrebbe semmai imputare allo stesso Roth di non aver tenuto fede al suo metodo, dato che la biografia procede spesso come un commento alle parole e alle azioni che proprio lo scrittore ha affidato a Bailey.
La sensazione di horror vacui che la biografia trasmette è accentuata dall’andamento quasi annalistico, che proietta la vicenda di Roth contro lo sfondo della storia contemporanea. E lo fa seriamente, cioè senza il tremendo umorismo a cui ricorre lo stesso Roth parlando di sé stesso nei Fatti, come accade nelle pagine in cui lo scrittore parla della morte di Josie (il nome fittizio dietro cui si cela quello di Maggie Martinson, prima moglie dello scrittore):
Tra l’assassinio di Martin Luther King e quello di Bobby Kennedy, morì di morte violenta anche Josie. Restò uccisa sul colpo, nelle prime ore di un mattino di maggio, quando la macchina sulla quale attraversava Central Park uscì di strada e andò a sbattere contro un albero, un lampione o una spalletta di cemento: nessuna delle persone con cui parlai sembrava sapere con esattezza come o dove aveva avuto luogo la collisione. Il guidatore era un editor che era stato il capo di Josie durante la sua attività editoriale fino a quando, mi parve di capire, l’aveva, di recente, licenziata.
Il fatto che fosse un nero mi fece tornare in mente le telefonate accusatorie che ricevevo da lei nel cuore della notte, dopo il mio trasloco da Princeton a un albergo di New York, quando sosteneva, sotto l’effetto dell’alcol, che ero a letto con una “negra”: me lo fece ricordare senza, però, aiutarmi a capirla un po’ meglio. Mi venne in mente che anche la donna incinta da cui aveva comprato il campione di urina era nera: possibile che fosse la “negra” con cui Josie immaginava che io fossi a letto a New York? Solo gli dei della Paranoia conoscevano la risposta (p. 154).
La ferocia del brano dipende anche dall’incipit, che fa risaltare l’insulsa meschinità di Josie, della sua morte e di Roth stesso rispetto al destino di due protagonisti della Storia americana contemporanea (un nero e un bianco, con ironica corrispondenza rispetto ai tradimenti veri o immaginati della coppia Philip-Maggie). Nel libro di Bailey, invece, non c’è alcun reale attrito tra lo scrittore e il mondo (al massimo ci sono le ostilità puntali, gli screzi, le rivalità con altri scrittori, che non fanno che confermare l’orizzontalità cronachistica con cui Bailey imposta il racconto); né viene mantenuta la giusta distanza tra scrittura ed esperienza, tanto che in diversi casi motivi e situazioni dei romanzi di Roth vengono troppo immediatamente riferiti a elementi biografici:
I due uscirono insieme per un breve periodo, e Roth non dimenticò mai il suo incontro con la madre di Arizona, dalla pelle ancora più chiara, che gli raccontò che “la sua gente aveva perso per sempre” alcuni suoi parenti, nel senso che avevano deciso di farsi passare per bianchi, per “non tornare più indietro”, un dettaglio che a Roth sarebbe rivenuto in mente quarantaquattro anni dopo, mentre scriveva La macchia umana (p. 121);
Dato che aveva un solo rene, e per giunta malfunzionante, Trudy non poteva portare a termine una gravidanza, e così la coppia adottò due figli, nel 1957 e nel 1958. Tutt’e due le volte Philip funse da intermediario, un’esperienza che poi avrebbe utilizzato in Lasciar andare per il disastroso ruolo svolto da Gabe nell’adozione degli Herz (p. 191).
Non c’era bisogno di tanti particolari, Roth era già interessante; è per questo che non avremmo potuto fare a meno di leggerne la maestosa biografia definitiva, di desiderarla come se fosse un ultimo grande romanzo dello scrittore, di ammirarla innanzitutto come oggetto, e di infliggerci un’ovvia delusione – no, non è un suo romanzo.
Eppure avevamo bisogno di questo splendido mausoleo di carta, per farla finita con i fatti e i nonfatti transitori di un individuo che ha preferito ritirarsi in solitudine nel Connecticut e smettere di scrivere, confermando come non ci sia una vita di Philip Roth senza i suoi romanzi. «Ho dedicato la mia vita al romanzo», aveva dichiarato lo scrittore a «Les Inrockuptibles» nel 2012, «è abbastanza!»; un nuovo libro, aveva aggiunto subito dopo, non avrebbe cambiato ciò che aveva fatto in tutti quegli anni e probabilmente sarebbe stato un fallimento: «Chi ha bisogno di leggere un altro libro mediocre?». Se fosse di Roth, correremmo ancora il rischio, come abbiamo fatto con la biografia.