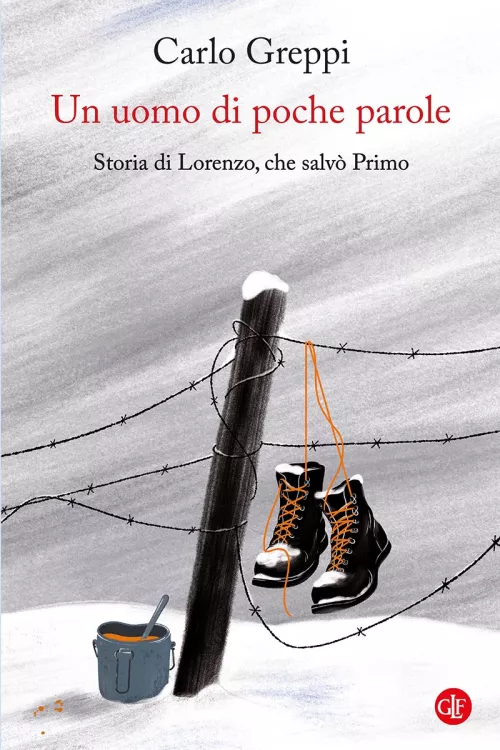Lorenzo, l'uomo che salvò Primo Levi
Un uomo di poche parole rientra nel ciclo narrativo-saggistico inaugurato da Uomini in grigio, ripreso dalla tesi di dottorato, e sviluppato in Il buon tedesco, in cui Carlo Greppi scava ai margini della Storia per dissotterrare le biografie di alcuni personaggi semi-sconosciuti della Seconda Guerra Mondiale: il brigadiere Antonio M. (autista del maggiore Serloreti, il torturatore della caserma Lamarmora, in Uomini in grigio), Rudolf Jacobs (maggiore della marina tedesca, poi disertore e infine membro della resistenza italiana, in Il buon tedesco) e, ora, Lorenzo Perone (lavoratore “volontario” presso il campo di Auschwitz III a cui Primo Levi dice di dovere la vita).
Cos’hanno in comune?
Sono individui le cui vicende non si sono ancora depositate nella cosiddetta memoria collettiva. In linea con i metodi di Bloch e delle Annales, della storia orale praticata da Ginzburg, Portelli e altri, e memore della meravigliosa poesia di Brecht citata nel libro (Domande di un lettore operaio, 1935: “Tebe dalle Sette porte, chi la costruì?.../ Dove andarono la sera che fu terminata la Grande Muraglia/ i muratori?”), Greppi riscatta dalla dimenticanza le vite di soggetti umili, appartenenti a categorie sottorappresentate – la cosiddetta “gente comune” – per rimettere in discussione la distinzione tra ciò che è storico e ciò che non lo è.
Perlopiù i suoi protagonisti non si lasciano inquadrare nella griglia di ruoli con cui abbiamo imparato a dare senso agli eventi della guerra: Vittime e Carnefici, Collaborazionisti, Bystander, Resistenti, Liberatori e Giusti tra le Nazioni. L’idea è di attraversare le categorie canoniche per mostrare come una stessa persona possa di volta in volta partecipare dell’uno o dell’altro ruolo, a seconda delle circostanze, di motivazioni spesso insondabili (lo storico non ha facoltà di entrare nella testa dei personaggi), e di un non meglio identificabile “bagliore di umanità” che talvolta sospinge i personaggi meno eroici a compiere azioni inaspettatamente coraggiose.
Antonio M. oscilla ambiguamente tra i ruoli di Carnefice-Collaborazionista da una parte, e Resistente dall’altra (nella misura in cui gli capita di aiutare i perseguitati politici). Rudolf Jacobs passa dalla posizione di Carnefice (in quanto membro della marina tedesca) a quello di martire della Resistenza. A modo suo anche Lorenzo rientra nel novero dei personaggi non immediatamente classificabili: tecnicamente parlando, dovrebbe appartenere alla categoria dei Collaborazionisti, visto che contribuisce, con il suo lavoro di muratore alle dipendenze della ditta Beotti, a “costruire qualcosa che era parte della macchina dello sterminio” (p. 36). E tuttavia le azioni che compie – chissà quanto consapevolmente – lo portano a dismettere quel ruolo non appena gli si offra la possibilità di incarnarne un altro che più gli si addice: quello che oggi viene definito (ma allora ovviamente non esisteva il termine, e forse neanche il concetto) “Giusto tra le Nazioni”.
Greppi, dunque, inaugura i suoi scavi storici in quella che Levi ha definito la zona grigia – anche se da quella zona si è via via allontanato. Il primo libro affondava le mani nella melma, ovvero nel sottobosco di collaborazionisti, doppiogiochisti, spie, ecc., impegnati in una miriade di piccole scelte quotidiane, motivate da opportunismo, paura, tattiche di sopravvivenza, conformismo e soprassalti di coscienza. È nei confronti di questi personaggi ambivalenti che, per la maggior parte di noi, dovrebbe scattare una scomoda identificazione, ed è con le loro – e con le nostre – contraddizioni (il “legno storto dell’umanità”) che bisognerebbe fare i conti se davvero si ambisse a ricavare qualche insegnamento realistico dalla storia.
Diversamente da altri autori, come Christopher Browning che in Uomini comuni narra “di come un manipolo di persone ordinarie possa diventare, e in fretta, una squadra di assassini” (p. 63); e diversamente dalla schiera di coloro che, dagli anni Novanta, si sono affannati a scovare macchie vergognose nella biografia di antifascisti illustri (penso per esempio alla pubblicazione scandalistica della lettera del giovane Bobbio a Mussolini su Panorama nel 1992), Greppi non ama calarsi negli anfratti più torbidi della Storia, e anche quando lo fa cerca di trovare qualche traccia di bontà, giustizia e redenzione nelle vicende che racconta. “Tra il grigio qualcosa brillava sempre” (p. 115): perfino tra le mura della caserma Lamarmora (luogo di torture e altre nefandezze) di cui scrive in Uomini in grigio.

La tendenza a cercare il Bene dove meno ce lo si aspetta si accentua cammin facendo, fino ad arrivare alla parabola abbagliante di Lorenzo Perone, che di grigio non ha proprio nulla (il suo colore è difatti il bianco, e anche i suoi difetti – carattere irascibile e consumo smodato di alcool – sono coerenti con il profilo di un uomo troppo buono per adattarsi alle schifezze del mondo). Lo ammette Greppi stesso: “Mi sono rintanato sempre più spesso nella luce, dopo avere annaspato a lungo nel grigio” (p. 63).
Che cosa – al netto della funzione auto-terapeutica – lo ha spinto ad abbandonare la zona grigia per privilegiare la prospettiva dei Giusti? È una domanda che provo ad articolare meglio. Greppi è perfettamente consapevole delle obiezioni che gli si potrebbero rivolgere. Per esempio, quella di Sergio Luzzatto, citata nel libro, secondo cui nell’approccio sui Giusti patrocinato da Yad Vashem manca una storiografia e una memoria delle azioni collettive di salvataggio e di protezione delle minoranze perseguitate. La filosofia dello Yad Vashem pone l’enfasi sulle azioni individuali, mentre per capire come molti ebrei (e non solo) si siano salvati occorre “ricostruire le vicende dei giusti come dinamiche di rete”. A insistere sull’eroismo individuale dei Giusti non si rischia di porre un peso sproporzionato sulle spalle dei pochi coraggiosi, a scapito della valorizzazione di un dissenso diffuso e organizzato?
Oppure l’altra obiezione, strettamente correlata alla prima, che Marco Revelli sollevava (in un articolo del 1992 sul manifesto) a proposito del cosiddetto scandalo Bobbio, in cui ricordava che Bobbio “ha sempre teorizzato la superiorità della democrazia sulla dittatura, proprio perché non costringe i cittadini a essere eroi per preservare la propria dignità.” Le risposte democratiche non dovrebbero assumere la forma di politiche condivise che non costringano i singoli a compiere quotidiani gesti di eroismo (oppure a sentirsi inadeguati se non hanno la fibra morale necessaria per opporsi a forze contrarie di gran lunga più potenti di loro)?
Greppi, dicevo, rende esplicite queste perplessità. Ed è anche attento a non presentare il suo racconto in termini esplicitamente pedagogici, come se la storia di Lorenzo contenesse una “lezione” o un “messaggio” edificante, posto che lo stesso Levi (in una citazione riportata nel libro) affermava che “[Messaggio] è un termine che detesto perché mi mette in crisi, perché mi pone indosso panni che non sono i miei, che anzi appartengono a un tipo umano di cui diffido: il profeta, il vate, il veggente”. (p. 82)
Qual è dunque la molla che spinge Greppi a intraprendere questo nuovo capitolo della sua ricerca? La domanda conclusiva del libro sembra quasi retorica: “Se ci fossero state solo persone come Lorenzo, sarebbe stato possibile un luogo come Auschwitz?”. Ovvio che no. Se la domanda viceversa fosse “che cosa ha spinto Lorenzo a fare la sua scelta?”, bisognerebbe ammettere (con l’autore) che a lettura ultimata non ne sappiamo molto più di prima: “non me ne importa niente” [dei rischi che corro] è l’unica battuta che Lorenzo pronuncia a tal proposito. Si potrebbe riflettere sul fatto che molte delle decisioni più importanti che capita di prendere non sono motivate, se non a posteriori: prima si agisce (bene o male), e poi si confeziona una spiegazione sul perché si è agito così. Forse Lorenzo è speciale perché non sente il bisogno di giustificare (o di raccontare, o di dare un senso a) dei comportamenti che per lui sono ovvi e inevitabili. Forse il suo essere di poche parole è ciò che lo rende diverso da tutti noi. Di certo non c’è nulla di banale in questo Bene.
Infine, un accenno alla struttura dei libri di Greppi, a cavallo tra narrativa e saggistica. Come i romanzi gialli, si articolano su due livelli intercalati. Da una parte c’è il racconto dei personaggi di cui si parla (in questo caso la storia di Lorenzo), estrapolabile dalle fonti e dalle testimonianze a disposizione. Dall’altra il racconto delle indagini compiute dallo storico per recuperare e per cercare di cucire insieme, a volte faticosamente, i suoi frammenti documentari. Greppi racconta in prima persona la sua ricerca delle fonti, spesso lacunose o reticenti, segnalando i passaggi più impervi, i dubbi, le frustrazioni, la necessità di avanzare congetture là dove manchino prove circa l’esatta dinamica degli eventi. Mette in scena il lavoro dell’interpretazione, con tutti i dilemmi che comporta, le ipotesi scartate, l’emozione di ogni nuova scoperta. Ma anziché nascondere i vuoti e le cuciture narrative, le mette in evidenza. I testi sono disseminati di frasi come:
Nulla so di quello che [Lorenzo] eventualmente disse nelle ore seguenti [al suo primo incontro con Levi], e ritengo impossibile che lo si possa sapere. Azzardo l’ipotesi, avendo intuito qualcosa della sua personalità grazie a una discreta quantità di fonti, che non volle cercare le parole neanche nei due o tre giorni successivi: stava più probabilmente a macinare pensieri con lo sguardo tra il perso e l'arcigno, indecifrabile, come quello che svelano le sue fotografie giunte fino a noi – mi risulta che siano solamente due. (p. 8)
Colpisce, in questo e in altri passaggi del libro, la presenza percepibile di una voce narrante – quella dello storico-detective – che si fa largo tra i documenti e, rivolgendosi ai lettori, costruisce e decostruisce i suoi racconti lacunosi, insistendo proprio su quel lavoro ipotetico che normalmente i racconti – anche quelli basati su storie realmente accadute – spingono in secondo piano. Ma è proprio in virtù di questa incertezza costantemente reiterata che, alla fine del libro, abbiamo la sensazione di avere capito molto di più non solo e non tanto delle dinamiche sommerse che contraddistinsero la storia europea tra il ’43 e l’immediato dopoguerra, ma soprattutto del modo – perlomeno di un modo – di fare storia a partire da un intensissimo corpo a corpo con le testimonianze.