Riforme, economia, diritti / La società giusta di Thomas Piketty
Nel corso della storia le guerre e le epidemie hanno periodicamente sconvolto le strutture economiche e sociali create dall’uomo. Secondo la maggior parte degli studiosi questi shock hanno avuto un effetto sia distruttore che equilibratore, spazzando via enormi ricchezze e quindi riducendo le disuguaglianze accumulatesi nel tempo. Oggi non sappiamo ancora quali saranno gli effetti del Coronavirus. C’è chi sostiene che i ricchi sono meglio attrezzati ad affrontare gli sconvolgimenti innescati dal contagio, e che quindi le disuguaglianze aumenteranno ulteriormente nel prossimo futuro. Altri invece intravedono la possibilità che una società più giusta ed equilibrata possa emergere dalla crisi.
Thomas Piketty è uno di questi. Circa sette anni fa usciva nelle librerie di mezzo mondo la traduzione di un voluminoso libro intitolato Il capitale nel ventunesimo secolo. Sarebbe diventato uno dei fenomeni editoriali del decennio, con centinaia di migliaia di copie vendute, elogiato da celebrità e premi Nobel. Nonostante le dimensioni (circa mille pagine), Il capitale nel ventunesimo secolo è un esempio interessante di scienza sociale accessibile al lettore medio. Utilizzando decine di grafici e pochissima teoria, Piketty sostiene una tesi molto semplice: dopo un periodo di declino nella parte centrale del ventesimo secolo, la disuguaglianza nell’accumulazione del capitale, all’interno della maggior parte dei paesi del mondo, è tornata ad aumentare in maniera vertiginosa, e continuerà a farlo.
Nel contesto della recessione seguita al crollo dei mercati finanziari, il successo del Capitale nel ventunesimo secolo non è difficile da spiegare. Il messaggio principale — la disuguaglianza è aumentata molto — è accompagnato da un’altra tesi largamente condivisa: la disuguaglianza è aumentata troppo, e dobbiamo intervenire rapidamente per invertire o almeno fermare questo trend. Trattandosi di un libro essenzialmente fattuale, tuttavia, Il capitale nel ventunesimo secolo non si preoccupava di argomentare queste ultime affermazioni. E non forniva indicazioni precise riguardo alle riforme che potrebbero ridurre la disuguaglianza senza sacrificare il benessere dei cittadini. I numerosi articoli scritti da Piketty su riviste e quotidiani dopo l’uscita del libro (alcuni raccolti e recensiti su Doppiozero) hanno evidenziato l’orientamento politico dell’autore, senza rispondere peraltro a diverse domande: innanzi tutto, perché vogliamo più uguaglianza? Quali disuguaglianze sono ingiuste, e quali non lo sono? Quanta disuguaglianza siamo disposti a tollerare, e quando invece diventa eccessiva? E se la disuguaglianza è davvero eccessiva, che cosa possiamo fare?
Sette anni dopo, Piketty offre ai lettori un’altra opera ambiziosa e impegnativa. Il titolo — Capitale e ideologia — evoca nuovamente Marx. E il peso lordo è di nuovo impressionante: 1200 pagine, nell’edizione italiana pubblicata da La Nave di Teseo. Rispetto al precursore, Capitale e ideologia si discosta ulteriormente dai canoni dei libri di economia. Non si occupa soltanto di storia economica, ma anche di storia delle idee, delle istituzioni sociali, e contiene un manifesto politico per un nuovo “socialismo del ventunesimo secolo”. Eppure, nonostante le dimensioni e l’ampiezza dello sguardo, Capitale e ideologia non risponde pienamente alla curiosità del lettore, come spiegherò fra poco.
Prima voglio provare a riassumere il contenuto del libro, per quanto sia umanamente possibile. I diciassette capitoli di Capitale e ideologia sono organizzati in quattro parti. Le prime tre sono essenzialmente storiche e forniscono una rassegna dei “regimi di disuguaglianza” che si sono susseguiti dal Medioevo ai giorni nostri. Per “regime” Piketty intende l’insieme di istituzioni che determinano la produzione e la distribuzione della ricchezza in una data società. Ogni regime è in parte condizionato dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell’epoca, senza esserne del tutto determinato. E ogni regime produce una sua “ideologia”, ovvero una serie di credenze, teorie, argomentazioni volte a giustificare le forme prevalenti di disuguaglianza. Discostandosi dal marxismo classico, Piketty enfatizza l’autonomia delle ideologie dalle forme di produzione. Non c’è determinismo ma se mai una reciproca relazione di interdipendenza.
I primi tre quarti del libro — circa settecento pagine — sono solo l’antipasto per il piatto forte servito nell’ultima parte, “Ripensare le dimensioni del conflitto politico” (capitoli 14-17). Qui Piketty delinea le sue proposte, ovvero un insieme di riforme in grado di fermare la crescita della disuguaglianza e di creare i presupposti per una società veramente giusta. Il tassello centrale è la tassa sulla ricchezza, un’imposta progressiva sui risparmi delle fasce più abbienti della popolazione per erodere nel corso degli anni l’accumulazione di capitale. I proventi di questa tassa sarebbero utilizzati per trasferire alle nuove generazioni una dotazione economica di base al compimento della maggiore età. Ma la proposta di Piketty non si limita a questo. Nella quarta parte del libro affronta questioni più vaste quali il mutamento della base sociale dei partiti tradizionali, l’emergere del populismo “nativista”, la libera circolazione degli individui attraverso le frontiere statuali, e il problema del riscaldamento globale.
La prima domanda che un essere umano si pone di fronte a un libro del genere è: perché dovrei leggerlo? È un impegno non da poco, da prendere soltanto se ne vale la pena. Qui la risposta ovviamente varia a seconda dei gusti: se vi piacciono le opere enciclopediche di grande respiro, in grado di abbracciare con lo sguardo la storia dell’uomo e i suoi sforzi per costruire società migliori, Capitale e ideologia fa al caso vostro. Imparerete diverse cose anche se siete uno specialista in qualche area delle scienze sociali, perché difficilmente avrete conoscenze così ampie e interdisciplinari. Il mio consiglio è di cominciare dall’introduzione, una cinquantina di pagine che riassumono gli argomenti principali di Capitalismo e ideologia. Questo vi permetterà di scegliere i capitoli che più vi interessano nelle prime tre parti. Personalmente consiglio i capitoli 11, 12, 13 dedicati alla nascita e al declino del Welfare State nelle società capitaliste avanzate, e alla crisi dei paesi dell’est in seguito alla fine del comunismo. A questo punto potete passare alla quarta parte, quella più interessante e propositiva. Se avete ancora energie da spendere, potete quindi leggere con calma la storia dei regimi di disuguaglianza dal medioevo al diciannovesimo secolo, contenuta nella prima metà del libro.
La funzione principale della prima parte, a mio parere, è istruttoria: serve a mettere il lettore nello spirito giusto per accogliere le proposte di Piketty. Il messaggio è semplice e poco controverso: l’incremento della disuguaglianza non è un fenomeno naturale, e non è inevitabile. Al contrario si tratta di uno sviluppo contingente che i cittadini hanno accettato sia per mancanza di fantasia (sembravano mancare le alternative), sia perché convinti da argomenti speciosi. Questi argomenti costituiscono proprio quell’ideologia della quale dobbiamo sbarazzarci. Piketty enfatizza ripetutamente che intende utilizzare il termine “ideologia” in senso neutrale, non spregiativo: qualsiasi regime si accompagna a un’ideologia. Questo approccio storicista è però un’arma a doppio taglio, nella misura in cui può ispirare una lettura relativista: se non c’è differenza di valore fra un’ideologia e un’altra, se Piketty sta descrivendo senza giudicare, come dovremmo valutare la sua proposta? Secondo il suo stesso schema di pensiero, ci sta rifilando un’altra ideologia. Il fatto che sia più egualitaria di altre non sembra essere di per sé una buona ragione per accettarla. A meno che…
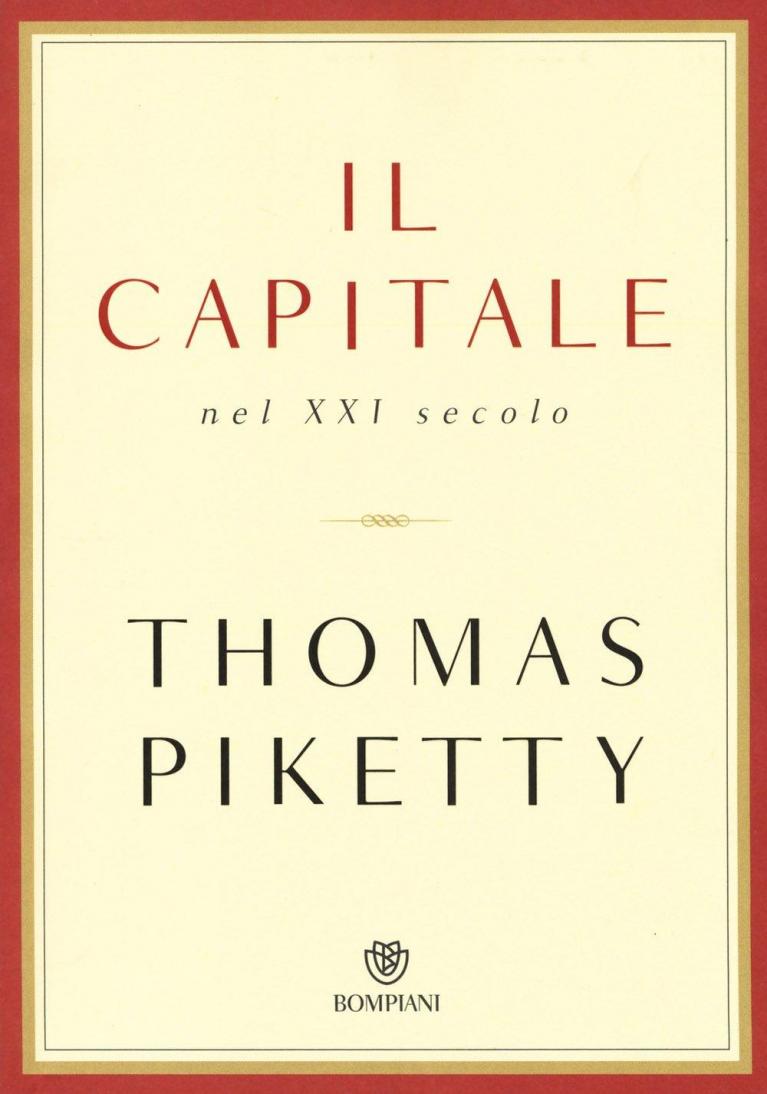
A meno che per Piketty uguaglianza e giustizia siano la stessa cosa, e l’obiettivo di disegnare una società più eguale sia considerato talmente evidente da non meritare neppure una discussione. Questa è l’impressione che si ricava leggendo la prima parte di Capitale e ideologia. “Più eguale” e “più giusto” sono trattati sostanzialmente come sinonimi, e Piketty non si cura mai di dirci che cosa sia l’uguaglianza o perché sia giusta. Per trovare qualcosa di illuminante bisogna superare pagina mille. A questo punto Piketty finalmente ci spiega che una società giusta non è caratterizzata dall’uguaglianza assoluta. È piuttosto una società nella quale le disuguaglianze sono funzionali a migliorare il benessere delle classi meno abbienti. Per chi non ci fosse arrivato c’è in nota un riferimento a John Rawls, il filosofo che nella seconda metà del secolo scorso ha articolato questa idea nella maniera più comprensiva e influente. E questa è tutta la teoria politica che troviamo in Capitale e ideologia.
Ora, si potrebbe rispondere che si tratta di quisquilie da filosofi. Il lettore medio non ha certo bisogno di argomenti per accettare il principio che una società più giusta sia anche una società più eguale (e vice versa). Ma sono convinto che questa risposta sia sbagliata. Numerosi studi mostrano che la maggioranza dei cittadini non identifica semplicemente la giustizia con l’uguaglianza. Una società giusta può anche essere parecchio diseguale, se le differenze sono giustificate. Per convincere l’elettore medio, dunque, l’intellettuale di sinistra non può appellarsi alla giustizia in modo generico. Deve argomentare a favore dell’appropriazione e della redistribuzione del reddito da parte dello Stato. Per dirlo in altri termini: la crisi della sinistra dopo la “Terza Via” di Blair e Clinton (e dei loro ideologi come Anthony Giddens) è stata principalmente una crisi di idee. Il problema oggi non è solo o principalmente convincere gli elettori che sia possibile ridurre la disuguaglianza, come Piketty argomenta ostinatamente per un migliaio di pagine. Bisogna convincerli che sia giusto.
Limitandosi agli aspetti più propriamente economici, la morale del senso comune si fonda su due principi fondamentali — il principio di uguaglianza e quello della produttività. Il primo dice che se un bene o servizio non è stato prodotto da nessuno in particolare, è giusto che sia distribuito in modo eguale. Il secondo dice che chi ha prodotto un bene o servizio ha un titolo speciale nei suoi confronti, un diritto di usufrutto o di proprietà prioritario rispetto a chi non ha fatto nulla. Il problema è come risolvere gli innumerevoli casi nei quali i due principi entrano in tensione uno con l’altro — quando la ricchezza è prodotta con la cooperazione, per esempio.
Rawls dava decisamente priorità al principio di uguaglianza e riteneva che il principio di produttività potesse essere violato tranquillamente per ottenere più uguaglianza. L’unica ragione per rispettarlo è l’incentivo che fornisce ai membri più produttivi della società. Se Lionel Messi dovesse restituire la maggior parte di quello che guadagna, potrebbe allenarsi meno volentieri e produrre meno spettacolo sui campi di calcio. Se un chirurgo di grande talento guadagnasse poco, avrebbe poca voglia di lavorare nel weekend per operare i pazienti — e così via. Uno dei problemi di questo approccio, notato dai critici di Rawls, è che sembra dare per scontato che si possa derogare dall’uguaglianza soltanto quando le differenze di reddito sono un male necessario. Ma la maggior parte delle persone non la pensano così: ritengono per esempio che sia giusto che un chirurgo guadagni più dei suoi colleghi, se è più bravo e lavora più di loro.
Si può provare ad aggirare il problema legando la giustizia economica a parametri come l’impegno, il talento o — per usare un termine che va molto di moda — il merito. L’uguaglianza diventerebbe un principio relativo: non stesso reddito per tutti, ma stesso reddito per chi ha gli stessi meriti. Questa soluzione però non piace a Piketty: “l’ipocrisia meritocratica” è liquidata in pochi paragrafi come ideologia che giustifica la posizione dei vincitori. Probabilmente non ha tutti i torti. Le teorie dell’uguaglianza basata sul merito soffrono di numerosi problemi concettuali. Da una parte il merito non è allineato con il principio di produttività, in quanto il successo nelle economie di mercato premia principalmente la capacità di soddisfare i desideri altrui, che a sua volta può dipendere (e spesso dipende) da fattori estranei al merito quali la fortuna. D’altra parte, provare a compensare le “distorsioni” dovute alla fortuna solleverebbe problemi spinosi. È chiaro che se il chirurgo fosse nato monco non avrebbe potuto operare, ma vogliamo per questo togliergli la maggior parte del reddito alla fine dell’anno? E dove vogliamo fermarci? Non è merito suo avere avuto genitori che l’hanno incoraggiato a studiare. Non è merito suo avere avuto un professore che lo ha ispirato a specializzarsi in chirurgia invece che in geriatria. Non è merito suo essere nato in un Paese — come l’Italia — dove la laurea in medicina è accessibile a molti. E così via all’infinito.
Si potrebbe rispondere che quantificare il merito in modo preciso non è importante. Una volta stabilito che gli esiti delle nostre vite sono determinati in larga parte da fattori che stanno fuori del nostro controllo, possiamo accordarci sul fatto che una significativa compensazione in senso egualitario sia giusta. Quanto redistribuire è un dettaglio secondario. Ma temo che anche questa sia una risposta sbagliata: essa ignora il fatto che una significativa redistribuzione del reddito è ormai data per scontata dalla maggior parte dei cittadini. Nella maggior parte dei paesi europei una quota che varia dal quaranta al cinquanta per cento del prodotto interno lordo è tassato e redistribuito sotto forma di trasferimenti diretti o di beni e servizi (negli Stati Uniti un po’ meno). Il punto intorno al quale verte la discussione politica è quanto redistribuire. In tutti i paesi le tasse gravano principalmente sulle fasce più ricche della popolazione. In Italia il quaranta per cento dei cittadini paga quasi tutte le imposte sul reddito, per dare un’idea, mentre più della metà non contribuisce nulla. Quindi la questione non è se i ricchi debbano pagare più degli altri — già lo fanno — ma quanto debbano pagare in più, rispetto a quanto già fanno adesso.
Questa è la vera questione per Piketty. Si evince da numerosi indizi, ma soprattutto dalla sua ossessione per la fascia di reddito più alta, i super-ricchi del famoso “un-percento”. La distribuzione della popolazione per fasce di reddito ha la forma di una “curva a elefante”: comincia con una grossa gobba a sinistra, in corrispondenza dei redditi bassi e medio-bassi, scende nel mezzo (i redditi medio-alti) per poi salire precipitosamente in fondo a destra (la “proboscide” dell’elefante). Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi trent’anni è stata la crescita della proboscide, ovvero l’aumento sproporzionato delle famiglie con reddito superiore a 200 mila dollari l’anno. È anche successo che nei paesi in crescita, come gli Stati Uniti, la gobba dell’elefante si sia spostata verso destra (come si può vedere qui). Questo significa che un numero significativo di famiglie hanno compiuto un salto dalla classe media o medio-bassa a quella alta o medio-alta. Ma a Piketty la gobba non interessa — lui guarda la proboscide.
Perché questa ossessione? Piketty presumibilmente non odia i ricchi, e non è anti-capitalista in linea di principio. Anche se talvolta presenta le sue proposte come rivoluzionarie, in realtà la sua tassa sulla ricchezza consisterebbe in un aumento delle imposte sul patrimonio dal due-tre al cinque percento all’anno. Sui patrimoni più alti, l’imposta arriverebbe al dieci percento, una misura che non “trascende” il capitalismo (pag. 989) come si vanta l’autore, ma che sarebbe sufficiente a erodere progressivamente l’accumulo di capitale.
L’ossessione a mio parere si spiega in altro modo: Piketty probabilmente intuisce che la vera ragione per prendersela con i ricchi non è economica e neanche morale, ma ha a che fare con l’equilibrio sociale e politico all’interno dei paesi democratici. La democrazia storicamente è emersa e ha funzionato egregiamente grazie alla presenza di una forte classe media. Lo spostamento dei redditi descritto poc’anzi — l’abbassamento della “gobba” dell’elefante — ha quindi avuto come effetto la riduzione del baricentro politico sul quale si reggono i paesi democratici. Si tratta di un mutamento storico di grande importanza, con effetti potenzialmente devastanti. Detto in termini più intuitivi: la crescita della disuguaglianza rischia di rendere i paesi occidentali più simili a quelle società capitalistiche dallo sviluppo incompleto — come alcuni paesi sudamericani o la Russia — che sono caratterizzate da una forte divaricazione fra poveri e ricchi.
Non sarebbe una buona notizia. La divergenza di interessi fra classi troppo distanti per stili di vita, cultura, e capacità di influenzare le decisioni politiche, tende a generare tensioni enormi e difficili da controllare. In molti casi porta alla segregazione sociale, alla violenza endemica (alta criminalità, agenzie di protezione privata, corruzione), e all’emergere di “uomini forti” che cercano di coniugare il populismo nazionalista con la difesa degli interessi dell’oligarchia.
Coloro che hanno a cuore la democrazia fanno bene a preoccuparsi. Credo che Piketty sia fra costoro, anche se non lo dice chiaramente. È un peccato che non lo faccia, perché l’“egualitarismo democratico” offrirebbe argomenti solidi in supporto alle sue riforme. L’obbiettivo della sinistra non dovrebbe essere l’uguaglianza fine a se stessa. I partiti di sinistra dovrebbero cercare piuttosto di preservare la coesione sociale all’interno delle comunità nazionali, senza la quale non può funzionare la democrazia. Questo obbiettivo non richiede una misurazione del merito — perché ha poco a che fare con il merito. E non richiede neppure che identifichiamo la giustizia con l’uguaglianza in senso economico. La libertà e la giustizia politica, se mai, necessitano di una limitazione della disuguaglianza.
Mi sono dilungato su queste questioni filosofiche perché la mancanza di una teoria di fondo è il difetto principale di Piketty. Ma se Il capitale nel ventunesimo secolo era un libro principalmente fattuale, e il deficit teorico poteva essere perdonato, Capitale e ideologia si presenta apertamente come un testo politico. Chi si aspettava un salto di qualità purtroppo resterà deluso.
Restano ovviamente le proposte di riforma: da questo punto di vista, qual è il giudizio complessivo? Piketty ha il grande pregio di sapere presentare e argomentare in modo semplice con i grandi numeri. Le sezioni dedicate alla tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze sono convincenti, nel senso che il lettore resta persuaso che in linea di principio si può fare. Per quanto riguarda il reddito, Piketty rispolvera le aliquote massime della vecchia sinistra, che negli anni Settanta del Novecento in alcuni paesi superavano l’ottanta percento. I proventi di queste imposte sarebbero utilizzati per finanziare una forma di reddito minimo o di cittadinanza, come sostengono molti esponenti della nuova sinistra. Ma soprattutto faciliterebbero una radicale redistribuzione inter-generazionale, in modo da neutralizzare in parte i privilegi ereditari. Queste riforme permetterebbero di ridurre il gap sia di reddito che di opportunità che si è creato fra i giovani e gli anziani, e che continua ad aumentare col passare del tempo.
Piketty non dedica molto tempo a discutere gli ostacoli che una riforma del genere dovrebbe affrontare. Il “familismo” — morale o immorale — di società come la nostra sono effetto e in parte causa della debolezza di altre istituzioni, come quelle statuali, verso le quali i cittadini hanno storicamente poca fiducia. Purtroppo Piketty indossa sempre le vesti del consigliere di un principe o di un popolo illuminato, che una volta persuaso non avrebbe alcun problema ad applicare le giuste riforme. Nel mondo ideale di Piketty il governo è sempre benevolo. I cittadini si fidano degli uomini politici e non li puniscono quando aumentano le tasse (ma provate a chiedere a Giuliano Amato o Mario Monti). I sindacati non difendono mai le rendite improduttive e non portano mai le aziende al fallimento con la collusione dei politici (avrà sentito parlare di Alitalia?). I ricchi sono fonte di tutti i mali e una volta che ci saremo sbarazzati di loro andrà tutto magnificamente.
Nella realtà le cose sono un po’ più complicate, come i veri politici sanno bene. I cittadini non si fidano ciecamente dei governi, anche quando questi ultimi provano a difendere i diritti dei meno abbienti. I cittadini spesso non si fidano l’uno degli altri, per di più, e temono che i trasferimenti di risorse si trasformino in rendite immeritate. Questi ostacoli diventerebbero ancora più impervi qualora la redistribuzione di risorse avvenisse su scala mondiale. Piketty è un sostenitore del superamento dei confini nazionali, sia nella circolazione delle persone che nella solidarietà fiscale. Ma nel suo mondo idealizzato i cittadini non hanno remore a cedere parte della loro sovranità. Gli elettori ungheresi o spagnoli sono disposti a farsi governare da un primo ministro olandese o finlandese, e quando quest’ultimo impone sacrifici o tagli di spesa, li accettano di buon grado. Nel suo mondo si svolgono elezioni europee senza che i candidati possano parlare agli elettori in una lingua comprensibile. Nel mondo di Piketty infine i populisti non possono guadagnare voti sfruttando il risentimento nei confronti degli stranieri.
Temo che gli scienziati politici troveranno i capitoli dedicati alla giustizia trans-nazionale, al populismo e al riscaldamento globale irrimediabilmente ingenui. È un peccato, perché Capitale e ideologia è pieno di cose interessanti. Il problema è che l’analisi delle riforme economiche — in particolare della nuova struttura di imposte — non giustifica un volume di oltre mille pagine. Piketty avrebbe fatto meglio a scrivere un libro più compatto centrato sull’ultimo capitolo, introdotto magari da un breve riassunto dei capitoli precedenti. Il grande affresco storico delle prime settecento pagine merita una trattazione separata e non aggiunge molto alle tesi di Piketty. Un’esplicita difesa dell’idea di giustizia sottostante le riforme invece avrebbe rinforzato parecchio la sua proposta politica. Ma per questo dovremo aspettare il prossimo libro, che il prolifico Piketty non mancherà di scrivere presto.









