Negli Archivi vaticani
Nell’opera di Anselm Kiefer, protagonista di un recente, magnifico documentario di Wim Wenders e ora in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze, è trasposto l’immaginario che l’artista nativo (1945) del Baden-Württemberg ha raccolto con lo sguardo spontaneo del bambino negli anni del Secondo Dopoguerra, immaginario popolato dai ruderi delle città tedesche rase al suolo ma anche dai miti fondativi, sul piano storico-antropologico, della nazione germanica e del Reich (nelle intenzioni) millenario.
Peraltro, come si sa, la prerogativa dell’artista è proprio quella di fornire una rappresentazione del mythos più che di dare voce al logos, come quando Ingmar Bergman, invece di corredare la sua interpretazione autentica di Il Settimo Sigillo con un’analisi razionale dei contenuti teologici della pellicola, si limitò ad affermare di aver riprodotto gli affreschi medievali che in giovanissima età vedeva raffigurati nelle chiese che il padre, pastore luterano, lo portava a visitare.
Ed è proprio l’inconscio popolare germanico di Kiefer e la sua violenza distruttiva prodotta durante il regime hitleriano ad occupare quasi ossessivamente, negli anni drammatici che ne accompagnano la genesi e la successiva implosione in coincidenza con la fine del secondo conflitto mondiale, la mente del Pontefice di allora Pio XII, secondo l’accurata ricostruzione che ne fornisce Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, in un dialogo serrato con l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco trasfuso in un bellissimo volume dal titolo Secretum (Ed. Solferino).
Il Papa, discendente dalla nobile famiglia romana dei Pacelli, “uomo solo” che “studiava moltissimo” ed era “ossessionato dal perfezionismo”, che “leggeva i dossier anche a tavola” e faceva “comprare libri aggiornati sui temi che avrebbero formato oggetto dei suoi discorsi”, muoveva dalla consapevolezza, documentata dalle corrispondenze presenti nell’Archivio, che quel sostrato neopagano che animava i pur battezzati gerarchi del regime e che affondava le radici in quei miti secolari cui Kiefer anni dopo darà una veste figurativa, avrebbe portato, in caso di condanna apertis verbis del nazismo, a rappresaglie contro i Cristiani, non solo tedeschi, di una violenza forse non minore di quella usata nei confronti degli Ebrei. Addirittura, chiosa Mons. Pagano interpretando a posteriori i timori del Papa, non era da escludere una possibile deportazione o, peggio, l’uccisione di quest’ultimo quasi in una replica del Sacco di Roma di quattrocento anni prima.
Pio XII, fine cultore della musica classica e dell’opera ma non a tal punto da unirsi alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Mozart (1956) come sollecitato dal clero austriaco (forse ritenuto troppo indulgente col libertino e massone salisburghese?), finì così col vedersi attribuita la responsabilità storica dei silenzi vaticani in uno dei momenti più tragici della contemporaneità, sebbene la ragione, non sufficiente a valere da scusante, sia da rintracciarsi, come si è visto, nell’esigenza di evitare un’altra ipotetica responsabilità storica. Di quest’ultima non avremo mai la controprova, di modo che il confronto a posteriori tra le opzioni disponibili al Pontefice in quei momenti angosciosi risulta giocoforza asimmetrico; tuttavia, e anzi forse proprio per questo motivo, la drammaticità della scelta è resa ancora più vivida.
Secretum accompagna il lettore in un emozionante viaggio lungo il reticolo di stanze e di corridoi attraverso cui si snoda l’Archivio e lo porta alla scoperta di documenti unici come la pergamena del 1530 contenente la richiesta della nobiltà inglese a Papa Clemente VII, nipote di Lorenzo il Magnifico, di annullare il matrimonio tra Enrico VIII Tudor e Caterina d’Aragona, nell’atto finale di quella disputa che condusse l’Inghilterra a proclamare la propria autocefalia sul piano religioso separando le proprie sorti dalla Chiesa di Roma. Destino tragico, quello dei fiorentini Medici e dell’umanesimo universalistico di matrice classica di cui si erano fatti promotori e interpreti nella letteratura e nelle arti, perché proprio nei momenti in cui, con Leone X prima e Clemente poi, salirono al soglio pontificio furono testimoni (e responsabili?) di due fratture dell’“universalità europea” destinate a non ritrovare più una ricomposizione da lì in avanti.
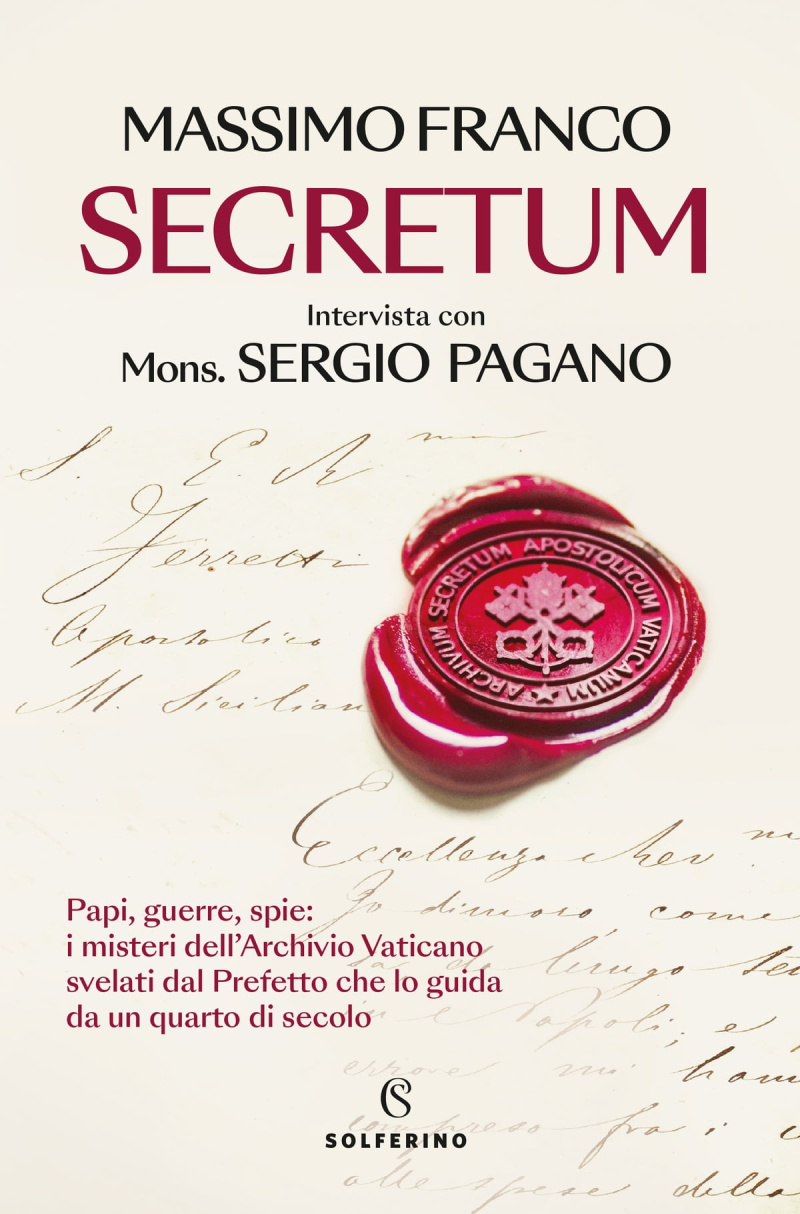
Il volume rappresenta anche quindi, nella forma non del trattato bensì della – più godibile – conversazione vivace tra Mons. Pagano e Massimo Franco, un testo di storia della Chiesa e, attraverso di essa, dell’umanità intera degli ultimi due millenni. Allo stesso modo, è una testimonianza di come un’istituzione come la Chiesa di Roma non possa non definirsi storica, non possa non vivere nella storia e non possa separare i propri destini dalle vicende dell’umanità, non soltanto perché, a differenza che nelle altre religioni monoteiste, la divinità si è fatta uomo, ma anche perché la vocazione universalistica che la caratterizza le impone, come fatto necessario, di misurarsi col mondo e con gli altri aggregati umani animati dal medesimo afflato e quindi destinati a confrontarsi o a scontrarsi con essa.
In questo contesto, i due Autori non potevano non affrontare il tema cruciale del rapporto tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, vale a dire degli Imperi Paralleli come recita il titolo di un libro dello stesso Franco edito da Il Saggiatore nel 2016, ovvero, in senso più largo, dei “due Occidenti” di cui parla Mons. Pagano a proposito delle incomprensioni sorte sin da subito tra le due sponde dell’Atlantico “al punto da impedire l’istituzione di vere relazioni diplomatiche fino al 1984”.
La reciproca diffidenza culturale si manifesta, da parte americana, nella caratterizzazione dei cattolici come “cittadini che rispondevano a un potere straniero, il potere di Roma, percepito come un mostro medievale con a capo questa figura un po’ strana, un po’ sovrano un po’ prete che ricordava figure dell’Antico Testamento”; sul versante vaticano, invece, nell’identificazione di Washington come “la Repubblica dei Massoni”, dove “non contava tanto l’essere un osservante episcopaliano o battista, quanto riconoscersi in una forma di cristianesimo, avulsa da autorità piramidali che rispondono a un potere esterno”. Colpisce, per inciso, l’impostazione metodologica con cui Mons. Pagano, nell’interpretare il sentimento dei cattolici (forse non solo) di allora, pone la struttura-potere a fondamento della sovrastruttura-religione.
Contestualmente, emerge in tutta la sua complessità la questione linguistica legata al massiccio fenomeno immigratorio negli Stati Uniti e ai riflessi che questo poteva avere nell’esercizio del magistero ecclesiastico nel Paese. Fu così che i vescovi americani segnalarono alla Santa Sede la necessità di inviare “clero che parlasse le lingue di questi popoli che arrivavano”, come se si trattasse di “missionari sui generis”. Il motivo, cui si allude in questa circostanza più nella domanda dell’intervistatore che nella risposta dell’intervistato, era da ricercarsi nella necessità di evitare che l’uniformazione linguistica del clero americano ne accentuasse i margini di autonomia nei confronti di Roma e, per converso, la dipendenza da Washington. Qualche secolo prima e sebbene in forme diverse, la stessa questione linguistica risultò uno degli elementi decisivi nel processo di separazione del potere romano da quello tedesco originato dalla Riforma di Lutero.
Stati Uniti e Santa Sede si guardano con circospezione anche quando le dinamiche dei rapporti internazionali ne suggeriscono un rapprochement, in particolare al fine di creare un fronte comune contro la minaccia sovietica nel secondo Dopoguerra. Sono gli anni in cui, nonostante l’opposizione interna del variegato mondo protestante, la Superpotenza temporale consolida il legame stretto con il Vaticano sin dai tempi del primo Dopoguerra, periodo a partire dal quale i flussi finanziari a beneficio di Roma aumentano via via di consistenza tanto da condizionare sia l’elezione dei Papi che la distribuzione delle berrette cardinalizie al di là dell’Atlantico. Ed è in questo quadro che emerge la figura del Card. Spellman, prelato statunitense definito da Franco “manager della fede” e da Mons. Pagano “il Papa degli Stati Uniti”, essendo lui “il vero referente” “nella Chiesa americana”, quasi che l’Impero tornasse de facto ad avocare a sé il titolo di defensor fidei cinque secoli dopo Enrico VIII, pur in assenza di un Imperatore cui attribuirlo e in presenza di una norma costituzionale che vieta di istituire una religione di Stato.
Tuttavia, al fine di evitare la deriva di una Chiesa e di una religione cattolica declassate a instrumentum regni, Papa Pacelli, già diffidente nei confronti della libertà religiosa sancita dalla Costituzione americana, si rifiutò di benedire da Roma la crociata anticomunista “in salsa statunitense”, così come aveva fatto qualche anno prima con quella promossa e ispirata dal regime fascista. Diversi decenni più tardi, l’ascesa al soglio di Pietro di un gesuita proveniente dalla “fine del mondo” accentuerà questo iato fino a produrre una vera e propria lacerazione.
Chi vive, come si è visto, dentro il flusso della storia è necessariamente portato a leggere il presente con lo sguardo sempre rivolto al passato, quasi a sussumere il secondo nel primo, eternizzandolo, e ad annullare distanze temporali anche di secoli, talvolta di millenni, nell’assunto che l’uomo è sempre lo stesso anche se ora comunica con telefoni cellulari e ha imparato negli anni a rendere innocue patologie una volta ritenute mortali. Così, mentre gli artisti come Kiefer si incaricano di portare alla superficie in modo non mediato, infantile, il sedime dell’inconscio dove avviene tale annullamento temporale, in Secretum la stessa operazione viene condotta attraverso la riflessione profonda, il dubbio metodico, la dialettica serrata. L’esito, però, è il medesimo.
Storia dell’umanità, si diceva, ma anche storia personale dell’uomo Mons. Pagano, giunto oramai al termine, non senza una nota di amarezza, del suo mandato come Prefetto dell’Archivio. Contrario alla recente riformulazione del Padre Nostro (“la […] Parola di Dio. E se è di Dio, come possiamo noi cambiarla? Studiarla, comprenderla, ma non cambiarla.”) così come alla ridenominazione dell’Archivio e all’eliminazione dell’attributo ‘segreto’ (“Significava toccare un titolo storico; io sono sempre un po’ tradizionalista su questo.”), censore dell’opulenza in cui vivono molti uomini di Chiesa, scettico nei confronti dell’accelerazione subita dai processi di beatificazione, il padre barnabita rivendica il proprio vissuto di sacerdote e di custode dei documenti in cui è racchiusa la storia vaticana senza sottrarsi a indagarne gli aspetti più contraddittori, più oscuri, laddove affiorano errori, debolezze, ambiguità, mancate assunzioni di responsabilità.
Il carattere umano dell’esperienza sua e dell’istituzione cui appartiene viene così affermato, non negato, proprio per l’immagine di complessità che anche chi è laico ne trae leggendo il volume e che induce ad approfondire e a conservare, in un’epoca di ‘cultura della cancellazione’ che fa da prodromo alla ‘cancellazione della cultura’, la cultura che rappresenta.









