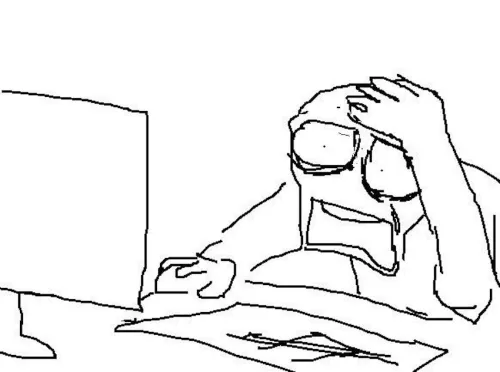Non di soli ‘meme’
Con ‘nuove forme semplici’, sulla scorta di André Jolles, si possono indicare tutte le elaborazioni artistiche che non ibridano componenti eterogenee ma si mantengono entro un preciso ambito stilistico-compositivo. Se prendiamo per esempio la forma ‘meme’ nella sua versione ora dominante (immagine + breve commento scritto), nata in sostanza con i social del XXI secolo, è chiaro che l’elaborazione artistica si può considerare, quanto a implicazioni estetiche, minima, ma si tratta pur sempre di una nuova versione di forme semplici già antiche e in qualche misura elaborate: favolette, barzellette, novellette ecc. Per ottenere effetti analoghi, essendo ormai indispensabile un appiglio visuale nei contesti social, chi aspira a un’efficacia da artista del meme deve lavorare sulla scelta di un’immagine adeguata (p.e. per l’espressione particolarmente singolare di un volto) e sull’ideazione di un commento che renda questa scelta spiritosa in rapporto a un contesto storico-sociale largamente noto. L’insieme è comunque compattato in un’unica e nuova forma semplice.
Si dirà che non si tratta di arte in senso canonico, ma riguardo a questo punto è evidente quanto ormai il ‘capitalismo-artista’ (Lipovetsky) ha allargato i confini: come le forme di pubblicità da tempo hanno conquistato un loro specifico ambito non solo nell’universo della comunicazione sociale, ma anche in quello del lavoro originale su princìpi retorico-compositivi consolidati, così l’universo dei meme social ha progressivamente acquisito una sua precisa codificazione e una serie di regole, adesso estrapolabili dalla massa di esempi disponibili. Rispetto alle arti tradizionali, quelle adatte ai social hanno peraltro una caratteristica ben precisa, la scadenza inevitabile, tanto certa che, stando alle statistiche disponibili nel web, persino i memi con miliardi di visualizzazioni svaniscono e spesso si azzerano una volta terminata la loro moda. In ogni caso, nel periodo di successo hanno ottenuto l’esito considerato ottimale per una qualunque opera che entri nel circuito dei social, e quindi nella logica del capitalismo-artista: massimizzare il suo pubblico, procedendo a eventuali variazioni sul tema, sino all’esaurimento della propria efficacia. Le nuove forme semplici come il meme, e già prima gli slogan con icone o gli spot con jingle, possiedono il vantaggio biologico-cognitivo di concentrare tutta l’attenzione dei fruitori sul loro messaggio immediato, e trovano quindi la loro realizzazione stilistica proprio nella non-mediatezza: non occorrono inferenze, non ci sono quasi mai allusioni complesse, il messaggio e i suoi scopi sono decodificabili alla lettura, l’aspetto di catarsi riguarda quasi sempre il gradimento basico (riso, soddisfazione, senso di superiorità ecc.).

In ambito strettamente letterario, vanno considerate nuove forme semplici tutte quelle che coinvolgono generi e sottogeneri consolidati, quindi dotati di caratteri facilmente replicabili (anche dalle forme di IA), e si limitano ad aggiungere una componente in precedenza censurata (sesso, violenza, perversione…), prendendola da altre forme semplici ma senza alcuna ibridazione: il caso paradigmatico è quello delle serie di Cinquanta sfumature, che amplia il confine del romanzo un tempo definito ‘rosa’ o ‘harmony’ con componenti in genere riservate a quelli erotico-pornografici. Ma anche nuovi romanzi storici su importanti famiglie del passato o su singole figure che possono risultare quasi esemplari riprendono forme semplici del romanzo tradizionale, giocando su modeste ma significative varianti riguardo alla componente didattico-moralistica da sempre implicita in questo tipo di opere, che adesso sono disposte a valutare positivamente le ribellioni femminili, le trasgressioni omosessuali, i comportamenti illeciti, come in passato era possibile solo nei testi di autori fuori della media.
Ma le nuove forme semplici riguardano più in generale le scritture romanzesche che non problematizzano l’etica dei personaggi e che pongono in maniera netta valori e disvalori, benché le trame risultino magari inutilmente complesse. È quanto avviene di solito nel settore più notevole della produzione letteraria attuale, il fantasy in tutte le sue declinazioni, sviluppatosi di molto nel XXI secolo. Rimangono certo altri generi di successo stabile (in primis il poliziesco), tuttavia l’esplosione del fantasy nelle vendite e nelle ricadute in ambito cine-tele-web visivo è chiarissima. Ormai si è creato, specie tra le generazioni dei Millennials, un canone condiviso che ha per capostipite Tolkien, prosegue con la saga di Harry Potter e conduce poi alle innumerevoli varianti attuali. Fenomeni nati come scritture in rete, ma in effetti fondati su una precisa e limitata conoscenza di testi di tipo fantasy, hanno conquistato le classifiche di vendite in molti paesi. In questo caso, fondamentale è la possibilità di diventare fan di un romanzo o magari di un videogioco, e poi (la sequenza però non è sempre scontata) di film, serie televisive, ecc.: la condivisione social è in questo caso il segno dell’efficacia della nuova forma semplice fantasy, che è replicabile, imitabile, ri-vivibile a livello mondiale, e permette di uscire dal mondo noto e delusivo per entrare in uno virtualmente rivivibile in ogni momento, e non solo p.e. ai concerti o alle proiezioni cinematografiche come nel XX secolo.
Il fantasy in tutte le sue declinazioni può insomma riproporre, a livello biologico-cognitivo, sentimenti semplici e depurati nonché situazioni narrative primarie (amori, conflitti, tradimenti ecc.) senza mediazione interpretativa e stratificazione, solo appoggiandosi alla propria specifica tradizione, che è ormai condivisa e autonoma rispetto a quella dei canoni letterari e artistici di tipo estetico-valutativo. Si tratta non di un semplice genere, bensì di una modalità dell’immaginario facilmente replicabile: la novità ‘meravigliosa’, che di per sé attrae, deve riguardare un mondo totalmente altro rispetto a quello già fruibile, in cui il godimento è solo parziale, e gli eventuali messaggi relativi a possibili implicazioni (come quelle squisitamente psicanalitiche nelle ultime parti di Harry Potter) devono generare dubbi interpretativi limitati, inerenti al mondo possibile generato. Invece sono solo esteriori le eventuali complicazioni tematiche o strutturali: le ‘nuove forme semplici’ fantasy possono persino risultare difficili da decodificare al loro interno (come avviene p.e. nelle varie serie di Game of thrones), ma restano basiche e immediate nella loro concezione di fondo.

Di contro, esistono ‘nuove forme stratificate’ che richiedono un’interpretazione soprattutto dei sottintesi, quindi una necessità inferenziale alta e spesso un’enciclopedia ampia riguardo alla tradizione letteraria e artistica precedente. Rispetto al periodo del postmodernismo trionfante, in cui questo tipo di opere risultava largamente diffuso, soprattutto dopo la diffusione dei social la stratificazione riguarda in prima battuta l’immaginario di lunga durata (quindi l’ambito che continuiamo a definire dei ‘classici’), ma insieme quello di larga diffusione, pop nel senso più ampio del termine, ossia ormai qualunque tipo di prodotto che sia veicolato nel web-cloud. Gran parte dei testi narrativi del terzo millennio sono quindi intrinsecamente ibridati, ma non solo per effetti di mescolanza o per la necessità di una lettura double coding alla Eco, ma perché il loro carattere fondativo è quello di nascere da un’elaborazione-ispirazione che coinvolge l’indistricabile convergenza di quanto è stato ricavato dalla percezione del mondo mediatizzato e dalle proprie fruizioni culturali in ogni campo: quello scolastico, con i suoi vari tipi di canoni, è adesso solo una componente minoritaria di quanto può ricavare individualmente o socialmente un essere umano nella sua Bildung.
Le nuove stratificazioni delle opere artistiche in generale e nelle narrative in particolare non riguardano una rielaborazione intellettuale e a suo modo elitaria del patrimonio culturale ereditato, bensì un effettivo e nuovo oggetto di condensazione e aggregazione multivettoriale: come nel Cloud, più ancora che nel Web, dove molto è già preventivato dagli algoritmi, il punto di condensazione viene raggiunto quando una massa critica elaborata dal singolo autore diventa dicibile con uno stile riconoscibile, ovvero con una forma che fa riconoscere un processo lungo di addensamento e di stratificazione che deve essere compreso. Questo aspetto si può cogliere persino in forme brevi o brevissime: è la differenza essenziale tra gli aforismi a forte tasso cognitivo rispetto ai memi univoci.
Le nuove forme stratificate sono quindi quelle in cui ancora, nonostante tutto, le elaborazioni stilistiche, da intendere in senso ampio (biologico-cognitivo prima ancora che tecnico), sono percepibili e pongono in discussione ogni aspetto proprio delle nuove forme semplici. Il weird, per esempio, contiene di certo, come notava già Mark Fischer, una componente anti-sistema capitalistico, ma attualmente è anche una sorta di anti-fantasy, che contribuisce a una ridistribuzione pure della trafila storico-letteraria: basti pensare alla ricollocazione di Lovecraft, un tempo considerato un semplice minore fra gli scrittori del fantastico-horror. Ma in generale la stratificazione si può cogliere là dove si ibridano componenti testuali in genere assai lontane: in alcuni casi si è già arrivati a nuovi generi codificati (p.e. le graphic novel come evoluzioni delle forme semplici dei cartoons), ma molti sono i testi intrinsecamente ibridi, p.e. basati su un rapporto imprevisto fra testo scritto e foto o video: un esempio recente è la narrazione ‘deformata’ di immagini-parole proposta da Marco Magurno nel suo Persona (Polidoro 2024): ma molto si ritrova anche in ibridazioni narrativo-poetiche come quelle proposte, per esempio, dal rimpianto Alessandro Broggi o da Tommaso Di Dio.
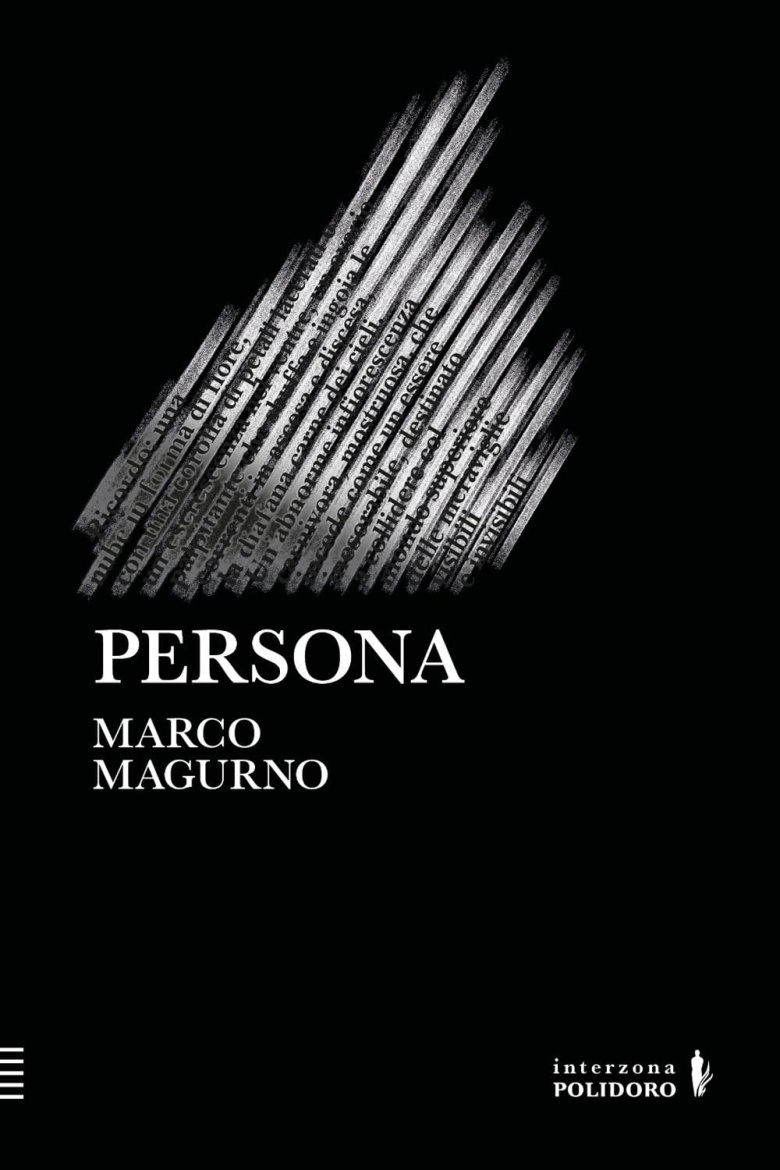
Le forme letterarie canonizzate vengono insomma superate ma non eliminate, come avviene nelle forme di racconti ultrabrevi o in generale nei testi nati da post in blog o nei social. Peraltro, anche da quelli che erano votati all’efficacia nella stringatezza imposta o autoimposta possono derivare testi o ipertesti che si stratificano, specie a livello di costruzione complessiva: si possono citare i casi di Mio salmone domestico di Emmanuela Carbé, configurato come oggetto narrativo ibrido (è chiuso da una favola a fumetti dell’autrice) nel 2013, e dei Personaggi precari di Vanni Santoni, progressivamente stratificati sino alla versione forse definitiva del 2024.
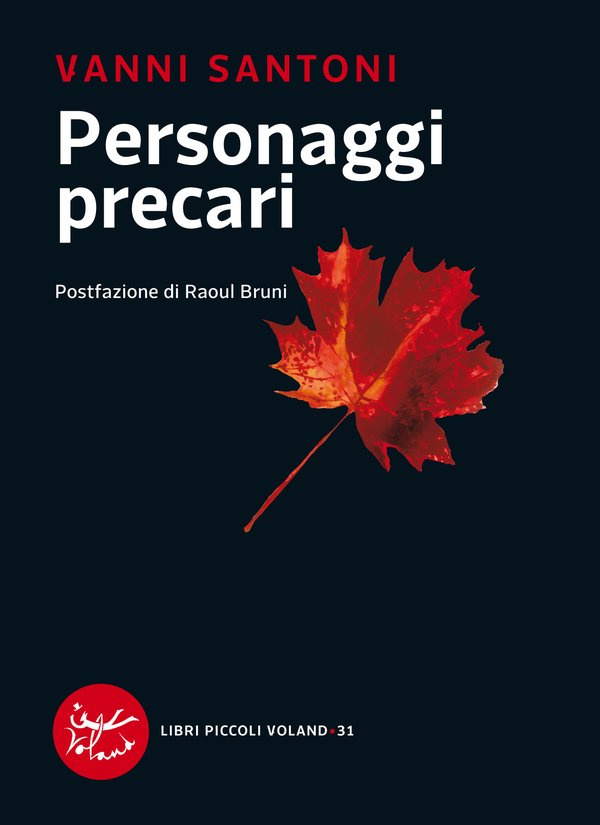
La forma ultima della stratificazione si può cogliere spesso in testi narrativi di amplissimo sviluppo, che non coincidono più né con le Opere mondo di Franco Moretti (1994), segnate dal titanismo e dalla confidenza dell’autore nella superiorità della propria inventio, né con i tanti romanzi massimalisti del Novecento. Le nuove opere mondo del XXI secolo non aspirano a essere riepilogative e sanno di dover accettare la loro marginalità nel campo di forze culturale; tuttavia possono così approfondire il senso completo di vicende che riguardano una moltitudine di vite e quasi sempre quella personale dell’autore (al di là, com’è ovvio, di ogni banale determinismo biografico). È il caso, per esempio, di Solenoide di Mircea Cărtărescu, nel quale il filo narrativo-diaristico, che costituirebbe una forma semplice persino scontata in questo caso (‘rievoco la mia difficile infanzia sotto un regime dittatoriale’), diventa solo il pretesto per continue sovrapposizioni di modi di percezione della realtà oscillanti tra l’horror, il fantascientifico, il grottesco ecc., per arrivare a un autentico weird complessivo. Si può almeno provvisoriamente concludere che, mentre una ‘nuova forma semplice’ deve cercare di ottimizzare i suoi mezzi, come adesso fanno con notevoli risultati ed efficacia molte di quelle pensate dall’IA per la pubblicità o l’attività nei social, una ‘nuova forma stratificata’ dovrebbe generare nuclei di senso irriducibili al già noto attraverso il raggiungimento di effetti disturbanti, weird a livello costitutivo e non solo esteriore, ulteriori rispetto alle nozioni acquisite anche riguardo agli aspetti psico-patologici, considerati essenziali nello sviluppo di molte forme artistiche dal Romanticismo in poi. Il problema critico, e quindi di politica culturale, è adesso quello di come valorizzare e semmai ampliare la condivisione delle nuove forme stratificate: la condizione attuale è quella di un loro prestigio che però riguarda una minoranza assoluta dei fruitori di narrative del XXI secolo.
Nota bibliografica
Questo breve articolo fa parte di una serie di ricerche in corso di elaborazione, ma riparte da quanto ho scritto in volumi già editi: mi sono riferito soprattutto a Romanzi di Finisterre. Narrazione della guerra e problemi del realismo (Carocci 2000) e a Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (il Mulino 2007) sul versante dell’analisi; a Letteratura e controvalori (Donzelli 2014) e a Biologia della letteratura (il Saggiatore 2018) in ambito teorico-storico. Oltre che all’ampia bibliografia ricavabile da quei volumi, rinvio anche al recente La brevità nella narrativa italiana contemporanea: qualche riflessione teorica e qualche esempio, in “Narrativa”, 46, 2024, pp. 201-212 per ulteriori riferimenti. In generale, molti spunti si possono ricavare da G. Di Giacomo-U. Rubeo (a cura di), Il romanzo del nuovo millennio, Mimesis 2022, e G. Benvenuti (a cura di), La letteratura oggi. Romanzo, editoria, transmedialità, Einaudi 2023.