Paolo Fossati fuori dai generi
Critico, scrittore, storico dell’arte, filologo, editore, letterato… Non si può parlare dei libri, a maggior ragione se antologici, di Paolo Fossati (1938-1998) senza ricordarne con tratti pur brevi la fisionomia proteiforme della personalità, perché i diversi ruoli e modi in cui si è espresso sono a vario titolo sempre presenti, congiunti, nella sua letteratura. La multiforme attività intellettuale di Fossati è davvero singolare, perché non si è limitato a operare di volta in volta sui diversi fronti della critica, della cura espositiva, della storiografia, dell’editoria, ma ha fatto di questa apertura eclettica lo stesso metro conoscitivo di una ricerca che a sua volta trova conferma negli stessi soggetti artistici sottoposti al vaglio della sua interpretazione, della sua scrittura.
Dovendo condensare in poche parole il suo campo di interessi, potremmo definirlo il «Novecento artistico-letterario», o meglio – come proverò a mostrare – il Novecento visto e letto attraverso la crisi dei generi delle arti tanto visive quanto letterarie, con annesse le relative sinestesie, confusioni, ibridazioni… Ed ecco spiegato perché nella scrittura di Fossati troviamo, rivendicata, una analoga riluttanza alla distinzione tra i generi artistici e letterari, che si tratti della recensione o introduzione a una mostra, dell’interpretazione critica di un artista, della singola filologia di un quadro o testo, del racconto storico artistico di una stagione… e persino che si tratti di scelte editoriali. I suoi lavori insistono di continuo sui travasi e trapassi tra «linguaggio di pittore» e «linguaggio di poeta», tra «figure» e «storie», facendo emergere le congiunzioni e ibridazioni, dichiarate o celate che siano, tra i generi visivo e letterario che hanno indirizzato molta arte «alta» del Novecento, arte di cui Fossati è stato non solo un imprescindibile interprete ma anche – per così dire – un artista collega tramite la sua «prosa d’arte».
«Prosa d’arte»: rare volte come in Fossati questa formula, sorta peraltro negli ambienti artistici del primo Novecento che gli erano cari, acquista significato, poiché richiama esattamente il binomio letteratura-pittura da lui tanto studiato e traslato nella propria scrittura.
Sulla scorta di questi riferimenti, mi azzardo a definire la scrittura di Fossati una forma di sinestesia letteraria – e con questo spero di riallineare certe bocche storte che non lo vorrebbero annoverare quale «storico» e «filologo» perché non rispetterebbe i protocolli (accademici) o i canoni (corporativi) di dette discipline, richiamate al rispetto di un pensiero unico. La sua sinestesia letteraria, al contrario, piaccia o meno, è a mio parere ciò che meglio valorizza anche il lavoro storiografico e filologico di Fossati – insieme naturalmente al lavoro di critico in senso stretto dedicato per esempio ad artisti contemporanei, e al lavoro editoriale con cui ha parlato spesso di sé attraverso i libri degli altri. La sua «prosa d’arte», insomma, insofferente alle convenzionali distinzioni di genere come nei lavori di tanti suoi artisti amati, sempre intrisa in diversi dosaggi di saggismo e filologia e racconto, non va riduttivamente intesa quale originale sfida stilistica, bensì come autentico strumento gnoseologico – eteroclito, certo!
Per giorni interi non ho fatto altro che leggere (e rileggere) i libri di Paolo Fossati, spinto a farlo dalla nuova e corposa antologia dei suoi Scritti. La letteratura come metodo dello sguardo, da poco pubblicati per i tipi di Electa, Milano 2024, con l’attenta cura di Chiara Portesine. È una «combinazione di tessere tematiche» ben congegnata la nuova antologia del «Fossati letterato», che raccoglie testi giornalistici e recensioni, interventi del critico «militante» e saggi sparsi insieme a capitoli di alcuni libri. E perfetta è la copertina (il libro, che inaugura una collana di Scritti in cui seguiranno presto quelli di Paolo Volponi e di Marco Vallora, nelle sue oltre quattrocento pagine, per coerenza, non contiene nemmeno una illustrazione). Poiché la copertina è solo grafica, anch’essa senza immagini, ne risulta che sia lo stesso brano di scrittura riportato a diventare immagine. E il succinto brano che in copertina sigilla la sinestesia parola-immagine è altrettanto ben scelto. Riporta un estratto dell’articolo Gli incontri umani di Carlo Levi, comparso su «L’Unità» del 6 dicembre 1966, dove Fossati parla dell’«osmosi continua tra letterato e pittore, cioè tra visione culturale affidata alla visione e all’integrazione della poesia e materiali e dimensioni più specificamente pittorici…».
L’arte «bifida» di Carlo Levi veniva colta al volo dal giovane critico d’arte, laureatosi in filologia a Torino due soli anni prima ma già consapevole dell’intuizione gnoseologica di fondo che lo accompagnerà negli anni a venire: l’arte del Novecento (solo quella?) andrà, insieme, «vista» e «letta», che si tratti di una pittura o scultura… o di un romanzo, una lirica, un taccuino, un lavoro teatrale – significative al proposito la curatela nel 1967 della Calandria cinquecentesca del Bibbiena, e soprattutto La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, libro Einaudi del 1977, da cui l’antologia or ora pubblicata riprende alcuni capitoli. L’«osmosi» tra letteratura e arte visiva e la relativa filologia, non verrà tuttavia limitata da Fossati agli artisti dal «doppio registro» espressivo quali Carlo Levi, o a seguire De Pisis, Carrà, i De Chirico…, i quali sanno di volta in volta dipingere o scrivere; e nemmeno riservata a operazioni complessivamente sinestetiche come gli spettacoli della compagine futurista. A sancirlo, sempre in quel precoce 1966, troviamo la recensione a una mostra a Torino – città dove Fossati ha vissuto e operato – del praghese Jiří Kolář, che lo entusiasma con i suoi collages saturi di «labirinti, pullulii, anditi, ritmi» in cui i richiami alla poesia concreta del periodo si innestano sull’evocazione degli esperimenti surrealisti in cui linguaggio verbale e immagine e oggetto (anche qui) si travasano per confluire in opere ibride di icono-grafia, meglio: di icono-scrittura.
Mi rendo conto di stare usando un lessico qua e là tortuoso, ma d’altronde questo rispecchia anche la scrittura di Fossati «strategicamente ostile ai dizionari comuni», il suo «carattere impervio, a tratti involuto» – come ha scritto Michele Dantini.
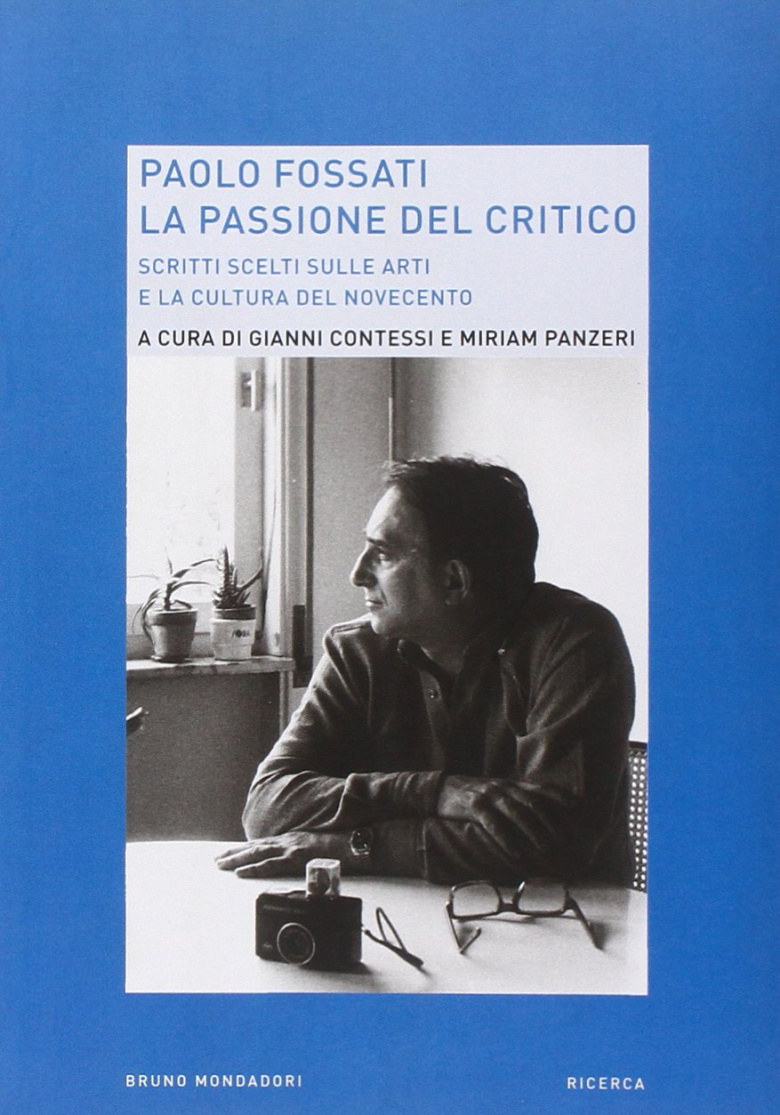
Quella che mi piace definire «l’intuizione gnoseologica» di Fossati viene ben riassunta dal sottotitolo posto al nuovo libro antologico: La letteratura come metodo dello sguardo, dove la «letteratura» andrà affrancata dagli stereotipi narrativi e, appunto, intesa quale «prosa d’arte» che, posta oltre i generi canonici, si fa strumento per interpretare ad armi pari l’irruente processo storico novecentesco in cui si è in parallelo consumata la crisi dei generi artistici tanto visuali quanto letterari, entrambi investiti da sfrangiamenti, osmosi, agoni, ibridazioni e sinestesie più o meno dichiarate tra «linguaggio di pittore» e «linguaggio di poeta». Continuando a scorrere l’assemblaggio degli Scritti, incappiamo così in recensioni di mostre dove Fossati, sin dagli esordi negli anni 1960, scrive della «parola concreta» di Heinz Gappmayr, di Veronesi «uomo di poesia», di Zavattini «narratore, scenarista, diarista, pittore», di «pittura con Pavese», di «scacchiere con parole» di Kolář, del «doppio registro» di Carlo Levi, di «una poesia» di Paolini… A questi casi succederanno via via, confluendo nei suoi libri della maturità dedicati in particolare al primo Novecento italiano (la stagione artistica più amata e studiata), testi dedicati ai «canzonieri di Carrà e De Chirico», a «prose di De Pisis», al «romanzo di Savinio», sino a giungere all’«istinto leopardiano» di Giorgio Morandi e al «realismo poetico» di Lalla Romano… Tutti questi scritti ribadiscono una scelta gnoseologica che – per citare Robert Walser, i cui Ritratti di pittori Fossati credo avrebbe inserito volentieri nella «sua» collana Einaudi Letteratura – va sempre a cercare nei quadri «l’effetto d’un racconto in piena regola», così come in parallelo nei lavori di scrittura va sempre a svelare le «figure».
Il concetto di «figura» è fondamentale. Per quanto talvolta oscuro e volutamente tenuto al riparo da teorizzazioni, Fossati non vi rinuncia mai nei fatti, giacché è attraverso di esso che può leggere l’arte novecentesca, compresa quella cosiddetta astratta, come arte per intero «figurativa». Sicché il suo racconto storico ne risulterà più novellistico per quelle opere visive in cui sopravvive il soggetto della realtà, mentre per quanto riguarda le opere astratte che pretendono di essere realtà in sé, il racconto filologico declinerà piuttosto in senso più «linguistico», poetico, del flusso di coscienza.
Nel nuovo libro antologico degli Scritti tornano di continuo testi rivelatori dell’interesse prioritario di Fossati per la confusione «semiologica» che si accompagna alla crisi dei generi e linguaggi artistici novecenteschi. Esemplare è Paragrafi per il disegno fra due guerre, dove egli richiama le argomentazioni di Cesare Segre nella voce Generi dell’Enciclopedia Einaudi; mentre altrove, a dimostrazione dell’apertura concettuale e storica con cui egli «visitava» le mostre con sguardo sempre attento a catturare il posizionamento dell’artista entro l’orizzonte dei generi artistici, leggiamo l’acuta recensione alla mostra parigina del 1972 dei disegni di Victor Hugo, il vulcanico scrittore di cui non si lascia sfuggire l’apocalittica diagnosi storica fissata in Ceci tuera cela. Nella digressione saggistica Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio, contenuta nel romanzone Notre Dame de Paris pubblicato nel 1832 ma ambientato nel 1482, Victor Hugo pronostica addirittura la fine dell’architettura sotto i colpi letali inferti dalla letteratura (qui da intendersi come invenzione della stampa, come nascita del libro). Rammentandoci la formidabile speculazione di Hugo, ancora una volta Fossati ci sta dicendo che le arti procedono per confronti, anche agoni (il lato oscuro dell’osmosi) tra generi visuali e letterari. In Questo ucciderà quello Hugo parla dei «due registri dell’umanità: la Bibbia di pietra e la Bibbia di carta». Ebbene, scoprendo solo in questi giorni la recensione di Fossati, ho maturato il convincimento che nell’apodittica coppia «libraria» dello scrittore parigino egli abbia visto un annuncio e un suggerimento per la sua intuizione gnoseologica: raccontare il «doppio registro», visuale e letterario, dell’«umanità» artistica del Novecento, secolo nel quale, particolarmente nella prima parte, si sarebbe consumato un autentico agone, di confronto e incrocio e persino amplesso, tra «libro visivo» e «libro scritto», tra «linguaggio di pittore» e «linguaggio di poeta».
Quello che abbiamo qui sopra definito «doppio registro artistico», a questo punto acquisterà ancora più senso se lo rinominiamo «registro dell’insofferenza ai generi», insofferenza che trova una sorta di suggello anche nell’eccezionale attività editoriale di Fossati. In particolare – come ricorda Marco Belpoliti in appendice al libro degli Scritti – «dando vita nel 1969 con Giulio Bollati a Einaudi Letteratura, la collana dove si incontrano le opere di Beckett, Benjamin, Bataille, Gadda… ma anche i libri di Lucio Fontana, Man Ray, Giulio Paolini…». Nel «secolo» che tutto ha trascinato nella sua «svolta linguistica», il Fossati editore, al pari del «critico e scrittore» ci dice che – per usare le parole di Maurice Blanchot in Lo spazio letterario, fatto pubblicare dallo stesso Fossati nel 1969 per i tipi dell’Einaudi – «le forme, i generi non hanno più significato… Il libro solo importa».
Alla nuova e nutrita antologia, come dicevo, ho affiancato parziali riletture di altri libri fossatiani: innanzi tutto quelli postumi antologici: La passione del critico. Scritti scelti sulle arti e la cultura del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2009, a cura di Gianni Contessi e Miriam Panzeri, bravi curatori anche di Officina Torinese. Gli scritti giovanili di Paolo Fossati sull’arte nelle cronache de «l’Unità» 1965-70, Aragno, Torino 2010; e ho infine allargato la lettura almeno ad alcuni brani dei suoi ultimi due libri, da cui la nuova antologia ripropone alcuni capitoli, libri di cui ebbi la fortuna di parlare con lo stesso autore: Storie di figure e di immagini. Da Boccioni a Licini, Einaudi, Torino 1995, e Autoritratti, specchi e palestre. Figure della pittura italiana del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 1998, pubblicato quest’ultimo poco avanti l’inattesa, sofferta scomparsa dell’autore.
Tutti questi libri, che ora conferiscono uno statuto compiutamente «letterario» anche agli scritti del giornalista, del critico «militante» o del saggista d’occasione, mi paiono un degno riconoscimento alla sua «prosa d’arte», sempre movimentata – come ha scritto Gianni Contessi – da una scrittura di «macchinosa bellezza» che interroga in ogni pagina «la dimensione letteraria della misteriosa signora che ha nome Storia dell’arte». Tanto che la nuova antologia degli Scritti dedicata al «Fossati critico d’arte “letterario”» – come specifica la brava curatrice – mi fa augurare che in un futuro prossimo si possa vedere pubblicato un volume ancora più esauriente di sue «opere scelte» comprensive anche di alcuni libri integrali, magari in una di quelle collane che «classicizzano» il singolo autore, quale i Meridiani Mondadori, collana letteraria di prim’ordine aperta alla «prosa d’arte» (penso ai volumi dedicati alla produzione critica di Roberto Longhi e Emilio Cecchi, ma anche al saggismo irregolare di un Fosco Maraini…).
Interrogandosi sul continuo trapassare novecentesco da letteratura e pittura e viceversa, così Fossati scriveva nelle pagine di esordio di Storie di figure e immagini: «Se questo è vero, saremmo alla fine di una parabola che, grosso modo, ha inizio con Diderot: quando Jacques il fatalista, l’eroe del suo romanzo chiede al padrone se gli piacciono i quadri, si sente rispondere: oui, mais en récit. A noi, interpellati oggi, in tema di saggistica e critica, cioè di récit d’epoca, capiterà l’ovvia replica, oui, mais en tableaux».
Al mio contributo per L’intellettuale mal temperato. Scritti in onore di Paolo Fossati, a cura di Miriam Panzeri, Accademia University Press, Torino 2015, davo il titolo di Paolo l’ecfrastico, concludendo il breve testo citando proprio questo riferimento all’amato Diderot. In Fossati, infatti, io identifico il «prosatore d’arte» che – a mia conoscenza – ha meglio colto e raccontato le declinazioni nel contemporaneo del plurisecolare tema dell’ecfrasi, dimostrando quanto l’oraziano ut pictura poesis abbia trovato nel Novecento artistico, soprattutto italiano, una nuova, fervida stagione – l’ultima?









