Europe d’Oriente 2. La Russia di Gino Kirill Piovesana
Lessi Filosofia contemporanea giapponese di Gino Kirill Piovesana per miei scopi letterari. Il suo secondo libro lo lessi per semplice apprezzamento dell’autore, del suo sguardo “ecumenico” sul tema della migrazione culturale e i conflitti che le si accompagnano. Allora (oltre dodici anni fa) il libro era ancora reperibile sul mercato, così potei procurarmi una copia di Russia–Europa nel pensiero filosofico russo. Storia antologica. Il testo era stato pubblicato nel 1995 da Lipa, piccolo editore collegato al Centro Aletti e al Pontificio Istituto Orientale di cui Piovesana era a quel tempo Rettore (morirà l’anno seguente). Anche in questo caso, approfittando dell’“attualità” della crisi russo–ucraina, ho provato a farlo ripubblicare (con migliore cura redazionale!) presso un editore commerciale, ma senza successo, come è avvenuto per il libro sul Giappone.
Come detto, Piovesana era uno studioso di cultura russa – per quanto questa, come egli ci insegna, comporti considerazioni molto controverse per la sua sfrangiata circoscrizione geografica e storica, pregna com’è di una stratificazione plurisecolare che l’autore ha restituito più ampiamente in un altro suo libro, anch’esso fuori commercio e che ho potuto solo consultare in biblioteca: Storia del pensiero filosofico russo (988–1988), San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (MI) 1992. A questo esteso racconto storico che si snoda lungo un intero millennio, Piovesana, spinto dalle domande sul «destino della Russia dopo il tramonto dell’ideologia comunista», decise di affiancare un «complemento e aggiornamento» che meglio facesse comprendere il confronto Russia–Europa sviluppatosi a partire da Pietro I, il grande zar fondatore della nuova capitale San Pietroburgo «finestra sull’Europa» (Puškin), che, a inizio Settecento, «volendo introdurre la tecnica europea in Russia, rafforzò l’autocrazia». Nell’Introduzione di Russia–Europa… l’autore discute gli studi di autorevoli russisti del secondo dopoguerra, vi riassume «l’isolamento della Russia fino a Pietro il Grande e l’apertura all’Europa nel Settecento», per passare quindi a una dettagliata Storia antologica, ottenuta con un montaggio di brevi commenti alternati a estratti da testi e documenti originali, in cui dipana il dibattito tra occidentalisti e slavofili dispiegatosi irruento lungo l’Ottocento, dibattito poi declinato (soffocato) dalla dittatura marxista del bolscevismo, e a seguire rintracciato lungo il Novecento seguendo i percorsi dei «filosofi in esilio», per interrogarsi nell’Epilogo sulle forme di continuità storica di tale dibattito negli scenari post–comunisti che gravano ancora sui nostri giorni.
Scrive Piovesana: «Il confronto intellettuale Russia–Europa non nacque con la famosa Lettera di Čaadaev del 1836, né con il formarsi dei gruppi opposti di slavofili ed occidentalisti negli anni Quaranta. Con tale formazione, però, quel confronto si formalizza e viene ad assumere aspetti che, con sviluppi ben diversi, perdurano tuttora. Dai tempi di Pietro il Grande i contatti con l’Occidente s’erano moltiplicati e i russi venivano a conoscere sempre più l’Europa… e il sorgere di una coscienza nazionale fra gli slavi indusse gli intellettuali russi a chiedersi sempre più quali fossero i destini della Russia rispetto all’Europa, alla quale erano ormai tanto legati». In Europa occidentale, in realtà, vi aveva speso due lunghi viaggi lo stesso Pietro I (nel 1697–1698 e nel 1716–1717), iniziando presto a importarne scienziati, professori e tecnici, soprattutto dalla Germania. Ma «Pietro I non fu uno zar illuminista, come lo fu invece Caterina II, ammiratrice di Voltaire, Diderot e Montesquieu». (Mi sono chiesto se Nishi Amane, un secolo esatto dopo, durante le lezioni sulla filosofica occidentale all’Imperatore Meiji in Giappone gli parlò degli incontri tra gli intellettuali illuministi e l’imperatrice.) Pietro il Grande si limitò ad applicare la dura «legge» storica di Toynbee, ossia promosse l’assimilazione di un sapere europeo sostanzialmente tecnico, senza curarsi che la modernizzazione centrata sul potenziamento di esercito e flotta navale, sull’organizzazione dell’industria siderurgica e del sistema burocratico, si allargasse a una modernità della cultura, come invece proverà in parte a fare Caterina II. Sulla scia di queste figure che sembrava dovessero fare uscire la Russia da secoli di isolamento, i successivi rapporti con l’Europa non si sciolsero mai con la vittoria del fronte europeista, e l’insistenza con cui hanno continuato a operare tra Otto e Novecento le forze intellettuali e politiche del fronte slavofilo (o addirittura euroasiatico), mostra quanto il problematico caso russo preoccupasse anche a livello internazionale – basti ricordare Tomáš Masaryk, il filosofo sociale primo presidente dello Stato cecoslovacco, che nel 1913 pubblicherà La Russia e l’Europa, redatto dopo vari soggiorni nel Paese e incontri avuti tra gli altri con Lev Tolstoj.
Dai contrasti emersi tra i due fronti, Piovesana fa inoltre emergere due diverse modalità nel confronto con la filosofia europea. Presso gli occidentalisti questa viene sì recepita in varie forme di idealismo, hegelismo, positivismo, poi marxismo e infine esistenzialismo, ma senza riversarla, se non occasionalmente, in forme di dichiarata assimilazione o di diretta discussione teoretica dei discorsi e sistemi originali. Questi vengono semmai declinati, via via, in forme di filosofia sociale “applicata” alla storia e realtà russa. La dimensione squisitamente teoretica del «pensiero filosofico» la vediamo ben più praticata tra gli slavofili, che tendono a rivendicarne forme autonome e talvolta ostentatamente autoctone. Verso fine Ottocento ne saranno esempi illustri i testi di filosofia del diritto e sul rapporto tra scienza e religione di Boris N. Čičerin (che fu anche precettore dell’erede al trono, morto prematuramente), e soprattutto quelli di Vladimir S. Solov’ëv sulla Crisi della filosofia occidentale, cui contrappose la Teosofia libera, «sintesi organica della teologia, della filosofia e delle scienze sperimentali».
Impossibile riassumere qui un tale intricato, a volte criptico e contraddittorio, dibattito storico, per quanto sezionato da Piovesana con competenza. In un veloce sorvolo narrativo, possiamo solo richiamare alcune delle figure più significative dei due fronti ottocenteschi. Si può partire dagli slavofili Ivan V. Kireevskij e Aleksej S. Chomjakov, inflessibili rivalutatori della tradizione russa e in particolare della religiosità del suo popolo contro «l’astratto intellettualismo dell’Occidente». Sempre a metà Ottocento, ad essi si contrapposero tra gli altri Vissarion G. Belinskij e Alexander Herzen, il primo con l’accusa a Nikolaj V. Gogol’ di elogiare nei suoi romanzi proprio la religiosità del popolo russo cara agli slavofili; il secondo con una critica del «dispotismo esasperante» che regnava nel Paese, ma al contempo, smussando scetticamente il proprio occidentalismo, anche con una difesa del popolo russo dalle accuse di Jules Michelet che lo considerava barbarico e senza morale, cui Herzen ribatteva che «la comunità rurale aveva salvato l’uomo del popolo dalla barbarie mongola e dallo zarismo civilizzatore, dai proprietari verniciati all’europea e dalla burocrazia tedesca», aggiungendo che «gli slavi, attraverso i secoli, riuscirono a conservare la loro nazionalità, i loro costumi e la loro lingua», tanto che la Russia, «centro attorno al quale gravita il mondo slavo, potrebbe essere il seme di questa cristallizzazione».
Mondo slavo, religione, nazionalità: è su questa triade che si confrontano le prese di posizione, distribuite tra i due fronti anche con acceso manicheismo. È il caso dello scrittore Ivan S. Turgenev, tra le maggiori presenze letterarie nel dibattito, risoluto occidentalista, che considerava «la razza slava uno dei rami principali della stirpe indo–germanica», da qui il rifiuto di qualsivoglia «linea tra Russia e l’Europa occidentale». Le sue posizioni suscitarono in Fëdor M. Dostoevskij repliche senza sconti, sebbene Turgenev avesse fatto prestiti, a lui come a Tolstoj, per saldare debiti di gioco. Diventato con l’età un incendiario slavofilo, Dostoevskij asserì che Turgenev «ingiuriava la Russia e i russi in modo sconcio e orribile… e che noi avremmo dovuto strisciare davanti ai tedeschi… e che tutti i tentativi di russismo non sono che indecenze e scemenze». Forse non c’era da aspettarsi altro da lui, se solo pensiamo alla foga messianica con cui, nel Discorso su Puškin, facendo sua la visione paneuropeista di Turgenev ma capovolta in panslavista, invita «i russi futuri a riconciliare tutte le contraddizioni europee, di mostrare la soluzione all’angoscia europea nella universale tutto–unificante anima russa… secondo la legge evangelica di Cristo» – una missione che prevedeva anche la futura riconquista di Bisanzio, essendo la Russia sua legittima erede.
La Bisanzio bramata da Dostoevskij torna e ritorna di continuo nel dibattito. È la Bisanzio di una visione religiosa che lo stesso Dostoevskij farà esplodere nel romanzo I fratelli Karamazov (1880), è la Bisanzio di Costantino, del Cristianesimo ortodosso, del divorzio da Roma, un divorzio dalla Chiesa romana che Kireevskij, a metà Ottocento, bolla come «intellettualistica, scolastica, del diritto, della concatenazione logica dei concetti», cui quella ortodossa risponde con «l’integrità dello spirito, la costante tendenza alla purificazione della verità». Nikolaj Ja. Danielevkij, pochi anni dopo, a rafforzamento delle teorie di Kireevskij, sosterrà che «i russi, con la maggioranza dei popoli slavi e con i greci, hanno avuto lo storico destino d’essere i principali custodi dell’Ortodossia, e in questo modo sono stati i detentori di quell’alto onere che fu d’Israele e Bisanzio, d’essere popoli eletti da Dio». Kostantin N. Leont’ev, nel 1875, dedicherà così il suo saggio di maggiore notorietà a Bizantinismo e Mondo Slavo, dove lamenta «l’impreparazione» con cui il primo era stato accolto in Russia, ma gli riconosce quella che fu «la forza di sopportare il giogo tataro, a dimostrazione che la Rus’ di Mosca non era più la disunita e lacerata Rus’ del passato»; e celebrando il Cristianesimo bizantino in quanto unica vera forma di spiritualità cristiana, Leont’ev ne esalta «l’influsso sull’autocrazia di Pietro» insieme ai «tratti ben chiari anche nella sfera artistica ed estetica in generale: le mode, gli usi, i gusti, l’architettura, l’arredamento».
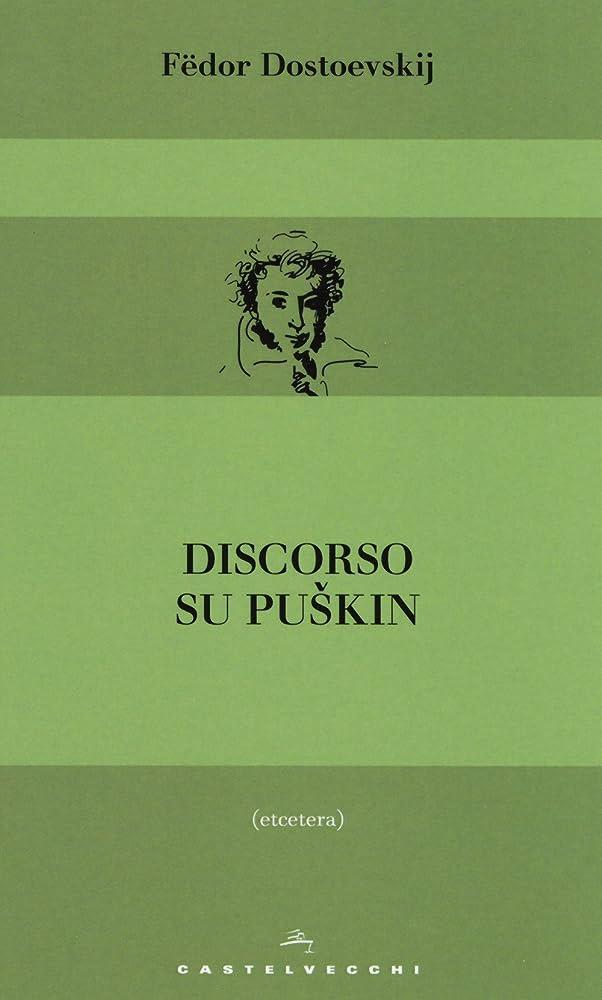
I «tratti ben chiari» dell’arte di matrice bizantina saranno al centro, nel primo Novecento, degli studi di Pavel A. Florenskij – definito da Piovesana «un genio in tanti campi dello scibile». Il sacerdote matematico teologo filosofo e critico d’arte Florenskij, maestro nel «sapere integrale» propugnato da Solov’ëv, dedicherà importanti saggi alle arti (si vedano la Teoria della prospettiva rovesciata e Il rito ortodosso come sintesi delle arti), sempre integrandole in una visione teoretica teologica su cui Bisanzio continua a insufflare la sua voce.
La “voce bizantina” non viene ovviamente ascoltata da molti pensatori, filosofi e letterati russi tra quanti Piovesana raduna sotto l’ampia cupola del «pensiero filosofico». A quelli sinora richiamati molti altri andrebbero aggiunti, di idee differenti, sia per quanto espressero i decenni dell’inverno bolscevico, da molti considerato in continuità anch’esso con la tradizione del despotismo zarista, sia per i tempi a noi più vicini, ancora impregnati di un’eredità cesaropapista che risalirebbe a fonti bizantine. Ma qui non c’è spazio e non è nelle mie capacità addentrarmi in approfondimenti storico–filologici come quelli suggeritimi dall’amico studioso di civiltà bizantina Paolo Cesaretti, che ringrazio dei preziosi consigli. Troppa la varietà degli autori e troppo complessi i temi, peraltro controversi tra gli stessi studiosi (Piovesana fa notare tra l’altro che Toynbee giudicava «l’assolutismo un retaggio di Bisanzio, ma si tratta di una valutazione che bizantinisti come Obolensky criticano severamente»). In ogni caso è innegabile il ruolo centrale ricoperto dai tempi lunghi, anzi lunghissimi, della “memoria bizantina” nel dibattito moderno, come se questo fosse ancora in qualche misura un confronto tra Prima e Terza Roma (ossia Mosca, mentre la seconda è appunto Bisanzio–Costantinopoli).
L’intricata questione della lunga memoria storica – la stessa che rende difficile ancora oggi pronunciarsi sui legittimi confini della Russia e delle diverse nazioni, etnie e tribù che occupano l’immenso spazio geografico slavo – non poteva che riaffiorare anche nel rilevante libro dell’émigré Wladimir Weidlé, La Russia assente e presente, Edifir, Firenze 2021, ed. or. Gallimard, Parigi 1949 (ringrazio l’amica russista Lucia Tonini per avermelo fatto conoscere). In esso Weidlé, critico d’arte e uomo di lettere niente affatto slavofilo, «geniale storico della Russia» (Ettore Lo Gatto), offre interpretazioni articolate sull’inestinguibile dibattito Russia–Europa, e contestando certe visioni dicotomiche slavisti Vs occidentalisti, si spinge a illustrare nelle conclusioni quelli che ritiene essere dei caratteri dell’«anima russa, modellata da nove secoli di storia». Sono i nove secoli che ci fanno risalire alle origini dello «Stato russo, che si formò grazie a un gruppo di variaghi, guerrieri commercianti scandinavi» che aprirono «la celebre via fluviale che dal mar Baltico conduceva a Bisanzio», sulla cui linea sorgerà nel secolo IX la Rus’ di Kiev, governata da «variaghi, chiamati dai greci con un termine di origine incerta, Rus’, che ha portato successivamente alla formazione delle parole Russia e russo». Ancora una volta, è sulla strada di Bisanzio che la Russia cerca i natali, i suoi stessi nomi di famiglia.
Leggendo le pagine di Weidlé ho pensato che alla Bisanzio da molti rivendicata in vario modo quale sorgente dell’«anima russa», si potrebbe attribuire un valore simile a quello che kokoro ha per i giapponesi, che in esso vedono riuniti i significati di anima cuore e mente quale manifestazione dello «spirito nipponico». Mi è parso insomma, per azzardato e suggestivo paragone tra queste due coniugazioni di pensiero filosofico e religioso, che Bisanzio e kokoro ricoprano una funzione analoga nel confronto moderno dei due grandi Paesi con l’Europa e l’Occidente.
Il mio è solo un impertinente paragone dettato da fascinazioni letterarie. Fascinazioni che non mi fanno dimenticare quanto Bisanzio (quale Bisanzio?) possa pure trasformarsi da sogno mitologico in incubo esperienziale. Penso alle pagine scritte da Josif Brodskij durante un suo soggiorno a Istanbul nel 1985, tredici anni dopo l’esilio da Leningrado, pagine cui dà il titolo Fuga da Bisanzio (il saggio è raccolto nel libro che riporta lo stesso titolo, Adelphi, Milano 1987). Brodskij non fa quasi richiamo al dibattito storico sul confronto Russia–Europa. Nel suo saggio sfodera tuttavia severe accuse alla città che ha avuto «desiderio o pulsione subconscia» di visitare. «Vi sono luoghi in cui la storia è inevitabile» scrive. «Luoghi in cui la geografia provoca la storia. Uno è Istanbul, alias Costantinopoli, alias Bisanzio». La «storia provocata» da Bisanzio viene quindi setacciata lungo pagine che, guidate da risentimento più che comprensibile, ne trattano le vicende fondative, la figura di Costantino, gli sviluppi dottrinari bizantini, il «divorzio da Roma» e infine la migrazione a nord, verso la Russia. «Dove poteva mai nascondersi la Rus’, data la sua posizione geografica, per sfuggire a Bisanzio? Non soltanto la Rus’ di Kiev, ma anche la Rus’ di Mosca, e poi tutto il resto, nello spazio compreso tra il Donez e gli Urali… Non c’era scampo per la Rus’ di fronte all’invadenza di Bisanzio – così come non c’era scampo per l’Ovest di fronte all’invadenza di Roma… Dalle mani di Bisanzio la Rus’ ricevette, o prese, di tutto». Brodskij non ci dice in che cosa consista esattamente tale eredità giunta sino al Paese dove è nato in tempi sciagurati e che sarà costretto ad abbandonare. Ma attirandoci nelle sue spire inquisitorie che dalla Istanbul contemporanea si avvolgono all’indietro, in una storia «anteriore alla dominazione turca», ce lo fa intendere, purtroppo: per Brodskij l’eredità di Bisanzio è anche «il delirio e l’orrore dell’Est».
Leggi anche:
Bruno Pedretti | Europe d’Oriente 1 | Il Giappone di Gino Kirill Piovesana
In copertina foto di Leonid Lazarev, Untitled, Moscow, 1957.









