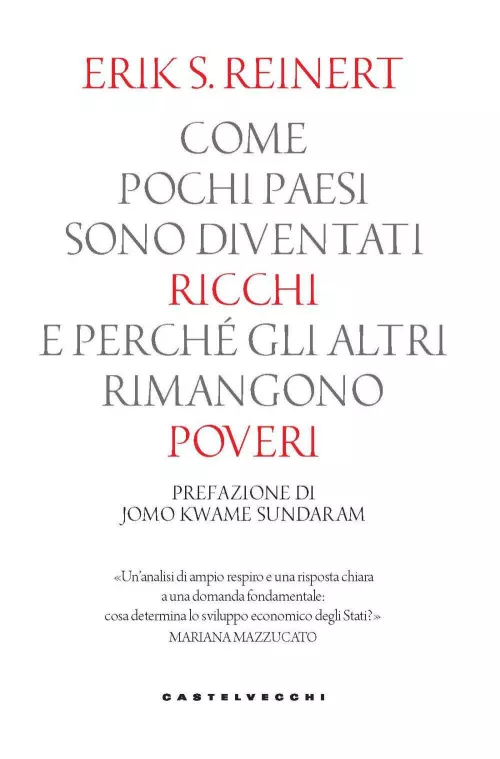Perché alcuni Paesi sono diventati ricchi e altri no?
Cosa spiega il successo delle nazioni? Perché alcuni Paesi sono diventati ricchi e altri no? E perché il primo è un piccolo gruppo, e il secondo è invece ancora numeroso? E come mai nel gruppo dei poveri ci sono Paesi incredibilmente ricchi di risorse naturali e materie prime? Risponde a queste domande semplici, che potrebbero persino apparire ingenue, il libro di Erik S. Reinert Come pochi paesi sono diventati ricchi e perché gli altri rimangono poveri (Castelvecchi, 2023), scritto nel 2007 e di recente ripubblicato con una introduzione aggiornata: una cavalcata continua e parallela nella storia (non solo) economica e nel pensiero (non solo) economico. Il cattivo della storia è chiaramente delineato: che si chiami “Washington consensus”, egemonia neoliberista, individualismo metodologico, insomma quella evoluzione dell’ultimo pezzo del Novecento il cui risultato è stato – parole di Reinert – “la perdita di due importanti dimensioni: il tempo (storia) e lo spazio (geografia)”. In che senso la teoria economica ha perso il riferimento alla storia e alla geografia, cioè alla realtà? E allo stesso tempo come può essere accaduto che una teoria così colpevole di essere fuori dal mondo ha causato tanti danni nel mondo reale?
Reinert è un economista norvegese di nascita (1949) ma cosmopolita per formazione ed esperienza. La sua formazione iniziale avviene alla Harvard Business School, e i suoi primi passi sono da imprenditore – in Italia, peraltro. Ma la domanda dalla quale scaturiscono le 425 pagine del libro si era affacciata nella sua mente molto prima, durante una vacanza da liceale, affacciato su una discarica di rifiuti di Lima con vicina baraccopoli, ospite di una organizzazione per lo sviluppo della comunità peruviana: “Perché sono così poveri?”. Per inoltrarsi nelle possibili risposte, si ancora al metodo appreso alla Harvard Business School, basato sui casi di studio: “una tradizione economica alternativa, ormai defunta, che si è mantenuta più vicina all’albero della vita reale di quanto non faccia l’economia odierna” (p. 63). Seconda informazione biografica rilevante: lo stesso Reinert ha girato il mondo come consulente di imprese, istituzioni, organizzazioni della società civile, governi dei paesi in via di sviluppo. Come un giornalista d’altri tempi, ha usato le suole delle scarpe. Terza precisazione a questo punto d’obbligo: Reinert è un accademico, conosce la teoria economica e la storia del pensiero economico, cita autori di moltissimi Paesi ed epoche – ben presenti gli italiani, dal Rinascimento in poi. È anche un bibliofilo, dunque ha scovato testi che pochi hanno letto, anche dalle bancarelle e dai tomi destinati al macero (leggendo il suo libro viene una fortissima voglia di fare un giro nella sua biblioteca). Però non disdegna le citazioni pop, dai Peanuts (usa una striscia di Schultz per criticare le teorie economiche liberoscambiste: “le ipotesi sbagliate generano domande sbagliate”) alla famosa massima di Mark Twain “quando tutto ciò che hai è un martello, tutti i problemi iniziano a sembrare chiodi”.
Il fatto è che la storia del martello unico e dei chiodi fittizi non è iniziata con Milton Friedman e con la grande restaurazione del pensiero economico dagli anni ’70 in poi. I due approcci alternativi, nel racconto di Reinert, cominciano ben prima, da David Ricardo e dalla sua teoria dei vantaggi comparati nel commercio internazionale; a una impostazione che propone il libero commercio internazionale come ricetta universale, grazie alla quale ciascuna nazione si specializzerà in quel che sa fare meglio, Reinert contrappone un altro approccio, che si può riassumere così: conta quel che un Paese produce, e le sue caratteristiche, in particolare: attività soggette a rendimenti di scala crescenti (uguale: diventare ricchi), o rendimenti decrescenti (uguale: specializzarsi nell’essere poveri). Su piano teorico, il libro contrappone al filone che parte da Ricardo quello che parte dall’economista tedesco Friedrich List (ma che risale anche agli italiani Giovanni Botero e Antonio Serra, diciassettesimo secolo) e culmina con Schumpeter. Sul piano storico, la ricostruzione di Reinert contrappone quel che i Paesi industrializzati dicono oggi agli altri di fare – aprire le frontiere, combattere il protezionismo – con quello che hanno fatto – ossia proteggere la loro industria manifatturiera nascente, portatrice di innovazione tecnologica e rendimenti crescenti, che portano a cicliche “esplosioni di produttività”. Tale contrapposizione ritorna, riproposta anche nella discussione sulla ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, con il piano Marshall che alla fine sposa la visione “empirica”, o di quello che Reinert chiama “il canone alternativo”, o eterodosso.

Finché i Paesi che sono diventati ricchi anche grazie alle pratiche protezioniste non hanno imposto a tutti gli altri un modello opposto. Condannandoli spesso a specializzarsi in povertà. Questa condanna sarebbe l’esito comune di due opposti determinismi economici, quello liberista e quello marxista – qui il libro non approfondisce molto, poiché il suo principale bersaglio polemico è il liberismo economico, ma chiarisce che è ugualmente distante dalla teoria economica marxista.
Va precisato che Reinert ammette che nessuna teoria economica è così sprovveduta da negare il ruolo dell’innovazione tecnologica, dei contesti istituzionali, e della complessità della società: solo, li considerano fattori esogeni e non parte dell’analisi. “Nessuno mette in dubbio che le innovazioni e l’apprendimento creino crescita economica, ma da Adam Smith questo aspetto dell’economia è stato esternalizzato. Si tende a ritenere che il cambiamento tecnologico e le nuove innovazioni scendano come manna dal cielo, gratis e a disposizione di tutti”. (p. 208). Mentre, questa è la ricetta dell’autore, richiedono di essere favoriti, accuditi, nutriti.
Una delle critiche a suo tempo portata al libro di Reinert viene da un commentatore economico, Martin Wolf. Lo stesso Wolf è peraltro “usato” nel libro stesso, che cita una sua frase da un articolo del 2003 nel quale l’editorialista del Financial Times scriveva: “Il divario tra paesi ricchi e paesi poveri riflette il successo di quei paesi che hanno abbracciato il capitalismo e il fallimento di quelli che non lo hanno fatto”. Ha ragione, dice Reinert, se per capitalismo intendiamo il sistema di produzione, nel quale imprese, Stato e innovazione hanno un ruolo storicamente essenziale; ha torto, se, con una visione da “guerra fredda”, centriamo la definizione sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sul solo operare delle forze di mercato. In una recensione alla prima edizione, sul Financial Times, (21 luglio 2007), Wolf non rispondeva sulla definizione di capitalismo, ma suggeriva di prendere il libro molto sul serio per la profondità della ricerca che c’è alla base, ma sosteneva che proprio i fatti storici portati da Reinert a sostegno della sua tesi in realtà non la dimostrano affatto: poiché i Paesi che hanno avuto successo con le pratiche di protezione dell’industria nascente, che si parli degli Usa nel passato o della Cina oggi, hanno caratteristiche specifiche, come l’essere molto vasti, e con un grande mercato interno; al contrario di Paesi poveri dell’Africa o dell’Asia al quale oggi le ricette eterodosse del libro si potrebbero rivolgere.
Due notazioni, in chiusura, possono essere utili nel confrontarsi con una lettura che è ricchissima di informazioni e riferimenti, e anche piacevole nello stile. La prima è temporale: dal 2007 a oggi ci separa un intero mondo. La crisi finanziaria, la pandemia, il pieno dispiegarsi della rivoluzione digitale. L’aggiornamento insertio nell’introduzione all’edizione del 2023 è necessariamente breve – anche se preoccupante, aprendo a un paragone storico tra i nostri anni Venti e gli anni Trenta del Novecento. Quanto all’innovazione tecnologica digitale, non è chiaro se questa venga considerata come una conferma dello stesso paradigma (l’importanza della “democrazia manifatturiera” nello sviluppo delle nazioni) o se sia essa stessa un cambio di paradigma
La seconda notazione è invece di tipo istituzionale. Reinert ribadisce a ogni piè sospinto l’importanza del contesto, degli Stati, della politica, della cultura delle popolazioni; ma tralascia di considerare che, perché uno Stato protegga (bene) la sua industria, questo Stato deve esistere, le istituzioni devono essere almeno un po’ funzionanti e trasparenti, la corruzione, se non assente, possa almeno essere combattuta. Per l’Italia, a suo tempo, Pasquale Saraceno usava dire che è difficile separare effetto e causa, e le istituzioni possono crescere con lo sviluppo industriale: possibile che nella sua sconfinata biblioteca Reinert possa trovare buoni spunti su questo aspetto non trascurabile per l’efficacia delle sue ricette.