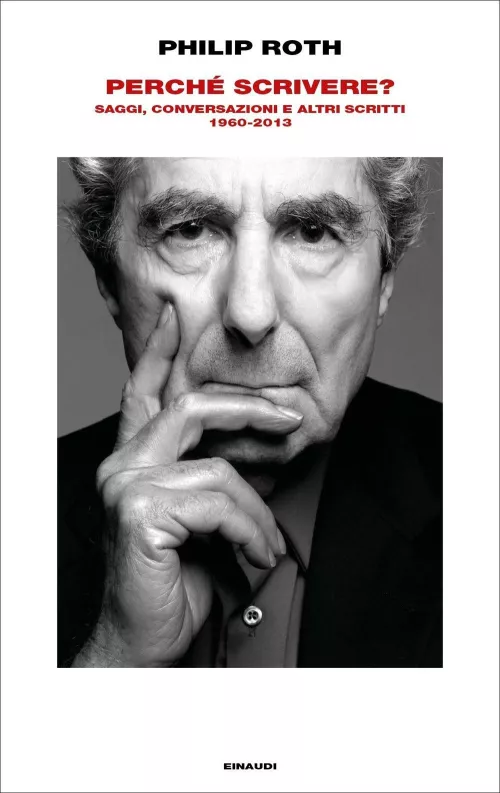1960 - 2013 / Philip Roth, Perché scrivere?
Davanti a un volume di «collected nonfiction» (questo il sottotitolo originale), riesce difficile abbozzare un compendio, sia pure approssimativo, tanto più che gli scritti raccolti in Perché scrivere? coprono un arco temporale molto vasto, che va dal 1960 al 2013, l’anno successivo a quello del fatidico annuncio di non scrivere più. In questo libro ricchissimo e a suo modo labirintico, l’unica cosa possibile è perdersi, o magari provare a tracciare dei percorsi particolari, alla ricerca di una risposta a quell’interrogativo che campeggia in copertina. Occorre dirlo subito: la risposta, per lo meno in termini diretti, non c’è, perché Philip Roth non fa che girare attorno al nucleo della sua e della altrui scrittura, in brevi saggi, in conversazioni straordinarie con altri scrittori o in vari scritti d’occasione.
In questo itinerario, che naturalmente ogni lettore può percorrere secondo le proprie inclinazioni e i propri interessi, si incontrano delle pietre miliari, dei landmarks essenziali e inaggirabili, a cominciare da uno dei testi più belli mai scritti dallo scrittore di Newark, giustamente collocato in apertura: «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno» ovvero, guardando Kafka. Vi si mette in scena un Franz Kafka che, invece di morire nel 1924 (è proprio da una fotografia che lo ritrae in quell’anno che ha inizio lo scritto), emigra in America nel 1938 per poi diventare, quattro anni dopo, l’insegnante di ebraico dello stesso Roth. Si fidanzerà con la zia del piccolo Philip ma, come sempre, interromperà improvvisamente il fidanzamento e infine morirà nel 1953, a settant’anni. In questo saggio narrativo del 1973, una specie di autofiction per interposta persona, non si dà soltanto una lettura (nonché una controbiografia) di Kafka, ma compaiono anche alcuni motivi essenziali per lo stesso Roth: il rapporto con il femminile, la finzione autobiografica (altrove parla di «finta autobiografia, autobiografia ipotetica o autobiografia spudoratamente esagerata»), l’ebraismo.
Ed è proprio l’ebraismo uno dei filoni di maggiore portata dell’intero libro. Il tema viene declinato in vari modi: nei primi scritti degli anni Sessanta troviamo un Roth sulla difensiva, pronto a controbattere punto per punto alle incredibili accuse che gli arrivano da alcuni ambienti ebraici – il suo principale accusatore è il rabbino David Seligson –, che arrivano ad addebitargli una sorta di antisemitismo, perché i suoi testi diffonderebbero «un'immagine distorta» dei valori ebraici. In sostanza, Roth non si è mai adeguato agli stereotipi, non ha mai dipinto gli ebrei americani come persone necessariamente buone e pie né come vittime: li ha ritratti semplicemente come uomini, nel bene e nel male, senza alcuna idealizzazione. Del resto, era ben diversa la condizione degli ebrei americani da quella vissuta dai loro correligionari in Europa: «La disparità fra la dimensione tragica della vita ebraica in Europa e la realtà della nostra vita quotidiana di ebrei nel New Jersey mi dava da pensare». L’essere ebreo senza tragedie che pesino sulla sua storia familiare, appunto, toglie a Roth medesimo molti scrupoli nella rappresentazione dell’ebreo americano, il che gli consente di pubblicare lo “scandaloso” Lamento di Portnoy. Con quel romanzo, ovviamente, le polemiche non fecero che amplificarsi, per poi attenuarsi negli anni Settanta, tanto che nel 1981, in una intervista con Alain Finkielkraut lo scrittore le liquidò in maniera perentoria: «quando scrivo un romanzo il mio compito non è correre in soccorso degli ebrei sofferenti».
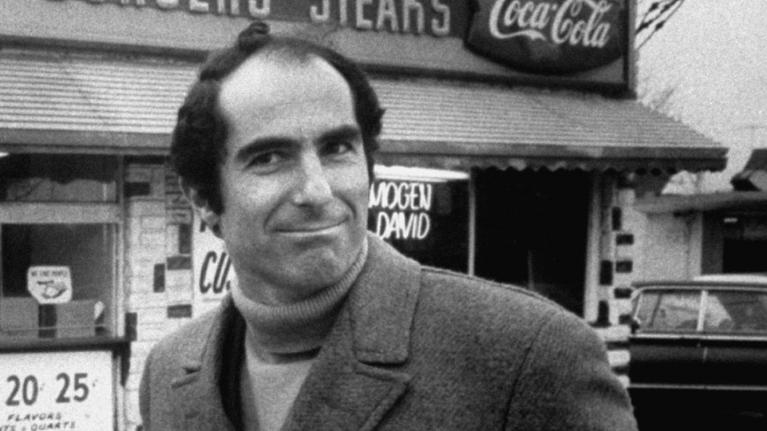
Oltre che sul piano della dimensione familiare, il confronto con l’ebraismo passa soprattutto, per alcuni aspetti, per il confronto con gli scrittori ebrei (sono notevoli le due interviste a Primo Levi e ad Aharon Appelfeld), in particolare con il venerato Bellow, quel «Bosch americano, [...] ottimista e non predicatorio» verso il quale non esita a dichiarare apertamente il proprio debito.
Due grandi linee, dunque, attraversano il libro, intersecandosi incessantemente. Una, lo si è appena mostrato, è quella dell’ebraismo, l’altra è quella dell’essere americano, riassunta nella semplice definizione che Roth fornì di sé in un discorso del 2002: «Un ebreo di Newark? Chiamatemi così e non avrò niente da obiettare». Un’identità duplice, dunque, perché l’essere ebreo e l’essere americano sono per Roth due realtà inscindibili. Non a caso sono numerose le pagine nelle quali lo scrittore si interroga non tanto sull’identità americana, ché sarebbe impresa pressoché impossibile, quanto sull’identità dello scrittore americano. In Scrivere narrativa americana si legge: «lo scrittore americano a metà del ventesimo secolo incontra grandi difficoltà a comprendere, descrivere e poi rendere credibile la realtà americana». Questa difficoltà nasce dalla necessità, per il romanziere americano, di impegnarsi in un corpo a corpo con la realtà circostante. Dice del resto in un’intervista: «Quando cominci, vai in cerca di ciò che oppone resistenza. Vai in cerca di guai».
E naturalmente questo corpo a corpo si conduce all’interno della lingua, perché l’identità americana è, per Roth (e per uno scrittore in generale), innanzitutto un'identità linguistica. In una pagina fondamentale del libro, contenuta in un altro discorso del 1997 intitolato Yiddish/inglese, Roth rivendica con forza l’unico radicamento possibile per lui, ormai lontano, per questioni anagrafiche, da quello nello yiddish, ancora vitale per autori come Appelfeld e Bellow: «Ovviamente, per uno con la mia biografia, l’inglese ha cessato da tempo di essere un ulteriore incidente inatteso accaduto agli ebrei. È l’inglese, e solo l’inglese, a tenere insieme il mio mondo. Se non fosse per l’inglese, sarei muto. Se ne venissi privato, sprofonderei in una completa oscurità mentale». E ancora: «La vita è l’inglese. Io sono un uomo fatto di inglese», quella «madrelingua per mezzo della quale cerco di trasmettere al mondo le mie fantasie di realtà – le mie sbrigliate allucinazioni travestite da romanzi realistici».
L’identità dell’ebreo di Newark si concretizza perciò più che mai nella scrittura, la quale costituisce, nella riflessione che suscita nell’autore, il basso continuo dell’intero libro. È quella del romanziere («cosa che io sono ben più di quanto sia ebreo», puntualizza), infatti, la vera immagine in cui si riconosce. Le stesse conversazioni con altri scrittori – i già citati Appelfeld e Levi, poi Isaac Bashevis Singer, Edna O’Brien e Ivan Klíma, per dirne solo alcuni – si configurano come spazi di riflessione, chiacchiere di bottega (come recita il titolo della seconda parte del libro che le ospita), momenti di una messa a fuoco della propria collocazione rispetto al «mondo scritto» e alla società. Di vitale importanza sembra in particolare il lungo dialogo con lo scrittore ceco (nei primi anni Settanta, Roth prese l’abitudine di compiere un viaggio a Praga ogni primavera), cui Roth assegna il ruolo di proprio «principale istruttore di realtà». Benché scritte nel 1990, a ridosso della fine del socialismo reale, le considerazioni che scaturiscono dalla conversazione con Klíma sembrano non aver perso la loro validità: «In una cultura della censura, in cui tutti vivono una doppia vita – una di menzogna e una di verità –, la letteratura diventa un salvagente, il vestigio di verità a cui la gente si aggrappa. Credo però che anche in una cultura come la mia, in cui nulla viene censurato ma dove i mass media ci inondano di vacue falsificazioni delle questioni umane, la letteratura seria sia un salvagente, anche se la società sembra non rendersene molto conto». Basterà sostituire l’espressione mass media con social media e avremo un quadro piuttosto preciso dell’oggi.
Dunque, se le condizioni in cui si muove la letteratura sono queste, perché scrivere? Le risposte di Roth, che, come si è detto, non sono mai esplicite, sono molteplici. In primo luogo si può dire che la narrativa – termine al quale lo scrittore aggiunge spesso l’aggettivo realistica, con un tono che sa di rivendicazione etica – assume una dimensione più o meno ludica, giacché «Scrivere romanzi è come giocare a “facciamo che”». Ma proprio in quel facciamo che, in quel prospettare orizzonti diversi, risiede in sostanza l’autentica funzione etico-politica della letteratura: «Il mondo della finzione ci libera dalle gabbie in cui la società rinchiude i sentimenti; una delle facoltà dell'arte è permettere tanto allo scrittore quanto al lettore di reagire all’esperienza in modi non sempre contemplabili nella quotidianità; o, se pure contemplabili, non sempre possibili, o gestibili, o legali, o consigliabili, o anche solo utili alla sopravvivenza». Ecco perché scrivere; e non è poco.