Pontiggia lettore di mestiere
Del suo lavoro di consulente editoriale, un'esperienza che attraversa le giornate di Giuseppe Pontiggia per quattro decenni (dalla metà degli anni Sessanta fino al 2003, l'anno della scomparsa), lo scrittore ha offerto un'immagine laconica e pensosa molto presto, in un fulminante apologo, di trasparente intonazione autobiografica, che Enzo Siciliano reputava fra i racconti più esemplari del Novecento italiano.
Pubblicata nel '71, la meditazione in forma di aneddoto ha per titolo Lettore di casa editrice: qualche anno dopo (nel '79) Pontiggia deciderà di includere il racconto nella terza parte di La morte in banca, dove campeggia insieme ad altre istantanee dello spaesamento e dell'inquietudine. Il caso prospettato in Lettore di casa editrice ha per baricentro un equivoco, che in Pontiggia è sempre un formidabile carburante narrativo: il protagonista, preso dalla stanchezza, scambia Dostoevskij per un esordiente e legge Delitto e castigo con matita rossa e blu, distillando un sofferto parere di rifiuto («... molti errori, molta enfasi. È un autore che va tenuto d'occhio per il futuro»). Pontiggia sorride dell'alienazione, che è una minaccia forse in agguato dentro ogni mestiere – anche intellettuale – sospeso fra la ripetitività della routine e un ritmo di applicazione forsennato: preso d'assedio da una moltitudine di troppe sollecitazioni frastornanti e discordanti, anche un lettore professionalmente solido e attrezzato può talora andare incontro a qualche occasionale passaggio a vuoto, o magari smarrirsi nella confusione fra le pagine scritte e la concretezza del mondo, più o meno alla maniera in cui un esperto confezionatore di radiodrammi – nel bellissimo e pirandelliano La zia Julia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa (1977) – perde l'orientamento nella foresta delle proprie macchinazioni fantastiche.
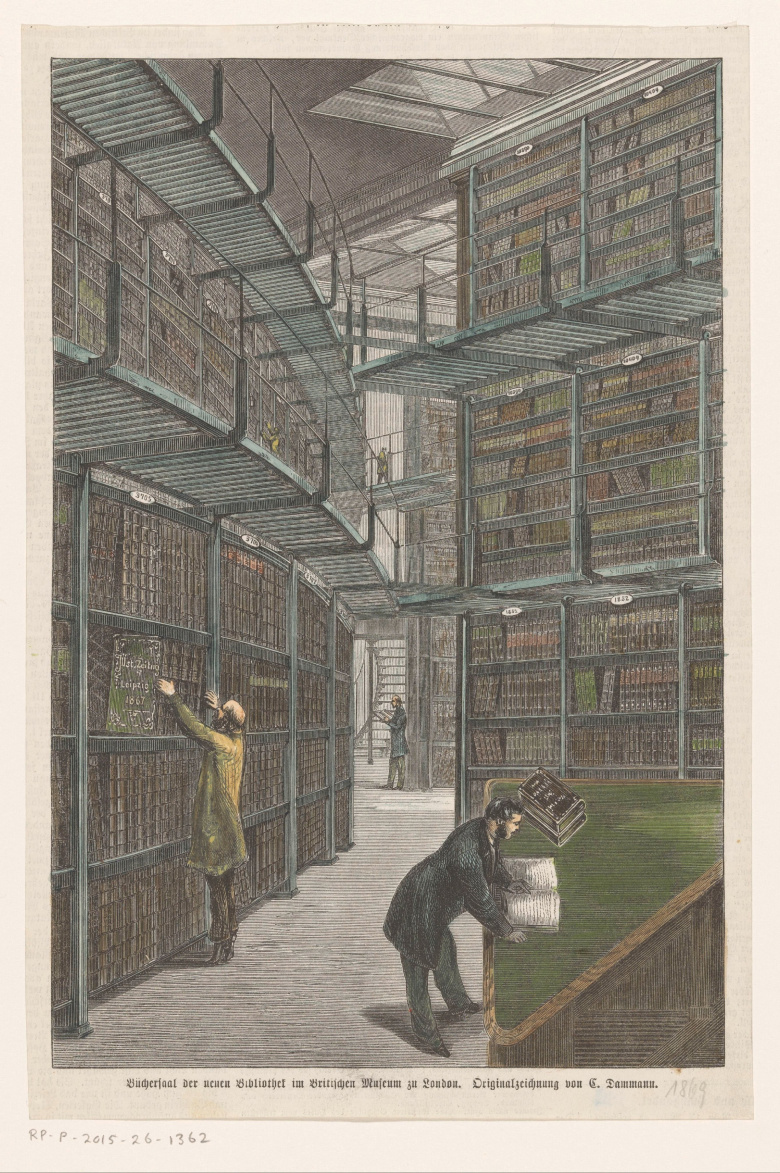
Ma il fatto è che il personaggio di Pontiggia – per ogni verso modellato sullo scrittore, nei termini di un autoritratto inciso a puntasecca, sottilmente caricaturale – applica nel racconto al capolavoro di Dostoevskij le risorse implicite nello straniamento, la vecchia strategia di indagine teorizzata a inizio Novecento da Viktor Šklovskij e dai formalisti russi. Il testo da esaminare viene anzitutto liberato da inutili gravami di idee precostituite, spogliato di orpelli e ricondotto per così dire alla sua datità fenomenica: letto, provato, "saggiato", idealmente alla maniera in cui nell'antica Grecia un saggiatore di professione (il cosiddetto dokimastès) procedeva a verificare, sulla pubblica piazza, la presenza del metallo pregiato all'interno di una moneta, in sostanza distinguendo la lucentezza dell'oro dalla volgare falsità del peltro.
«Alla fine si perde il senso delle proporzioni», lamenta il protagonista di Lettore di casa editrice, ma la confessione va letta nella luce, depistante e paradossale, tipicamente cara a Pontiggia: è vantaggioso perdere il senso di gerarchie bloccate e sclerotizzate, ogni volta che i testi vengono auscultati, messi alla prova, soppesati e centrifugati. Che sorprendente effetto produrranno, sottoposti al vaglio di questo attraversamento disinibito, privo in toto di pregiudizi, persino autori celebri del passato, schermati e opacizzati in certi casi dal velo dell'abitudine, dalla pigrizia di un consenso tributato per stanchezza o per intervenuta convenzione? Con il respiro giocoso della malinconia, un consulente di casa editrice può anche illudersi che «ci si abitua anche ai testi scadenti», ma l'affermazione suona falsa perché le cose stanno esattamente all'opposto, tanto che il discorso è sigillato nel racconto di Pontiggia da un'immediata ritrattazione: « ... non tema che si diventi indulgenti. Semmai capita il contrario».
«Giudicare i libri senza leggerli. Sembra una magia, mentre è solo una abitudine» scriveva Pontiggia, nel '91, in una pagina de Le sabbie immobili (all'ultimo punto di un esilarante Decalogo della società letteraria). Ma Pontiggia sapeva leggere e giudicare insieme, leggeva correndo dritto al punto, come si favoleggia riuscissero a fare – con misteriose tecniche di attraversamento veloce, orientandosi fra blocchi di pagine e compagini testuali elefantiache – i lettori della prima età moderna. Il suo giudizio arriva calibrato, sempre chirurgico, ricondotto con franchezza esplicita a una misura di predilezioni personali e qualche volta di intolleranze epidermiche; evita il vizio dell'indulgenza, che è confusione e mistificazione (sfiducia nelle possibilità del testo letterario in quanto organismo conoscitivo), ma non scade mai nell'intemperanza del dileggio, che può colorarsi di protervia. Tramata di ironia e misura, la brevitas di Pontiggia è anche un'arte dello sfumato: riflessa nell'impegno nervoso di diagnosticare, fare sintesi, condensare la verità di un autore e di un'opera in una scheda segnaletica fulminea o una vertiginosa immagine caratterizzante.
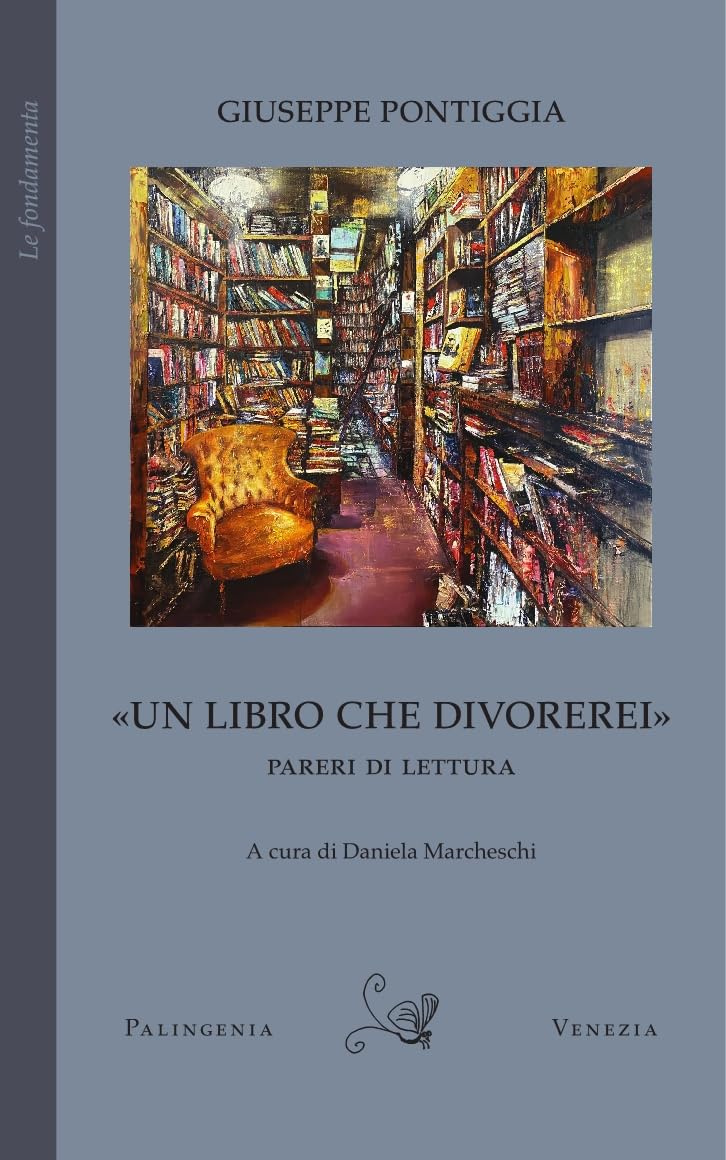
Si assapora questa splendida galleria di schede di lettura – «Un libro che divorerei». Pareri di lettura (Palingenia, Venezia 2024) – ad ogni pagina con il divertimento assoluto di cui scrive la curatrice del volume, Daniela Marcheschi, nei termini esatti e felicissimi di «un libro di critica che si legge come un romanzo di romanzi, quasi al modo di Vite di uomini non illustri». Una selezione di 186 pareri editoriali stesi da Pontiggia per i suoi due committenti editoriali, Adelphi e Mondadori, trascelti in una messe di altre centinaia di schede da lui prodotte nel corso degli anni e dei decenni. L'ordine per cui opta il volume è strettamente alfabetico (da Afanassiev a Zanzotto), insomma chi legge il libro può cominciare da un punto qualsiasi, più o meno a caso, ad apertura estemporanea di pagina. Forse può essere tentato di farlo persino incominciando dalla fine, da una esilarante rassegna di giudizi negativi (sul conto di bersagli lasciati giudiziosamente anonimi, perché non avrebbe senso incrudelire sulle velleità degli inermi). Proviamo a trascrivere una piccola ed esplicativa campionatura in corsa: «è il tipico romanzo che diverte chi lo scrive e annoia chi lo legge, come le fotografie fatte in vacanza e proiettate per gli amici in lugubri serate»; «un testo livido, tetro, opaco, in cui le frustrazioni del protagonista diventano subito del lettore ... forse non ha capito che uno che acquista un libro non lo fa per espiare»; «i veri naïfs, come dice Scheiwiller, sono quelli che comprano i loro quadri e non direi che questo vada acquistato. Ha preso troppo alla lettera Wilde quando diceva che l'arte è esagerazione»; «un giovane viziato da rifiuti editoriali troppo eufemistici per la sua immodestia (dice di non avere imparato niente dal "signor Hemingway": bisognerebbe rispondergli che, dopo averlo letto, nessuno ne dubita)».
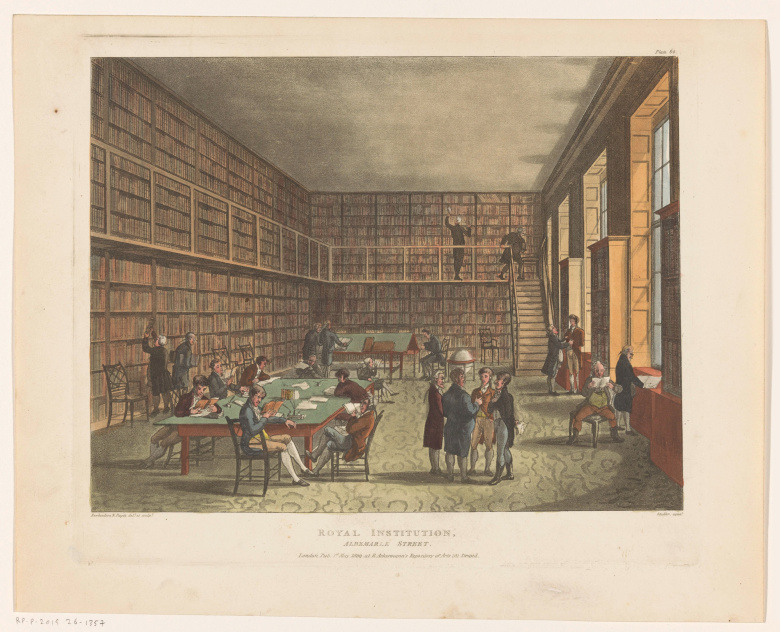
Niente dileggio, ma – questo sì – qualche volta magistrale sarcasmo (che è sempre il riflesso, nella sua matrice etimologica, di un "addentare" e un "mordere le carni"). Quando Pontiggia è di malumore – perché il testo sotto esame ha l'aspetto di una farragine, oppure di un ricalco, insomma di un composto squinternato – certe valutazioni si caricano di un divertimento accigliato, incline a un tono di staffilante riprovazione che evoca in filigrana (ma con più gelida e imperturbabile compostezza) le esilaranti requisitorie settecentesche di Giuseppe Baretti sulla "Frusta letteraria", contro ogni ipotesi di letteratura nutrita di chiacchiere e di tedio. Valga qui, a titolo di esempio, il giudizio negativo su un infelice Il basilisco di José Basile (parere steso per Adelphi):
Scritto con bella calligrafia e pathos molto signorile, sembra la sceneggiatura di un film di Visconti con la partecipazione dei nipotini di Von Stroheim. Non manca di pagine eleganti e preziose, ma ha il limite tipico di chi fa del distacco un mito: non riesce a conservarlo e così scivola nel ridicolo (con ufficiali esangui e smarriti che ascoltano in infermeria il Tristano e Isotta o mariti traditi che si consolano con la Nona). È un grande scrittore mancato, un ectoplasma di Broch, o, più probabilmente, di D'Annunzio, questo Monte di Pietà da cui gli scrittori italiani non riescono mai a riscattare i pegni.

«C'è chi ama l'oro finto, ma la cosa più preoccupante è che lo scambia per vero»: così Pontiggia sentenzia in margine a una disamina – datata 26 marzo 1987 – di La voglia di Pietro, un romanzo di Letizia Cella: l'aforisma è complicato da una specie di appendice in chiaroscuro (« ... questo pericolo, ma anche questa chance editoriale ... »). Conoscitore rispettoso dei meccanismi dell'industria editoriale, lo scrittore lombardo non prescinde mai da considerazioni di opportunità che investono il conto economico, la quadratura dei bilanci, l'elemento di una prudenziale sostenibilità della pubblicazione nel mare incognito del mercato librario. Non per nulla, uno dei vertici del ricorrente entusiasmo di Pontiggia coinvolge nel volume – letto, per conto di Adelphi, il 9 maggio 1991 – un capitale lavoro di un grande storico del libro nell'età moderna, il Robert Darnton di Édition et sédition:
Questo è uno di quei libri che vorrei comperare due volte (mi capita di desiderarlo, e a volte di farlo, quando trovo in catalogo certi libri che ho già), perché unisce il gusto della clandestinità al piacere della lettura, i rischi della sovversione al culto – privato, ma contemporaneamente anche pubblico – della provocazione. Una selva affascinante di autori, editori, librai ci offre un quadro che, non esagero, è esaltante: l'amore della avventura, il coraggio, il senso di una solidarietà ideale e concreta che spinge queste persone a unirsi in una rete sotterranea di rapporti è qualcosa di incomparabile con l'ottusità della moderna vetrina del libro. Qui il libro viene riscoperto nel suo valore inestimabile e nella sua ricchezza terribile e temibile. Questa è una di quelle opere che ho sognato che ci fossero, ma che ho sempre dubitato potessero esserci, per la vastità della materia e per la complessità delle intersezioni (erudite, moralistiche, politiche eccetera).
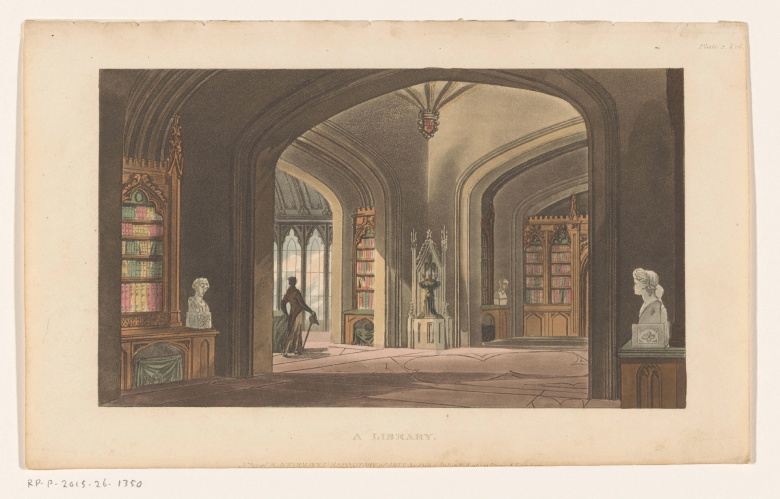
Fedele al gusto di questa compromissione con l'orizzonte cartografico della cultura e la fibrillante trama dell'universo umano, anche la voce di Pontiggia sembra immettere ogni volta il lettore in una prospettiva enciclopedica, con la stessa immediata «naturalezza» con cui Aldous Huxley – annota una volta, per Adelphi, a proposito di Oltre la baia del Messico – «passa dal visibile alla storia che c'è dietro, arricchendo il viaggio di sensazioni, immagini, riferimenti che lo stile rende vivificanti ... con un suo timbro inconfondibile, dove emozione visiva e riflessione si fondono in un suono puro». Cambiandosi vorticosamente d'abito, lo scrittore trascorre con agilità stupefacente nei suoi pareri dalla filosofia (lapidario, per Alexandre Kojève: «l'impressione di un nominalismo neoscolastico di impronta esistenzialistica») alla poesia italiana contemporanea (Piero Bigongiari, Andrea Zanzotto, Maurizio Cucchi, tre microsaggi compendiosi), dall'antropologia (il Mario Comincini di un Dossier sul lupo in Lombardia: «è un libro che, tanto per stare in argomento, io divorerei») alla politica (per il Winston Churchill di My Early Life: «di straordinaria efficacia, nella sua terrificante elementarità, nel suo terrificante cinismo ... sapido, gustoso, animato da una vitalità contagiosa»), con inserzioni e incursioni di infinito altro.
La molla dell'infinità curiosità implica in Pontiggia, autenticamente, l'ebbrezza di una fame onnivora: forse per questo – ma insieme per una riserva che coinvolge responsabilmente il piano della ricezione – la scheda editoriale sulle Poesie di Ceronetti recita: « è una poesia dove la carne, che compare ossessivamente, è fatta per togliere ogni appetito: liquida, ulcerosa, putrescente, ricorda la sensualità spettrale e sudata del manierismo pittorico lombardo nel periodo della Controriforma, con corpi nudi in torsione lungo le mura dei lazzaretti ... La qualità e, a tratti, la verità sono fuori discussione, però sono poesie che non mi piacerebbe uscissero da Adelphi sia per il significato che hanno sia per quello che verrebbero ad assumere (grazie anche agli inevitabili equivoci) per i lettori». In Pontiggia il segno, mai intermittente, di un'idea forte e civile di editoria e letteratura.
Leggi anche:
Daniela Marcheschi | Giuseppe Pontiggia e la traduzione
Gianmarco Gaspari | I tradimenti di Pontiggia
Diego Varini | Pontiggia, autopsia della verità









