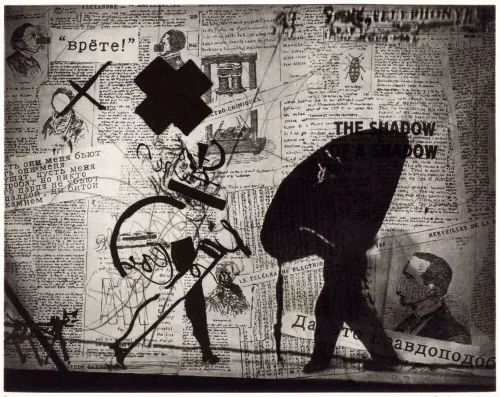Speciale
Scuola digitale
La storia dell’introduzione delle tecnologie digitali nella scuola italiana è fatta tutta o quasi di paradossi, nei modi, nei tempi, nelle convinzioni dei protagonisti. Un esercizio utile per non rimanerne intrappolati potrebbe allora essere quello di prescindere di netto dal quadro di realtà: fare “come se” la maggioranza delle classi disponessero di infrastrutture adeguate a utilizzare contenuti e strumenti digitali, gli insegnanti fossero formati e motivati a guidare il processo di innovazione, gli editori scolastici fossero a loro volta pronti e ben disposti ad assecondare il cambiamento e infine il quadro legislativo fosse chiaro, coerente, accompagnato da opportune azioni di sistema e soprattutto stabile.
Viceversa, per tacere del resto, la legislazione che obbliga al passaggio dal cartaceo al digitale si barcamena tra accelerazioni e frenate, tra l’aspirazione a una forte discontinuità (nella convinzione implicita che un’istituzione conservativa come la scuola non possa cambiare per un processo naturale) e la necessità di mediare con gli interessi degli editori, l’ostilità e l’inadeguatezza di una parte degli insegnanti, la mancanza delle risorse economiche indispensabili per sostenere il piano, l’incertezza negli obiettivi e negli strumenti. Intanto però di didattica digitale si dibatte moltissimo, e molte sono le sperimentazioni e i progetti speciali: la scuola italiana, anche per l’ambito delle tecnologie, è il regno delle splendide eccezioni, dei casi di studio da convegno; mentre sarebbe necessaria e urgente una fase di applicazione strutturale dell’innovazione: non solo per non disperdere le poche risorse disponibili in mille rivoli spesso senza esiti (e quasi mai documentati), ma anche perché la normalità è una delle poche armi utili a disinnescare il protagonismo naturale delle tecnologie, che inficia molte delle discussioni su questo argomento.
Dal digitale come fine al digitale come mezzo al servizio della didattica, come ulteriore strumento nella “cassetta degli attrezzi” dell’insegnante: avremo modo di ritornarci. Per adesso, tutta questa premessa serve solo a porre un assunto, che ha il valore di una petizione di fiducia: pur tra difficoltà, incoerenze e rallentamenti, si è avviato nella scuola un percorso in una direzione ormai tracciata. Ma qual è, per quanto si può capire oggi, questa direzione? Quale tipo di cambiamento asseconda e presuppone?
Le motivazioni che guidano l’introduzione dall’alto del digitale in classe sono, mi sembra, sostanzialmente quattro: diminuire il peso degli zaini; diminuire il costo dei libri; aggiornare la scuola a quel che accade fuori dalla scuola; rinnovare le pratiche didattiche. Tralasciando il primo punto, non centrale e anzi fuorviante in questo contesto, il secondo implica che il costo di produzione dei libri digitali sia in assoluto minore del costo di produzione dei libri cartacei. È un assunto solo parzialmente vero che sottende al tempo stesso il consueto ma non meno insidioso massimalismo rispetto alla nozione di “digitale”, dietro al quale può stare di tutto, dalla scheda in pdf alla simulazione interattiva.
Qui basti dire che, anche prescindendo dal CD-Rom o da altri supporti di distribuzione offline (e dunque a fronte del risparmio nella stampa, magazzino e distribuzione), la produzione di risorse digitali di qualità può avere costi molto elevati; che per un editore diciamo tradizionale le voci di spesa non comprendono soltanto lo sviluppo a regime, ma anche l’investimento necessario a mettere in piedi una nuova macchina progettuale, produttiva e organizzativa; che se queste risorse non vengono concepite in maniera obsoleta occorre un’infrastruttura che le accolga e dia loro un senso, la quale va creata e a sua volta mantenuta nel tempo (un tempo che nell’informatica, è noto, viaggia molto rapidamente); che infine, in questa fase di transizione nella quale non esistono veri standard, un produttore è costretto a destreggiarsi tra formati e devices che impongono spesso sviluppi e percorsi di testing differenziati.
Sono le prime cose che chi viene chiamato ad occuparsi di sviluppo digitale è costretto a spiegare al proprio editore, vittima spesso anch’egli del luogo comune secondo il quale “il digitale costa meno”. Se poi i contenuti multimediali-interattivi possono diventare in prospettiva una leva per la diversificazione dell’offerta scolastica, ad oggi per questo ambito un mercato non esiste, e il “digitale” viene solitamente offerto gratuitamente a chi adotta il libro tradizionale. Del resto, se venisse venduto, il pedaggio imposto dai distributori - 30% Apple e Amazon - e l’IVA al 22% anziché al 4%, difficilmente giustificherebbero un prezzo di vendita inferiore del 30% rispetto al cartaceo (come vuole il decreto sui libri digitali attualmente in vigore).
L’arretratezza tecnologica della scuola italiana è invece un dato di fatto incontestabile; però si può contestare che nella scuola debba valere la stessa idea di progresso che vige fuori dalla scuola. Giustamente Roberto Casati (Contro il colonialismo digitale) polemizza con quanti concepiscono l’innovazione come un processo automatico, da accettare senza discutere. La scuola italiana, nella logica dei modernizzatori, sarebbe inadeguata a instaurare un dialogo con i cosiddetti “nativi digitali”, ovvero con quei giovani, nati convenzionalmente dopo il 1996 o giù di lì, per i quali il digitale è una lingua madre, mentre per gli “immigrati” sarebbe una seconda lingua acquisita e compitata con difficoltà. Le tecnologie dunque non soltanto come strumento per migliorare il setting di studio, ma come modalità per attivare un processo di apprendimento con chi non conosce altro modo per comunicare. Qualcuno, ad alti livelli, ha spinto la fiducia in questa nuova umanità fino al punto di considerare i nativi digitali un veicolo di innovazione spontanea, portatori per così dire di un “contagio” che, se accolto e favorito, invaderà progressivamente la scuola e poi la stessa società, modernizzandola dal basso. È l’altro paradosso degli studenti che insegnano ai maestri: un luogo comune al quale si lega molta della diffidenza, o addirittura del rifiuto, che gli insegnanti nutrono nei confronti delle tecnologie, rispetto alle quali sono in qualche modo costretti o giustificati a provare un senso di inadeguatezza (nel comprenderle, nell’utilizzarle).
Eppure, come ormai da tempo è chiaro, i nativi digitali non esistono: sono una trovata mediatica che non ha riscontro nella realtà se non in un senso assai meccanico e autoreferenziale. Chiunque abbia a che fare con bambini e ragazzi anagraficamente nativi sa bene quanto siano lontani dall’avere con le tecnologie un rapporto maturo e consapevole. Al più si può parlare di una certa manualità, di un’empiria: non esiste alcuna competenza digitale innata da parte di chi è nato dopo una certa epoca, non c’è nessun cambiamento antropologico in corso. Al contrario, in un contesto così ricco di stimoli multimediali diventa vitale la capacità di svolgere ragionamenti complessi, di utilizzare puntualmente l’intelligenza critica: la scuola, anziché imparare dagli allievi, dovrebbe dunque rivendicare il proprio ruolo anche per l’ambito dei contenuti e degli strumenti digitali, in parte rafforzando le competenze di valutazione delle fonti e aggiornandole ai casi della rete, in parte introducendo in classe temi di web education: quali sono in internet i centri e i modelli di diffusione delle informazioni, come funzionano i meccanismi autoritativi che ne sono alla base, quali sono le forme di condivisione, quali i linguaggi.
Al fondo di molte delle iniziative ministeriali pare esserci la convinzione che le tecnologie siano portatrici di innovazione di per sé. Introduciamo in classe un tablet per ogni studente, una lavagna interattiva, delle risorse digitali, una connessione che permetta di accedere ad altre risorse open e magari a qualche forma di socialità di rete, ed ecco che la scuola si rinnova: l’importante è ridurre il ritardo rispetto al mondo circostante. Su temi così delicati, io credo che sarebbe lecito attendersi maggiore lucidità. Se si assolutizza il concetto della rispondenza tra fuori e dentro, la scuola a rigore serve a poco, perché non c’è niente di più allineato al mondo esterno del mondo stesso. Se invece la scuola deve continuare ad essere quel luogo “altro” nel quale accade qualcosa che ha a che fare con la didattica, allora non le si può chiedere, rispetto alle tecnologie, di arrendersi senza condizioni. L’introduzione di strumenti e tecnologie digitali in classe è auspicabile, ma bisogna essere in grado di mettere in gerarchia gli obiettivi e avere consapevolezza del contesto di riferimento.
L’ingresso del digitale, come di tutto il resto, deve essere subordinato a un progetto, al fondo del quale ci sarà la trasmissione e preservazione del paradigma culturale che ci rende quello che siamo (una tradizione, dunque), e anche, è lecito sperarlo, l’educazione a un dialogo critico con la tradizione e col mondo. Questo soprattutto se si intende il digitale in funzione non solo strumentale (e già sarebbe un obiettivo nobile e ambizioso), ma come leva per il rinnovamento dei metodi di insegnamento: un’altra, come si è detto, delle motivazioni a cui viene legata l’introduzione del digitale a scuola. È banale ma forse non inutile ripetere che l’innovazione nella didattica ha una curva diversa rispetto all’innovazione nella tecnologia. Si possono usare strumenti vecchi per fare cose nuove, e strumenti nuovi per fare cose vecchie. Proporre all’insegnante un testo in pdf da stampare o leggerlo su un eBook reader, mettere un test a risposta multipla sull’iPad o introdurre lo stesso contenuto in forma di gioco multimediale non significa necessariamente innovare la didattica. Ma un foglio e una penna sono sufficienti per impostare in classe un sofisticato modello di Problem based learning. Purtroppo oggi è più frequente il caso in cui la tecnologia, lasciata in mano ai tecnologi e non presidiata (o solo subita) dai didatti, contribuisce a reintrodurre in classe metodologie vecchie capziosamente rivestite di un’innovazione solo formale, modelli obsoleti di derivazione comportamentista, dinamiche biunivoche di insegnamento/apprendimento, la concezione di un sapere chiuso, nozionistico, non problematico.
Se dunque si vogliono aggiornare i metodi e le forme tradizionali di trasmissione del sapere, io non credo che le tecnologie, da sole, siano la strategia giusta. Non lo sono nella scuola come non lo sono nella politica: non c’è nessuna relazione tra un iPad e nuova didattica, come non c’è fra streaming e democrazia. Ma questo non vuol dire che le tecnologie siano neutre, fredde, inerti. Al contrario, hanno una propria intelligenza e una forza intrinseca che tuttavia conduce spesso in una direzione divergente rispetto quella propugnata dai paladini dell’innovazione. Per quello che è oggi il quadro delle forze in campo, portare in classe una componente digitale con un certo livello di sofisticatezza significa introdurre qualcosa che è di fatto fuori dalle possibilità di controllo dei legislatori e degli insegnanti. Per questo io credo che sia prioritario mettere gli insegnanti in grado di fare una scelta (anche, perché no, controcorrente), più che imporla per legge. È un aspetto che mi pare troppo sottovalutato, forse perché parlarne espone alla grave accusa di opporsi alle leggi naturali del mercato; qui tuttavia non si tratta di ideologia, ma di qualcosa di molto più concreto e reale. Apple, Google, Microsoft, Amazon non stanno lottando fra loro per imporre un prodotto hardware o software, ma ecosistemi complessi e sostanzialmente chiusi (de facto, se non de iure) nei quali i contenuti formativi e informativi sono, prima ancora che un business, una leva per introdurre ad altri prodotti e servizi, tutti indissolubilmente interconnessi.
Questi ecosistemi non presuppongono utenti generici e meno che mai studenti, ma consumatori. Chi lavora nel settore educativo ha ben presente quanto possano essere generosi con la scuola i feudatari del web. La scuola per loro non è tanto un mercato diretto: troppo piccola, almeno fino a oggi, la torta a disposizione. La scuola è il luogo in cui viene messo in mano agli studenti, agli insegnanti e alle loro famiglie quel filo d’Arianna paradossale che, tirato piano piano, conduce dentro al labirinto: un luogo talmente pervasivo e con una tale capacità di attrazione che rischia di fagocitare la scuola stessa. È quello che succede quando si mettono accanto entità di cui una ha a malapena i mezzi per sopravvivere, mentre l’altra assomma ambizioni e forze che raramente organizzazioni private hanno avuto nel passato. È la pericolosa illusione che si possano colmare le lacune di investimento rispetto alla prima utilizzando le risorse messe a disposizione dalla seconda. La storia è piena di esempi su quello che capita, di solito, in situazioni del genere. È una delle cose che mi hanno insegnato a scuola.
Questo pezzo è apparso precedentemente su Alfabeta2