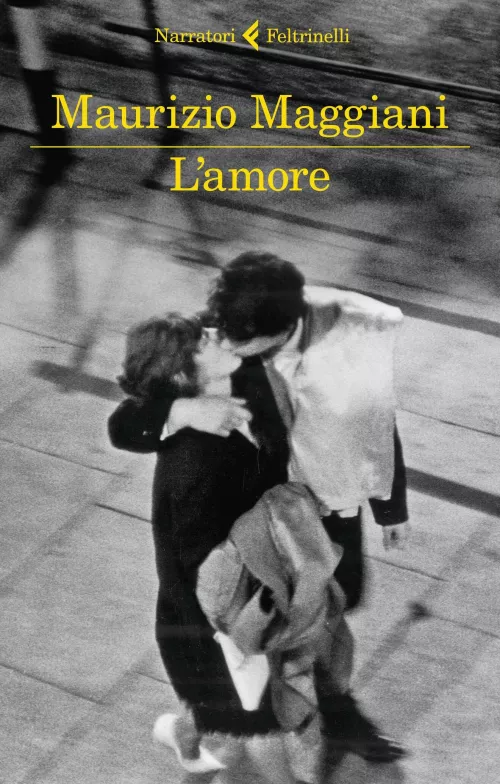Eraldo Affinati, Maurizio Maggiani / Tutti i nomi del mondo e L’amore
Tra i protagonisti della letteratura italiana di questi anni, Eraldo Affinati è senza dubbio una delle figure verso le quali provo la più sincera e convinta ammirazione. I suoi interventi giornalistici mi sembrano quasi sempre condivisibili alla lettera. Al suo nome e a quello di Anna Luce Lenzi è legata una iniziativa quanto mai meritoria, esemplare anche sul piano politico, cioè la scuola di italiano per migranti Penny Wirton. Quanto alla sua attività di narratore, mi sembra contraddistinta da un’idea ‘etica’ di letteratura, che è certamente uno dei fattori che qualificano una civiltà letteraria. Per rimanere all’ultima – penultima, anzi – sua prova, L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani (2016) è stato uno degli eventi principali nel cinquantenario della pubblicazione di Lettere a una professoressa. Così ho preso in mano questo nuovo libro, Tutti i nomi del mondo, Mondadori (pp. 282, € 19), con una forte prevenzione positiva. Titolo, bello.

Bella e promettente l’idea di convocare, nella forma di un ideale registro di classe, i nomi delle persone che hanno contato nella vita dell’autore: tanto più che si tratta davvero di un campionario dell’onomastica globale (Abdel, Bostan, Costantin, Daba, Erminio, Felicity, Gavina, Hermal, Ilario, Jan, Kim, Labib, Mustafa, Nwaebe, Ottavio, Pietro, Quirina, Rosina, Sesto, Tareq, Ullah, Vittorio, Willi, X, Yasser, Zuri). Coinvolgente, ad apertura di pagina, il fuoco d’artificio dell’avvicendarsi di voci, che poco dopo trova un criterio ordinatore nell’alternanza fra il narratore e Ottavio, anzi Ottavietto, romano romanissimo del Tiburtino terzo, che s’installa nella pagina come titolare di un metodico, irriverente, spassoso controcanto.
«Geniale, assolutamente geniale», mi sono detto. E me lo sono ripetuto per un buon pezzo, durante la lettura. Senonché la formula ha cominciato a logorarsi. Due o tre righe, a volte quattro, e Ottavietto commenta. Una riga, una riga e mezzo, e Ottavietto commenta. Un romanesco espressivo, colorito, maneggiato con sicura competenza e con efficace varietà di ritmo: ma insistente, troppo. Troppo davvero. «Te ne strigne er core. – A ‘nfamone! – Ma che ne vòi sapè? – A questo j’è partita ‘a brocca. – ‘Namo, rega’. – Ta’a rischi. – Ma nun stacchi mai? – A professo’, damme retta, mannalo a quer paese».
Nell’arco di un paio di capitoli, sono passato dal divertimento alla perplessità, allo sconcerto, all’insofferenza. Possibile che non riesca a chiudere il becco? Quando mi sono reso conto di odiare Ottavietto, ho interrotto la lettura. Ma con rammarico, con grande rammarico. Perché le storie che Affinati racconta, e sia pure in forma frammentaria, sono un repertorio eccezionale dei destini umani che s’incrociano nell’Italia del secolo ventunesimo: in Italia, o più precisamente a Roma, sul Colle Oppio – e, a proposito, si potrebbe ormai dedicare uno studio monografico alla rappresentazione letteraria di quella zona di Roma, fra la Stazione Termini e l’Esquilino, che nell’ultimo decennio è una calamita per i migliori narratori romani in circolazione (a cominciare dal Tommaso Pincio di Cinacittà, Einaudi 2008). Né si tratta solo di un interesse, per dir così, di contenuto: una delle operazioni più interessanti che Affinati intraprende con Tutti i nomi del mondo è la stilizzazione dell’italiano parlato da migranti delle provenienze più varie, con inevitabili transizioni e modulazioni verso una regolarità che consenta di narrare in maniera distesa. Se solo non ci fosse di mezzo Ottavietto, che con la sua petulanza non solo dà sui nervi («Te pòi fidà. – Pe’ modo de dì… – E che no so? – Voi che te do ‘na mano?»), ma compromette il gioco linguistico sull’italiano appreso, suscettibile di trascolorare dalla verosimile stentatezza della battuta alla fluidità del raccontare. Che sarebbe stata, anche, una bella morale: tanto per chi insegna, quanto per chi apprende.
Così sono passato a un altro autore di provato valore, Maurizio Maggiani. In copertina, ritaglio d’una celebre fotografia di Bruce Davidson con una coppia inquadrata dall’alto che si bacia (Couple kissing), immagine che il sito Magnum Shop include nella categoria «Vintage poster»: e che tuttavia sembra del tutto conforme al titolo, disarmante per ambizione e semplicità, L’amore. Come sempre, l’editore è Feltrinelli (pp. 202, € 16). A differenza del libro di Affinati, qui i nomi propri non sono molti; in particolare, mancano i nomi dei due personaggi principali, chiamati solo «lo sposo» e «la sposa». Lo sposo, al cui punto di vista la narrazione si attiene rigorosamente, chiama la sposa «amata mia»; nel corso del romanzo veniamo poi a sapere che, per parte sua, lo sposo in gioventù era stato soprannominato il Fabbro per un episodio avvenuto a Parma, l’assalto a una sede del partito neofascista della cosiddetta prima Repubblica, il Movimento Sociale (MSI). Altrettanto drastica, rispetto a Tutti i nomi del mondo, è la riduzione di orizzonti: il contenuto del romanzo è, in buona sostanza, la storia della vita dello sposo, ormai anziano, nato e vissuto in Lunigiana, la zona ai confini tra l’estremo lembo della Riviera ligure di Levante e le Alpi Apuane che è anche patria dell’autore.
Non manca, è vero, un’apertura al mondo di fuori: fra le attività dello sposo c’è l’importazione di zinco, e per questo lo vediamo consultare l’andamento della Borsa mineraria di Windhoek, Namibia. Ma non è un industriale: lo fa solo per dare una mano agli operai che, sul punto di perdere il lavoro, hanno cominciato a gestire in proprio l’attività di una fabbrica. Lo sposo appartiene a una generazione che ha fatto della politica una ragione di vita, e, pur nel mutare dei tempi e dei contesti, a certi principî è rimasto sempre fedele (interessanti considerazioni vengono fatte a proposito della parola «anarchia»).
L’amore è un libro intimo, delicato, silenzioso. Lo sposo ripensa agli anni andati, ma non per narcisismo o ripiegamento su di sé; è la sposa che, prima di addormentarsi, gli chiede di raccontargli «un fatterello». E tra i fatterelli, molti riguardano le storie che lo sposo ha avuto prima di conoscere lei. Dall’alto di un amore sereno, compiuto, così stabile da apparire definitivo, lo sposo finisce per ripercorrere la propria educazione sentimentale: gli amori che ha avuto o ha creduto di avere, il lungo cammino per riuscire a pronunciare davvero parole come «amore» o «ti amo». E così facendo ripercorre intera la propria vita, ricostruisce l’ambiente umano, sociale, geografico che gli appartiene, e a cui appartiene. Intanto attende alle proprie quotidiane attività, l’orto, la bicicletta, lo zinco da acquistare, le conoscenze di una vita che si ritrovano, ora con piacere ora con disagio, le fotografie che ormai hanno il valore di documenti storici.
Impossibile leggere L’amore d’un fiato (quello che avrei voluto fare con Tutti i nomi del mondo).
È un libro fatto di sfumature, di dettagli; c’è tanta vita, dietro ogni riga. Ed è un libro senza errori (nel senso che i mezzi corrispondono al fine): per questo va letto lentamente, va centellinato, come una raccolta poetica. Anche perché è un libro, nel senso più dignitoso e onesto della parola, senile. Un libro, forse, che si può apprezzare pienamente solo quando si è vecchi. E il rischio è che il lettore – pur simpatizzando con il protagonista, pur ripromettendosi, la prossima volta che gli capita, di evitare l’autostrada della Cisa (A5 Parma-La Spezia), e di discendere la Val di Magra per la vecchia strada del Passo, uno dei tragitti più incantevoli che sia dato percorrere in questo paese – il rischio è che il lettore cominci a domandarsi se, dopo tutto, per terminare la lettura, non sia il caso di invecchiare ancora un po’.
Eraldo Affinati, Tutti i nomi del mondo, Mondadori, pp. 282, € 19. Maurizio Maggiani, L’amore, Feltrinelli, pp. 202, € 16.