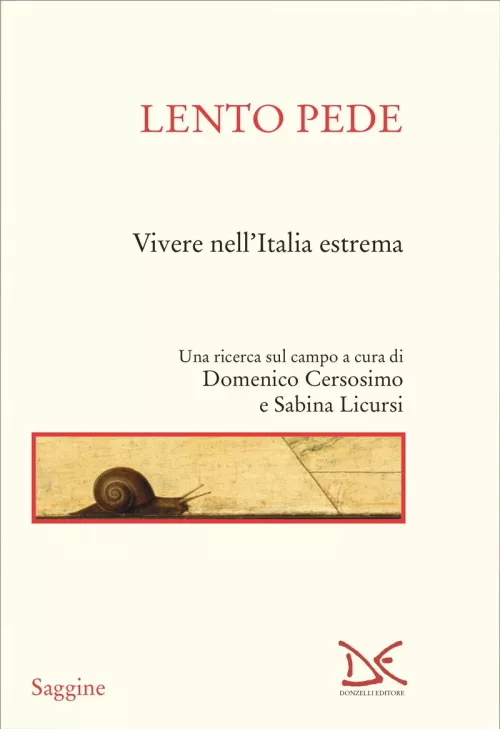Un paese ci vuole
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via”. E così è, ed è stato. Ma forse è arrivato il momento di fare i conti con un insieme di luoghi comuni che riguardano la vita dei paesi a cui allude quella tragica e teatrale frase con cui Pavese iniziava La luna e i falò, il libro scritto poco prima di uccidersi. Per la geografia umana e per il carattere culturale della nostra attuale nazione – dunque per la vita stessa del nostro paese, quello con P maiuscola –, il paese, questa entità provinciale ancora così fragile e diffusa, così maggioritaria e così significativamente italiana, resta tuttora variamente implicata nella realtà sociale, nel discorso pubblico e nelle scelte politiche ed economiche. Quale che sia la realtà, la crisi dei paesi ci riguarda tutti da vicino e si ripropone irrisolta, specie in questo particolare momento storico. Il costante svuotamento demografico e la “sparizione dei paesi” sono destinati a fare problema, a interrogarci sul presente e sul futuro da costruire in Italia con o senza paesi. Intanto un dato di fatto. Su quasi 8000 comuni, compresi tra questi le città capoluogo, i grandi centri metropolitani e quelli medi, distribuiti da Nord a Sud, ci sono ben 5.535 comuni che restano oggi sotto la soglia critica dei 5.000 abitanti. Questi piccoli comuni, che sono propriamente ciò che abbiamo definito da sempre “paesi”, rappresentano ben il 70% del numero totale dei comuni italiani, e ben 13 milioni di persone che nei paesi continuano ad abitare e a vivere. Nonostante declino demografico, perdita di servizi e attività fondamentali.
Dunque, i paesi pur gravemente dimidiati, restano l’entità geografica e amministrativa più capillare e meglio territorialmente distribuita, tipica della nostra tradizione insediativa di lungo periodo. Ma cosa sappiamo, cosa succede davvero dentro le pieghe di questa geografia minore, lontana ma poi mica tanto dai grandi centri pieni di traffico e di consumi, scarsi di gente e di velocità, di modernità e di indifferenza verso il passato prossimo e la vita concreta e attuale degli abitanti di questa “Italia estrema”? È una questione sulla quale oggi si accampa con accresciuta enfasi soprattutto l’attenzione sensazionalistica e la crescente spettacolarizzazione apportata dalla convergenza dei media (Tg, organizzazioni per eventi locali, rubriche turistiche, fiere e sagre, etc). Una falsificazione consolatoria che vuole che quella dei paesi sia ancora l’Italia delle tradizioni secolari, dei luoghi incontaminati e delle bellezze naturali e artistiche, l’Italia del pane buono e dell’ospitalità, dell’amicizia e della solidarietà, della vita lenta e del dolce far niente.
Nondimeno, la pubblicistica culturale e la riflessione incrociata da parte degli specialisti sui diversi aspetti del medesimo tema è proporzionalmente cresciuta in questi ultimi anni. Il notevole incremento di applicativi di ricerca da parte di studiosi e specialisti in ambito scientifico è dovuto al rinnovato interesse per il tema dei paesi e delle aree interne che fa capo a economisti, antropologi, sociologi, demografi, urbanisti, giuristi, amministratori e pianificatori. È questa la dimensione e l’indirizzo percorso da un volume collettaneo che raccoglie una serie di saggi unificati dal titolo Lento pede. Vivere nell’Italia estrema. Una ricerca sul campo a cura di Domenico Cersosimo e Sabina Licursi (Roma, Donzelli, 2023, pp. 189, Euro 19,00) che documenta ed esamina i timidi e contrastanti segni di resistenza e di presenza in vita che si registrano in una regione emblematica della crisi italiana dei paesi come la Calabria, e in particolare nelle sue aree interne e nei “63 paesi lontani dai servizi di cittadinanza” interessati dall’esperimento della SNAI, la Strategia Nazionale Aree Interne.
Lento pede è un lavoro a più voci (8 i testi raccolti, 11 gli autori) che postula una domanda cruciale: se “le aree marginalizzate” non siano ancora del tutto perdute, se “non sono spente” e “come abitare la rarefazione” di questa Italia “estrema”. Si parte da un’avvertenza etica e semiologica: “Per accorgersene però bisogna adottare altri sguardi, accendere i fari sulla vita che c’è nei paesi ‘vuoti, sui bisogni, le attese, le aspirazioni di quanti restano, tornano e, più raramente, arrivano. Pochi ma sufficienti per autorizzare la speranza che i luoghi rarefatti siano abitabili”. Cersosimo, ancora per Donzelli, aveva anche coordinato e raccolto di recente altri sguardi e opzioni di ricerca intorno a un piccolo volume a più voci dal titolo Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi (a cura di F. Barbera, M. Cersosimo, A. De Rossi), che a questo Lento pede fa idealmente da contrappunto e continuazione.
Tirando le somme, anche quando raggruppati insieme e impegnati con sguardo convergente in studi e ricerche condotte sul campo, da questi nuovi avvicinamenti al problema e da queste ripetute esperienze multidisciplinari, sinora piuttosto raramente è scaturito un quadro di contributi e di conoscenze spendibili e realmente avanzate. Pochi, pochissimi, gli apporti in grado di confortare le tanto attese conoscenze necessarie a illuminare spiragli utili a trovare soluzioni concrete e partecipate. Le ipotesi di lavoro utili a suggerire o concretizzare buone prassi e strade percorribili per l’affermazione di programmi politici, azioni, progetti in grado di affrontare la crisi dei paesi faticano a farsi strada. I connotati di queste trattazioni richiamano oramai una sorta di “genere”, nato a sua volta sul margine delle conoscenze. È una forma testuale eterogenea e composita che conosco perché l’ho praticata anch’io in alcuni miei libri e nel corso delle mie ricerche. Una specie di montaggio che ricorda i tratti di certe ibridazioni paraletterarie e imitazioni testuali, una forma in fondo sufficiente a giustificare se stessa come altro estremo di un discorso sull’estremo della geografia sociale che identifica i paesi, i luoghi sporadici e disabilitati, le aporie degli spazi in abbandono, certe sopravvivenze umane nelle terre di nessuno sparpagliate nelle diverse periferie suburbane della nostra penisola.
È una operazione sul limen, giocata sulla “situazione del margine”, tesa sull’indeterminatezza che percorre l’intervallo tra il non più e il non ancora; un’avventura tra la scienza e l’incerto argomentativo che certe volte riesce meglio, altre volte riesce peggio. Così si compilano brevi testi di cronaca, ci si riporta a cataloghi o scritti d’occasione, e si lasciano le cose esattamente dov’erano. Ci sono pagine che ottengono il risultato di accrescere in chi legge la consapevolezza delle frustrazioni e delle disillusioni che toccano in sorte coloro che invece ancora fanno stato in luogo nei paesi, vivendo da dentro e nel corpo dei vivi il sequestro sociale di questa geografia dispersa, che per molti versi appare vieppiù “normalizzata sul piano inclinato di un declino a cui è sempre più difficile sottrarsi” (D. Cersosimo).
I paesi scontano oggi un tempo della storia che appare radicalmente “diverso” ed estraneo. La vita quotidiana e la mentalità si confrontano con i rigori del “tramonto demografico”, sperimentano la prepotenza del “dispositivo dello spopolamento” che continua a generare abbandoni e migrazioni inarrestabili. Dando forma con ciò a “un sentimento inedito della fine, con una versione inconsueta dell’irreversibilità, per affrontare la quale non sembra vi siano a disposizione memorie retrospettive efficaci” (F. Librandi). Il vero problema dei paesi sta altrove. Paradossalmente proprio la recente abbondanza di scritture sui paesi, dimostra che la vita vera dei paesi non è mai stata così reietta, dimenticata, disamministrata e, ancor peggio, erroneamente trascritta come accade oggi in Italia. L’Italia, che è un mosaico di piccoli centri che ne formano l’architettura vivente, sembra proprio aver quasi del tutto rimosso l’idea stessa e l’evidenza storica del “paese”. Sostituendola con surrogati più spendibili e alla moda. Quello dei cosiddetti borghi è uno dei più frequenti e fastidiosi spropositi della comunicazione superimposta dai media. Con la ridondanza di un vero e proprio genere di pubblicistica specializzata in borghi, anche la più recente, strabordante e variopinta “narrazione” letteraria che ne consegue è entrata a far parte di una pervasiva quanto superficiale discussione pubblica, che si estende sino agli azzardi sulle sorti attuali e future dei paesi, specie quelli situati nelle aree interne del Sud.

Un tema su cui ormai tutti hanno da dire. Via via sempre più ipotetico e diversificato, il luogocomunismo sui paesi/borghi è però sempre più omologato alla accattivante e falsificante tendenza al marketing che punta al mirabolante, agli strumenti persuasivi della pubblicità, all’ovvia preveggenza della turistizzazione forzata. Quello che è indispensabile per il passaggio dal paese di ieri alla dimensione attuale del “borgo” è una sorte di dotazione “special”. Che prevede la messa a catalogo di una serie di eccezionalità, che stanno in ciò che è piccolo, bello, eccellente, autentico, sostenibile, pittoresco, rilassante, poeticamente naïf, esteticamente fungibile. L’attenzione calata da qualche decennio sui cosiddetti “borghi” è in realtà il derivato di una crisi di identità delle forme dell’abitare e del produrre, che nasce altrove. In generale è sovrapponibile al crescente rifiuto della complessità che accompagna il vivere in ambienti sociali stratificati e problematici, che trova origini e ragioni nelle crisi epocali – clima, salute, lavoro, economia – e nelle trasformazioni urbano-sociali sempre più massicce e incontrollate che investono la fisionomia degli ambienti metropolitani e la dimensione civile della forma urbana nel contemporaneo post-industriale.
L’enfasi su paesi e borghi ben rappresenta quindi una sorta di nevrosi sociale con sintomi di conversione. Mostra il tentativo di riposizionamento, altrove e con altri mezzi, delle logiche della metropoli, il trionfo di una boria antropologica sempre più pericolosamente classista, ipocritamente urbanocentrica e sempre più fortemente sbilanciata a favore dello stile di vita tipico delle metropoli. Il “piccoloborghismo” e l’abbandono dei paesi di cui è affetta l’Italia è il duplice riflesso della degnazione di una borghesia un tempo affluente e del panico di ceti medi in caduta libera. La composita platea sociale di nuovi (potenziali) utenti che si rivolge ai borghi e non ai paesi – identificati non come luoghi-rifugio, ma come dislivello insediativo tipico delle comunità locali irreversibilmente al tramonto –, è appunto quella stanca del declino economico, preoccupata per il recente allarme pandemico e climatico, per il caos sociale e la crescente insicurezza di città e contesti urbani divenuti “invivibili”. Proprio nel periodo di restrizioni pandemiche anche alcune note archistar avevano, non a caso, riaperto il dibattito su questi temi. Ma è a cavallo tra il 2021 e il 2022 che esplode un fenomeno che possiamo definire di superamento della soglia pubblica, destinato a segnare anche il recepimento istituzionale dell’abuso di retorica sul tema dei borghi. Accade con la linea A dell’apposito Bando borghi, gestito dal ministero dei Beni Cult. e inserito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Un provvedimento molto strombazzato anche se ha destinato (solo) 20 milioni di euro a 21 progetti “esemplari” di rigenerazione, uno per Regione, quasi tutti però a fini esclusivamente turistici, con la completa estromissione dei legami territoriali. Poi molto ha contribuito alla divulgazione del fenomeno –non certo alla sua decostruzione significativa e ad una sua più consapevole rappresentazione culturale– la diffusione di video e prodotti vari di comunicazione audiovisiva e artistica passati dai media. Unitamente alla fioritura di una congerie di festival e festivalini estivi intitolati ai paesi, alla sostenibilità, alla restanza, al “piccolo e bello”, alle preoccupazioni per le sorti delle aree interne. Insomma i borghi come nuovo status symbol del tutto de-realizzato e disinvoltamente fungibile, “perché il termine borgo è bellissimo e non va demonizzato”, secondo la ricetta che per Anna Rizzo, autrice di I paesi invisibili dovrebbe essere presa sul serio come “Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia (Il Saggiatore, 2022).
Resta quindi aperta e ancora irrisolta la domanda se una nuova geografia possibile per i cosiddetti “borghi” italiani, possa includere senza cancellare del tutto quella tradizionale e ben più numerosa e problematica dei paesi, evitando il fraintendimento corrente che i paesi per sopravvivere “debbano essere speciali”. Anche se l’alternativa paese/borgo è già effetto della dialettica che ha imposto questa nuova entità come il risultato di narrative e idealizzazioni che ormai connotano un insediamento storico per specializzazioni funzionali, trasformato da progetti fungibili e intercambiabili secondo la logica del profitto neoliberista. Paesi-albergo o villaggi-relax, borghi “belli ma bisognosi” cui si sottraggono o cancellano come semplici ingombri del passato, storia, geografia, tratti identitari e rapporti stratificati col contesto economico e sociale. Non c’è più spazio, sembra, per paesi normali, paesi e basta, in cui riprodurre la vita sociale in ambiti più ristretti e con margini di autonomia primariamente dipendenti dalla dimensione locale.
La narrazione smart omologa invece le differenze, impone immagini patinate, elimina per magia ogni forma di conflitto, cancella il peso delle comunità e della storia, fraintende la realtà complessa delle relazioni locali, facendo di luoghi e persone una sorta di bazar dell’alterità prêt-à-porter, “un po’ un selfie del mondo” alla moda (F. Barbera, Contro i borghi).Versione altrettanto simmetrica e autocompiaciuta del borghismo alla moda è quella dell’orazione civile indirizzata “al paese che ci vuole”. Non salveranno certo i paesi da spopolamento e anomia sociale gli inni nostalgici e lacrimosi per il compianto della sparizione di antiche veto-comunità da presepio, che fanno il paio con l’apologetica alla moda rivolta a forme di neocomunitarismo da ottimati. Il bricolage intellettualistico e l’eclettismo da show-biz lasciano correre una realtà sempre più elementare e deprivata, che resta dov’è, così com’è. Davvero i paesi esistono in quanto “contesti appartati, diversamente appaganti”?; e davvero “si può aspirare a un futuro diverso da quello contratto e cupo delle tendenze demografiche e dell’indifferenza istituzionale, se si rovesciano i vincoli in opportunità”? I limiti sono sempre opportunità valicabili?: “la rarefazione demografica come alternativa alla congestione urbana; la lentezza come guadagno di tempo per abitare lo spazio; le pluriclassi per mettere a punto nuovi metodi didattici; la distanza dai poli di servizi per sviluppare forme di mobilità e accessibilità diverse”.
La ridondanza retorica che sembra più volte sul punto di appagarsi in se stessa. Per ora la vita dei paesi, piccoli e anche piccolissimi, resta gioco forza sommersa, come del resto quella dei suoi sparuti abitanti, assorbita nel grande gioco maggioritario del nuovo mondo che tutto omologa e travolge. Eppure, sembrano dire infine quelli di Lento pede, che anche paesi piccoli e comunità minori, a dispetto di tutto, possono continuare a durare, ed essere abitabili, a vivere dignitosamente, esattamente lì dove stanno da secoli. Occorre però, indicano sempre gli autori, “uscire dal solco”; “non guardarli più dal lato del passato”, rifiutarne attivamente la dimensione di asili di deprivazioni e povertà ostaggio del nostos “per quello che resta”, digerendo finalmente il bolo delle ruminazioni post pasoliniane e il rimpianto del vecchio mondo. Chi scrive sembra credere a una nuova immaginazione sociale in grado di riabitare i paesi; “una nuova linfa”, da attingere da “nuovi protagonisti, nuovi arrivi, nuove sorgenti di desideri” necessari per “abitare la rarefazione”. Che per ora è tutto quello che c’è. E c’è quindi il richiamo a forme attive di innovazione, con il ricorso a forme di immaginazione “retro-innovativa” in grado di mettere a frutto quel che c’era e quel che sarà. “La ripresa delle aree interne non si realizza con la nostalgia, con la testa rivolta all’indietro, con l’aratro e la miseria. Al contrario sarà tanto più duratura quanto più farà ricorso a tecniche e approcci innovativi, alla creatività e alle tecnologie del presente, ma anche del passato: innovazione non sempre coincide con il nuovo, tantomeno con tecniche e tecnologie recenti.
A volte innovare significa riadattare e ricontestualizzare tecniche tradizionali. Serve innovazione lenta, che guarda lontano, strettamente tarata sui bisogni essenziali dei residenti, adattata alla caratteristica dei singoli luoghi, generatrice di diverse opportunità e di tutto ciò che può favorire l’integrazione sostenibile tra attività umane e ambiente e la giustizia sociale”. In un’epoca di passioni tristi e incostanti l’esortazione a riabitare i paesi risuona per ora come una petizione di intenti, con l’appello alla “speranza come principio di indeterminazione, come energia che per definizione è protesa verso il futuro” (F. Librandi). Un’utopia da ristabilire anche contro “la privatizzazione” di spazi, sentimenti e discorsi sociali. Attività che riguarda per ora più “la dimensione culturale, l’economia simbolica” e “i modi in cui la speranza viene prodotta e mantenuta nei processi concreti di formazione della conoscenza”, come affermazione un dover essere etico che di fatto deve ancora precedere e creare le condizioni di progetto di una società realizzabile nell’orizzonte politico e nelle condizioni date. Somministrare speranze e incoraggiamenti, avanti lento pede, paese per paese, mentre tutto intorno cambia e si allontana velocissimamente, con la realtà che nel frattempo si rapprende e indurisce come cemento a presa rapida. Complicato, non impossibile, forse. Resta la domanda del che fare, e nessuna soluzione in vista.
Controfattualmente è pensabile invece che la fine del mondo dei paesi – inevitabile? – non coincida più necessariamente con la fine del mondo demartiniana, e che anche l’apocalissi culturale della sparizione dei paesi e delle comunità locali diventi infine condizione per aprire il passaggio verso un altro mondo (F. Librandi). Se accade, quando qualche paese piccolo resiste e continua a vivere, è per merito di giovani istruiti e di gruppi di cittadini organizzati, di amministrazioni attive e consapevoli. Solo così, borghi o non borghi, i paesi possono salvarsi. Perché anche i paesi devono cambiare, per restare vivi. Se è ancora vero “che un paese ci vuole”, è anche vero che, se ci vivi sul serio “non è facile starci tranquillo”. E devi prendertene cura, dato che non è un luogo per tutti, e la sua realtà spesso “sfugge di mano”. Cose che “si capiscono col tempo e l’esperienza”. E occorre sempre chiedersi perché?, il qui e ora, dato che ogni paese è il mondo. Ed è possibile che “con tutto il mondo che ho visto”, anche oggi, nessuno “sappia ancora cos’è il mio paese”, come già ammoniva Pavese in quel suo libro scritto prima della fine.