Che cosa significa essere umani?
Che cosa significa essere umani? Partiamo da qui, da questa domanda capitale, perché quel punto interrogativo non è retorico, ma fondativo. Il libro pone molte domande, e a nessuna pretende di rispondere in maniera conclusiva: nella densità del testo ad ogni pagina, ad ogni questione, si dipartono altre vie, altre domande. Essere umani, del resto, è una domanda aperta: l'ente che chiamiamo umano, infatti, consiste in una radicale dimensione di apertura al mondo. E a farlo consistere in quanto umano, c'è proprio il fatto di essere un produttore di significati: l'umano è l'animale che si chiede “che cosa significa essere umani?”.
Vittorio Gallese, neuroscienziato che negli anni novanta fu parte del team che scoprì i neuroni specchio, e Ugo Morelli, psicologo e studioso di scienze cognitive, hanno scritto a quattro mani questo testo che suona come il precipitato di un comune itinerario di conoscenza e riflessione, nella distinzione delle rispettive competenze e attività, e si pongono la domanda sull'umano incrociando differenti saperi nell'ottica della complessità, con una scrittura ad un tempo rigorosa e divulgativa: insomma, mettono a disposizione di un ampio pubblico di lettori il modo in cui i saperi neuroscientifici, psicologici e filosofici cercano di far luce sulla “natura umana” in una prospettiva evolutiva.
Spesso, nel senso comune, le neuroscienze appaiono come la frontiera del riduzionismo: scopriamo i meccanismi del cervello, si pensa, e scopriremo le fondamenta dell'umano, che a quei meccanismi neurali possono tutti quanti essere ricondotti – come molti auspicavano sarebbe stato per il DSM-5 del 2015 – l'ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali –, ovvero realizzare una mappatura dei cosiddetti disturbi mentali in relazione al loro fondamento neurobiologico – tentativo fallimentare, ma che testimonia di una tendenza persistente e centrale della nostra cultura e della nostra contemporaneità. Ma le neuroscienze non sono il braccio armato del riduzionismo: al contrario, possono mostrare come sia illegittima qualsiasi riduzione organicistica dell'umano, e qualsiasi riduzione della mente al cervello.

Se il riduzionismo implica il dualismo mente-corpo (dove la mente viene ridotta a attributo del cervello), il frame di Che cosa significa essere umani? è quello del superamento dei vari dualismi che la nostra tradizione culturale porta con sé: mente-corpo, natura-cultura, io-tu. Finché non usciremo da queste dicotomie, non saremo mai in grado di comprendere che cosa sia l'umano. Dicotomie che fondano invece il senso comune, e pure il senso politico comune di questa società degli individui: e invece no, l'individuo non è la sola cosa che esiste, come vuole la vulgata egemonica, formulata da Thatcher, iniettata nelle vene del nostro mondo dalla grande trasformazione antropologica neoliberale, che si radica però in presupposti culturali ben anteriori. Prima dell'individuo esiste la relazione, ecco uno dei fondamenti concettuali di quest'opera. Non più il primato del soggetto, ma la centralità della relazione, che “precede l’individuazione e configura una dimensione del noi nella quale si individua il soggetto”. È in questo spazio noicentrico, come da molti anni va scrivendo Gallese, che si individua una qual cosa che si chiamo Io – che non è una cosa, ma un processo che emerge da un sistema dinamico. Ed è per questo che non individuo, dovremmo dirlo, ma condividuo, come dice l'antropologo Francesco Remotti: con-dividuo, in quanto ciò che chiamiamo Io è l'esito – sempre precario e in divenire – di un processo relazionale. Questo Io che si presume fondamento si scopre emergenza di un processo che lo trascende. Di questo processo il cervello è certamente uno degli elementi decisivi, ma il punto è che esso implica, ed è implicato da, altri elementi: il cervello, il corpo, l'azione, e appunto la relazione. Senza mettere in circolo questi elementi (che propriamente, allora, non saranno più elementi, ovvero costituenti ultimi), ci condanneremo allo scacco della domanda sull'umano.

Per comprendere la soggettività, dunque, bisogna partire dalla relazione, ma “se partiamo dalla relazione, dobbiamo partire dal corpo, quindi da un concetto performativo, pragmatico e agentivo dell’essere umano, che si individua e diviene sé stesso grazie alla relazione”: noi siamo, infatti, corpo-cervello-mente in relazione. Siamo, scrivono Gallese e Morelli, “cablati per connetterci con l'altro. L’imitazione neonatale è il primo strumento che abbiamo, innato, per sintonizzarci con l’altro, seguito da una serie di aggiustamenti e dalla capacità di istituire, cambiare e invertire ruoli”. Ma è già nel grembo materno che, come è stato osservato nei casi di gestazione gemellare, i movimenti diretti all'altro feto sono più accuratamente controllati rispetto a quelli diretti altrove: tra gli schemi motori di cui siamo dotati i più sofisticati sono quelli diretti all'altro.
La stessa razionalità non può essere davvero compresa senza incrociarla con la dimensione dell'intersoggettività, diversamente da quanto ha fatto gran parte della tradizione del pensiero occidentale. Per questa tradizione, per questo canone, l'umano è cogito, teoresi di una realtà che sta là fuori, e che conosciamo attraverso degli a priori. In questa tradizione, a mancare è il corpo. La stessa intersoggettività viene prevalentemente compresa in termini teoretici, ovvero possiamo capire gli altri grazie a una teoria della mente, negli stessi termini in cui possiamo elaborare un problema matematico. Nel paradigma teoretico-“oculocentrico” (nel senso della primato della theorìa, dell'eìdos, della conoscenza come visione), non c'è il corpo e non c'è il movimento: la cognizione è altra cosa rispetto al movimento. È così anche nel modello a sandwich del cognitivismo classico, dove azione, percezione e cognizione sono elementi isolati, e messi in relazione da un flusso di informazioni sulla cui base costruiamo una rappresentazione del mondo: in questa prospettiva, il movimento arriva alla fine, informato e causato dall'elaborazione del pensiero. Questa prospettiva non considera affatto come invece la relazione, che accade tra corpi, sia fatta di movimento: “è un andare verso o un allontanarsi da; è cercare quello che ci manca, è un proiettarsi verso l’altro da sé, ma proiettarsi non solo in senso metaforico bensì in senso fisico, in senso corporeo. Tant’è vero che, per mantenersi biologicamente in vita, per noi umani è centrale non solo l’omeostasi, cioè la capacità di movimento e scambio tra interno ed esterno, ma anche l’allostasi, la reciproca regolazione tra sé e altro da sé”. Azione e percezione, lungi dall'essere elementi isolati e distinti, “sono due facce della stessa medaglia e sono l’ingrediente essenziale di ciò che chiamiamo cognizione”. Tutto, insomma, nasce dal movimento: “sappiamo con sempre maggiore evidenza che le cosiddette parti motorie del cervello sono parte integrante degli apparati che ci permettono di riconoscere quello che c’è attorno a noi, dagli oggetti inanimati, al modo in cui mappiamo lo spazio, al senso che diamo alle azioni e alle esperienze altrui”. La percezione e l'azione non stanno in successione, ma si danno insieme: il sistema motorio non è un “organo esecutivo”, laddove lo scopo di un movimento viene mappato da qualche altra area del cervello, ma è il sistema motorio stesso che mappa le azioni, ovvero è caratterizzato in termini di scopo. La neuroscienza, qui, pensa insieme a Merleau-Ponty quando parlava di practognosia, ovvero una conoscenza determinata dalle potenzialità del corpo.

È nello spazio noicentrico, come si diceva, che prende corpo la nostra esperienza. Si tratta di mettere al centro il corpo che si muove in uno spazio – ciò che è stato ben compreso con la scoperta dei neuroni specchio, che, essendo la base fisiologica del meccanismo di risonanza motoria, ci permettono di connetterci all'altro a livello pre-intenzionale e pre-linguistico. Neuroni specchio che, vale la pena di ricordarlo, esistono in molte specie animali, ma che nell'animale umano si applicano non solo nelle azioni dotate di finalità, ma in tutti i movimenti: per questo, scrivono Gallese e Morelli, “noi siamo la vera specie mimetica”, perché possiamo parlare di imitazione quando si riproducono sia lo scopo delle azioni altrui sia i movimenti per arrivare a quello scopo. Riflettere sull'empatia in quanto sentire con l'altro – legata all'attività dei neuroni specchio – ci conduce a uscire dal recinto del riduzionismo: noi siamo costantemente nella relazione, siamo costantemente presi in un processo di riflessione dell'altro nel sé e del sé nell'altro, senza che questo cancelli la distinzione tra sé e altro (l'altro è sempre un “come se”: vi accediamo solo grazie al modello della simulazione incarnata), ma che li rende concepibili unicamente entro un processo: un processo in cui ciò che emerge non è riconducibile, riducibile, alle proprietà costitutive, e che, ancor prima, è dove sia l'io che l'altro sono a loro volta costituiti e prendono forma. Il rispecchiamento negli altri è sempre un riconoscere e un riconoscerci: “siamo quello che riconosciamo di noi attraverso la nostra auto-percezione combinata con l’etero-percezione, in un tempo e in un contesto”.
Ne seguono, in ordine sparso, molte domande. Se siamo relazione – se siamo, come scrivono gli autori diventità –, come possiamo non considerare come siamo intrinsecamente modulati dai fattori ambientali, socioculturali? Sono molte le evidenze scientifiche che dimostrano che la simulazione incarnata, ovvero l'espressione del meccanismo di risonanza dei neuroni specchio, è plasticamente condizionata dalle nostre esperienze: come evitare la questione della responsabilità, ponendoci in condizione di incrementare l'intensità della nostra connessione con l'altro?
La cognizione, si diceva, “è una costellazione di elementi in cui la percezione è l’altra faccia dell’azione”. E il linguaggio stesso – elemento antropogenico, se è vero che l'umano è l'animale che si chiede il significato – è evidentemente inconcepibile senza pensarlo come emergente dal corpo, e come un'emergenza evolutiva. Non è immaginabile lo sviluppo del linguaggio al di fuori della nostra corporeità, anche se ancora si tratta di comprendere come essa determini le attività linguistiche più astratte (come la negazione, alla quale Paolo Virno dedicò un saggio fondamentale in cui dialogava a distanza con Gallese). La disposizione a tradurre un oggetto in un significato, il comportamento simbolico, è la differenza specie specifica dell'umano, che è un sense-maker (pensiamo all'umano che decora un utensile, non per uno scopo strumentale dunque, ma per comunicare un significato: non possiamo osservare lì l'aurora di questa dimensione simbolica specificamente umana?). Il linguaggio – così come la rappresentazione in una caverna – ci rende non solo parlanti, ma parlati: diventiamo un “io”, e possiamo dire di “avere un corpo” (Virno, ancora). E, correlativamente, non solo sappiamo, ma sappiamo di sapere, come dicono Maturana e Varela; ovvero, non solo pensiamo (come fanno gli altri animali), ma pensiamo di pensare.
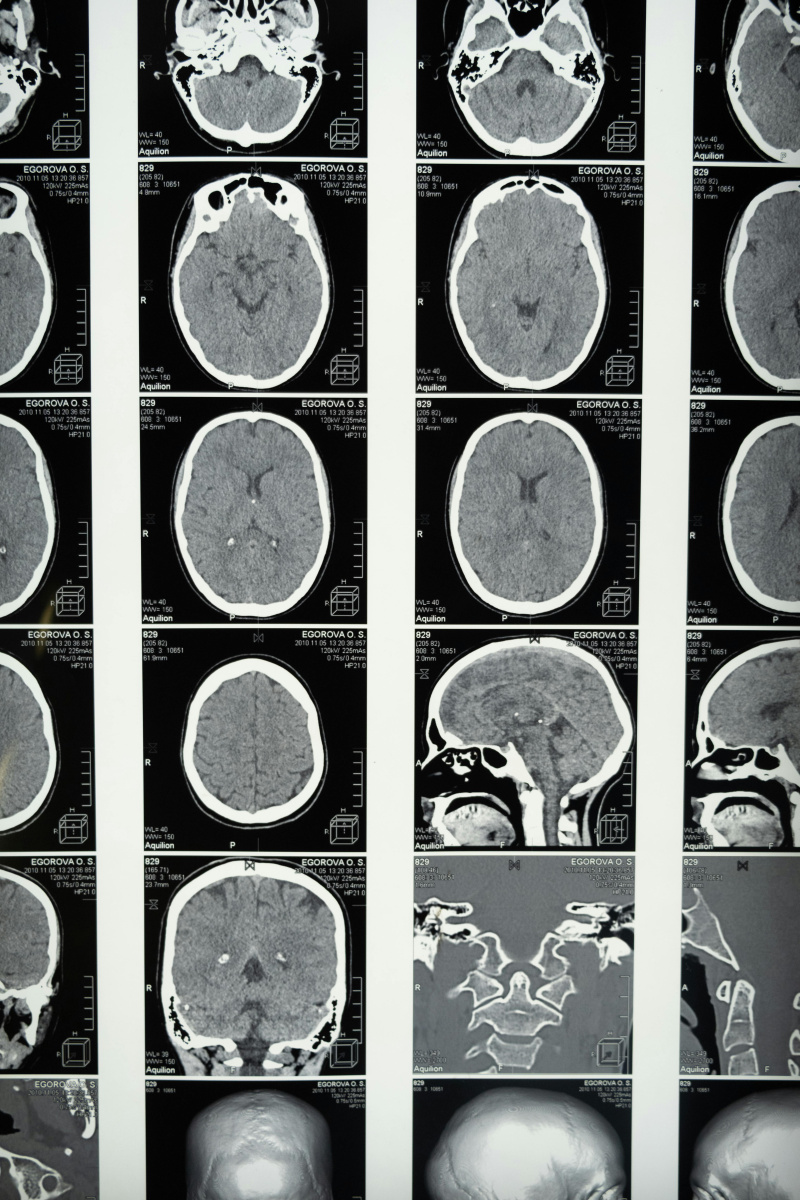
Occorre comprendere come questa differenza specifica sia radicata nell'evoluzione: e da questo punto di vista gli autori scrivono che “è plausibile ipotizzare che la sintassi linguistica sia evolutivamente legata a circuiti corticali premotori originariamente sviluppati per controllare la struttura gerarchica dell’azione. Quando nel corso dell’evoluzione la pressione selettiva ha portato alla nascita del linguaggio, gli stessi circuiti neurali incaricati di controllare la gerarchia delle azioni potrebbero essere stati riusati per servire la nuova funzione acquisita della sintassi del linguaggio”. Torna dunque quella tesi ricorrente nella storia della filosofia, da Epicuro a Condillac, che la dimensione corporea sensomotoria giochi un ruolo costitutivo nella facoltà linguistica dell'umano.
Tutto questo non significa esaltare la differenza umana nel sempiterno moto di presunzione antropocentrica: perché, nel momento in cui consideriamo la differenza umana, occorre tener presente che cosa ci accomuna agli altri animali e ci rende partecipi del sistema vivente, ovvero che “siamo un ramo dell’evoluzione che ha preso una certa strada, ma il tronco comune della vita ha dei principi di base che pur differenziandosi mantengono delle caratteristiche comuni”.
E poi ci sono ancora molte altre questioni che definiscono il nostro essere umani e vengono messe in gioco nel libro, in pagine e capitoli ai quali possiamo solo accennare. Il ruolo delle emozioni nella nostra esperienza, poiché l’emozione non è qualcosa che accade sorgivamente in interiore homine, ma accade entro il contesto della relazione con l'altro e ha dunque una natura sociale. L'apprendimento, che avviene esso stesso per risonanza incarnata, ovvero dall'esperienza: un'altra questione profondamente politica, visto che dovremmo capire che esso non può non coinvolgere corpo ed emozioni condivise, e sollecitare domande, curiosità, ricerca, esplorazione – laddove invece sempre di più predomina, come si vede bene nella direzione intrapresa dall'istituzione scolastica, una prospettiva tecnicistica, fondata sulle “competenze”, progressivamente spogliata di ogni postura critica e riflessiva. La relazione con il mondo che abitiamo, anch'essa governata dalla risonanza incarnata, con la necessità di ristabilire un legame di reciprocità col sistema vivente. L'immaginazione e l'esperienza estetica, che come si è già accennato a proposito della decorazione e del significato sono un momento decisivo nell'antropogenesi: l’esperienza estetica – un'esperienza relazionale e sociale, una risonanza con altri della creatività individuale – “si propone come un salto quantico dell’umano” perché “il leone si rappresenta senz’altro la gazzella mentre l’attende, ma non ne ha mai dipinta una”; ancora, la capacità di significazione dell'umano, la capacità di trascendimento dell'umano, la sua tensione rinviante.
Insomma, un libro che attraversa tutti i territori che definiscono l'umano nel suo farsi, nel suo stesso attraversamento del mondo, e dove si tenta di fondare il superamento del dualismo mente-corpo, soggetto-oggetto, natura-cultura. Nella prospettiva della centralità del corpo che si muove nello spazio, non si può che parlare della relazione mente-corpo in senso spinoziano, ovvero come “due livelli di descrizione della medesima realtà, che manifesta proprietà diverse a seconda del livello di descrizione prescelto e del linguaggio impiegato per descriverle. Un pensiero non è né un muscolo né un neurone; ma i suoi contenuti, i contenuti delle nostre rappresentazioni mentali, sono inconcepibili senza la nostra corporeità”. Un paradigma bio-culturale, dove natura e cultura sono partner in una danza intricata: “i nostri cervelli-corpi, scolpiti dall’implacabile mano della natura, desideravano un significato, facendo nascere la cultura come un vibrante arazzo intessuto di storie, strumenti e sogni condivisi. Pensiamo a un antico ominide, chino sul fuoco, che costruisce una lancia da un ramo caduto. In quel gesto è iniziata la danza”.
Sul sito di Fondazione Hapax è possibile iscriversi al doppio corso di Vittorio Gallese e Ugo Morelli, libro e lezioni, dal titolo Cosa significa essere umani. Fondazione Hapax e doppiozero collaborano nel progetto Synapsis, corsi di formazione a distanza che permettono di conseguire i crediti dell’Educazione Continua in Medicina (ECM).









