Un matrimonio felice / Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij
Giovanni è un tipografo di mezza età che dopo il licenziamento dalla grande azienda in cui lavorava, ha aperto una piccola attività in proprio per poter continuare il lavoro che costituisce la passione della sua vita. È un uomo mansueto, tanto gentile da avvertirlo come una debolezza, sposato con Giulia, una donna intelligente e ancora molto bella, che non ha mai capito come avesse potuto scegliere e amare intensamente proprio lui. La coppia vive in grande armonia e tranquillità in una villetta suburbana, con un piccolo giardino che lei cura amorevolmente, finché un giorno “il male [entra] nella loro casa”. Giulia si ammala gravemente e la malattia, anche se viene apparentemente superata, lascia dei segni nel loro rapporto che però entrambi, delicatamente, cercano di nascondere all’altro. Fino a che un giorno Giulia sparisce senza motivo né spiegazioni, dopo che la notte prima avevano fatto l’amore con grande tenerezza. Allora per quell’uomo in fondo semplice che è Giovanni (ammesso che un essere umano possa essere semplice), comincia un periodo di disorientamento totale, che lui cerca di controllare perseverando nella sua routine. Un giorno, per occupare il tempo e tener vivo il ricordo, decide di scegliere a caso uno dei libri della moglie, grande lettrice al contrario di lui che ha sempre e solo letto le pagine che doveva comporre badando unicamente alla corretta forma linguistica e tipografica, e di copiarlo tutto, per farne un libro unico, bellissimo, curato in ogni dettaglio, per quando lei tornerà. Mentre lo ricopia con sempre maggiore partecipazione, gli sembra di trovare nelle sue pagine una specie di premonizione di ciò che sta vivendo. Il libro è Anna Karenina, che come è noto ha uno degli esordi più famosi di tutta la storia della letteratura (”Tutte le famiglie felici si assomigliano; ogni famiglia infelice invece è infelice a modo suo”), che a mio parere è stata una delle molle che hanno indotto Claudio Piersanti a scrivere questa storia, per verificare quanta verità la sentenza contiene. A colpire Giovanni però non è la protagonista, che non assomiglia per nulla alla moglie scomparsa, quanto la figura di Vronskij, il seduttore di Anna, che si insinua nel suo mondo mentale come incarnazione di tutto ciò che lui non è, bello brillante e affascinante, e che può aver allontanato da lui la donna che continua ad amare più che mai.
Pian piano Giovanni quasi senza accorgersene sovrappone ciò che gli capita a ciò che trascrive (come lo scrittore ha presente ciò che ha letto quando scrive, fosse pure nella forma dell’oblio): trova nel libro di Tolstoj, in filigrana, alcune delle situazioni che sta vivendo e gli strumenti per cercare di capire, naturalmente in modo illusorio e arbitrario. Perché ciò che vive è effetto più di ciò che immagina, che di ciò che sa; e lui immagina sul filo non della realtà, ma di ciò che è scritto. Vronskij diventa la chiave per provare a interpretare prima ciò che immagina accada alla moglie, poi quello che accade dentro di lui, e infine cosa a tutto questo è sotteso, come destino. Dallo statuto di personaggio passa a quello di strumento ermeneutico, assurge a simbolo polivalente, a categoria, e quasi a entelechia. È la personificazione della minaccia, dell’inquietudine, dell’elemento senza coscienza morale che incombe, stravolge e porta alla distruzione. Alla fine troverà il suo vero nome, che non rivelo per la ferrea legge antispoiler. (La morte, detto in camera caritatis.)

Quel maledetto Vronskij, che racconta questa vicenda, è un libro struggente, senza contenere un solo passaggio sentimentale. Si tratta del resto di una caratteristica di Piersanti, che non si ritrae davanti ai temi forti, e anzi li va a cercare, e li affronta, sempre, insieme con adesione e distacco. Li prende sul serio, cioè, e proprio per questo se ne discosta per guardarli in faccia, con forza pacata, che però non ha nulla della distanza cinica, che semmai è presente solo nelle parole di alcuni personaggi. La voce narrante è impersonale, onnisciente, anche se prevale in buona parte del libro (dei libri di Piersanti) una specie di focalizzazione interna a uno o due dei protagonisti, di cui vengono seguiti moti d’animo e pensieri con una specie di discorso indiretto semilibero, se mi è concessa l’approssimazione: cioè libero nelle associazioni dei pensieri di personaggi, ma filtrato da una prosa asciutta, cadenzata in un ritmo di grande presa proprio in quanto piano, misurato nel tono, ma non freddo né mai sopra le righe nemmeno nei momenti più aspri, che evita sistematicamente la tentazione di sussulti vistosi e la ricerca di detti memorabili, nel senso letterale di questo termine. Vertici che non mancano, ma che nella lettura passano inavvertiti e arrivano a segno solo dopo, con un sottile quanto incisivo effetto di ritorno. Lo stile, in questo libro più che in altri, pur severo, è soffuso di tenerezza, oggettivo e al contempo partecipe; la sofferenza, i dubbi e le trepidazioni di Giovanni hanno la sua voce, che però giunge a noi smorzata, raccontata dall’esterno in virtù non solo della prospettiva “oggettiva” adottata da Piersanti, ma ancor più dal fatto di non essere disgiunta, come gli altri sentimenti del resto, dalla minuzia discreta della narrazione degli eventi quotidiani e dei gesti e dei luoghi. La scelta della terza persona, apparentemente tradizionale, che incornicia e dà il tono alla parziale focalizzazione interna laconica come la personalità del protagonista, è funzionale a questa resa. Perfetta, senza sbavature, senza una parola superflua, come avviene in quello che secondo me resta il capolavoro di Piersanti, Luisa e il silenzio.
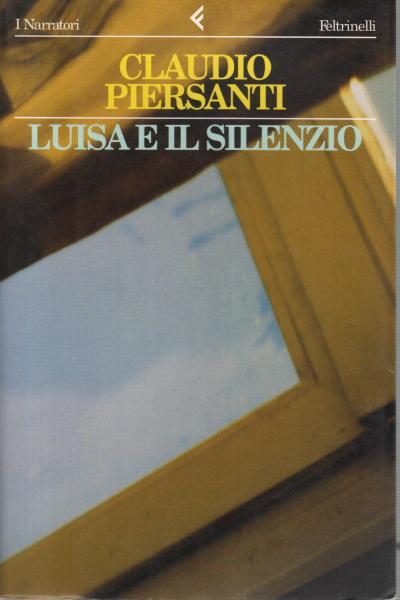
Anche la sintassi contribuisce all’arginamento del sentimentalismo che l’argomento del libro potrebbe favorire, e del lirismo che pure è presente, quasi reticente ma intenso, specie quando lo sguardo si dirige sulla natura. Il ritmo è scandito da frasi brevi, ma non elementari se non nel senso di essenziali; la scarsità di concatenazioni e di subordinate anziché sintomo di piattezza o ricerca forzata di linearità, è l’effetto primario di uno stile ellittico e direi concentrato, dove il tasso di taciuto (di silenzio) si arricchisce di tutte le relazioni possibili. Il risultato è una scrittura piana, ma tutt’altro che semplice. La lettura richiede una certa lentezza: impossibile pattinare da una frase all’altra, correre a ciò che succede, perché ciò che succede non è tanto, e in mezzo c’è tutto. Invece di un flusso il lettore si trova di fronte a un susseguirsi di monadi, ciascuna conclusa e perfetta, che spetta a lui mettere in relazione, ma in modo autonomo, richiesto, e quasi imposto, dal ritmo stesso della narrazione, pacato e implacabile, che nella elementarità della sintassi semplice e perlopiù paratattica trova l’impulso, anziché l’ostacolo. Come se la punteggiatura avesse una sua temporalità continua, diversa da quella pausata o anche sincopata che a volte la brevità produce, un suo armonico respiro privo di sbalzi e cadute.
L’assenza di commenti, e di ogni dimensione meta- tipica di tanta narrativa modernista e contemporanea, non esclude, per esempio, la possibilità di una lettura in tal senso almeno per alcuni aspetti della figura del protagonista. Infatti è difficile non leggere nella professione di tipografo del protagonista, così ossessionato dalla correttezza dei testi e dalla perfezione dell’impaginazione un’immagine dello scrittore, non per forza autobiografica. E nel suo licenziamento a causa delle innovazioni tecnologiche, così come nel suo declassamento fino all’abbandono della piccola bottega tipografica artigianale un'allusione alla perdita di ruolo e di significato dello scrittore.
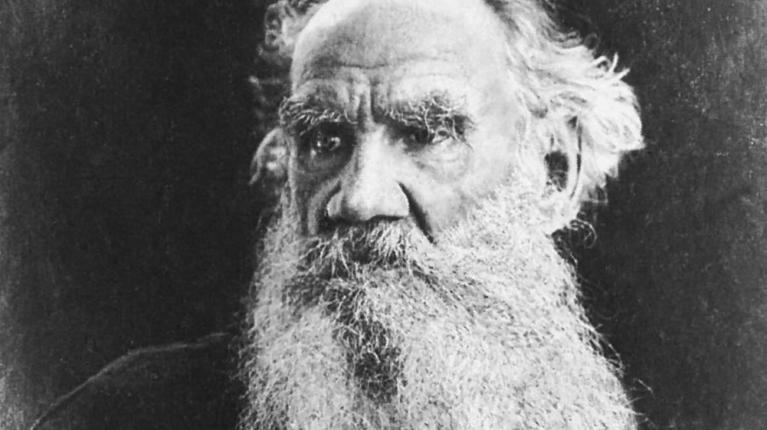
E ancora nel quasi religioso, monacale, lavoro di copiatura di uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale l’allusione, più che quella esplicita alla devozione per la bellezza che ogni attività artistica comporta, a quella alla memoria e al confronto con le opere del passato per cui l’agire artistico passa pur senza farne diretto oggetto di riflessione all’interno dell’opera. Giovanni si limita a copiare, Piersanti si confronta. E scrive la storia di un matrimonio per quanto possibile felice. Cosa dichiarata noiosa da Tolstoj, con la sua sentenza diventata cliché universale, come peraltro meritano il suo sensazionalismo e la sete di applausi implicita. (Certo che colpire colpisce, però!)
Piersanti invece con questo libro sembra voler smentire Tolstoj. Quella che racconta è la storia di una coppia felice, una coppia piccolo borghese, presa nella sua medietà e mediocrità (nell’eccezionalità che in ogni medietà si cela e che a nessuno viene in mente di cercare), senza nessuna inflessione di ironia, da cui del resto Piersanti si guarda bene in tutte le sue opere, per quanto crudeli possano essere le storie che racconta: gli ideali di fusione che la coppia di sposi persegue e nel complesso raggiunge, la creazione di un piccolo mondo chiuso, a sé (amore, casa, famiglia, lavoro, svaghi, ambizioni, con poche amicizie fedeli e di lunga data), autosufficiente (persino la lontananza della figlia che ormai vive all’estero è vissuta senza patemi: così è, così stanno le cose...), non hanno nulla di meschino, sono ciò che hanno deciso insieme di perseguire e che fanno di tutto per raggiungere, in modo quieto, nonostante amarezze anche intense, come il licenziamento di Giovanni da un lavoro in cui aveva riposto tutte le sue ambizioni e la malattia di Giulia. Giovanni e Giulia sono la coppia scissa di Aristofane che ha avuto la fortuna di incontrarsi e non ha nessuna intenzione di lasciarsi più dividere, che trova modo di vivere questa fusione pur mantenendo ciascuno la propria personalità, fino all’arrivo di quello che Giovanni chiamerà Vronskij, e più ancora dopo, superata la separazione: le prove che ne scaturiscono, e la sua minaccia sempre incipiente e che prima o poi tornerà (ma non è detto che dovrà essere una catastrofe a cui passivamente soccombere), quando le sue metamorfosi a partire da quella iniziale della gelosia riveleranno il suo vero volto di morte con la paura che essa comporta, alla fine verranno riconosciute e affrontate, non insieme, perché infine ognuno deve affrontarle da solo, ma uno accanto all’altra, ciascuno sapendo e accettando la presenza dell’altro.
C’è sempre un Vronskij che mina la felicità. A cominciare dal Vronskij insito nell’idea stessa di felicità. Non esiste la famiglia felice, soltanto un osservatore superficiale ne vede qualcuna, e la vede perché vuole vederla, per invidia, per sarcasmo, o per darsi un’illusione, e un obiettivo. Ogni famiglia è infelice, in diverso grado. Per fortuna esiste l’oblio. La cancellazione, la tolleranza, la pazienza. E pure l’amore: la nebulosa di cose che questa parola contiene, e che quindi è opportuno evitare. (Evitare di nominare, beninteso...)
Soltanto i romanzieri dell’800, e i loro eredi odierni, fanno ancora queste distinzioni. Non si occupano di quelle che a loro sembrano famiglie felici perché appunto le trovano monotone, cioè senza niente di particolarmente attraente da raccontare, e pertanto, più o meno apertamente, le disprezzano. Non c’è luogo, in esse, per le emozioni forti, che bramerebbero i lettori, o loro stessi che non sanno scrivere altro. Ma ogni giorno è un susseguirsi di colpi di scena. Ogni giorno c’è il dolore; e la morte all’orizzonte. Ogni giorno qualcosa manca, affanna, preoccupa, si incrina e minaccia di spezzarsi e difatti si spezza, anche nelle relazioni cosiddette felici. Anche senza fare troppe scenate o clamore. Senza altro rumore che non sia quello avvertito da colui o coloro per i quali quella cosa, minima o grande, si spezza, da colui e coloro che sono incrinati e spezzati.

C’è la sofferenza, che spesso resta inespressa e a volte si nasconde per volerla risparmiare all'altro, che invece soffre di non poterla condividere e si sente escluso proprio laddove vorrebbe poter far sentire la propria presenza, intervenire, alleviare se non curare. Non tutto può essere detto, eppure è proprio questo silenzio a essere più doloroso. A escludere la comunanza, l'intimità da cui pure era nato. E chi così esclude, al pari di chi è escluso, come Giulia e Giovanni, soffre di questa esclusione e non sa come venirne a capo, e in tal modo approfondisce tanto l’esclusione che il dolore. Allora cerca nel silenzio qualche possibile spiegazione, ma nessuna è all’altezza né di chi tace e se ne è andato, né di chi non fa che pensarci e vuole un senso per l’abbandono. Tanto più che, come Piersanti scriveva già nel precedente, potente, La forza di gravità, “non ti abbandona mai uno soltanto, a un certo punto ti abbandonano tutti”. Ma poi “[d]opo l’abbandono viene la forza”. A volte, quanto meno. Perché anche qui risiede la possibilità, se non di una salvezza, almeno di una diversa, nuova, e forse più matura, condivisione, senza parole, dopo che le poche indispensabili saranno state dette, ancora inquieta, ma per l’altro, non per sé, quasi serena, accettata. Piersanti racconta questa storia. Il suo libro è bellissimo.









