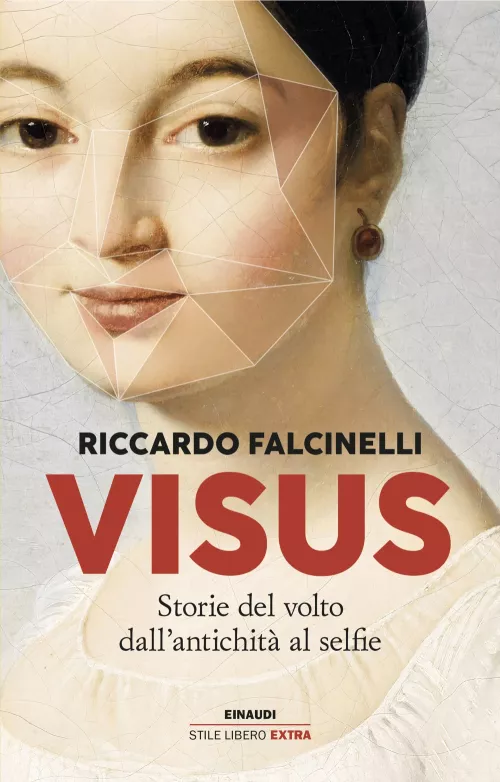Come fare cose con le facce
Di tutte le parti del corpo umano, la faccia è la più immediatamente visibile benché sempre sottratta al nostro sguardo. Se il resto del corpo lo posso in parte vedere, quella sporgenza lì, così importante perché mi distingue e mi identifica, resta per me invisibile, un punto cieco esposto allo sguardo degli altri. Il viso, come indica l’etimo dal latino visus, è sempre inevitabilmente ciò che è visto, un oggetto che prende forma e significato solo nel faccia a faccia con altri esseri umani, come inter-faccia.
Il tema non è nuovo, anzi, su questa peculiarità anatomica del corpo umano, tanto ovvia quanto gravida di implicazioni filosofiche e sociali, si ragiona ormai da tempo. Ma da essa sta emergendo con forza, in tempi più recenti, l’idea che la natura del volto umano dipenda allora anche dalla miriade di artefatti, di tecniche e pratiche culturali con cui da secoli trasformiamo i visi in oggetti e facciamo cose con le facce: le costruiamo, le usiamo, le rappresentiamo, le mettiamo in ordine con la cosmesi o le rendiamo leggibili come dei testi, inventandoci su di loro (e con loro) storie sempre diverse. Dipende insomma dal fatto che il volto, come ci ha ricordato Hans Belting in Facce (Carocci, 2014), è innanzitutto un’immagine che appare nel medium del corpo, sulla superficie della pelle, e genera immagini in altri media che continuamente ne ridisegnano i contorni e i significati: dalle maschere alle monete, dai disegni ai dipinti alle sculture, le bambole, le pellicole fotografiche e cinematografiche, fino ai raggi X o al selfie dello schermo digitale, la storia delle facce è una questione di immagini e di immaginari. Oggi che siamo sommersi da volti artificiali, vuoi per chirurgia estetica, vuoi per il proliferare di avatar, di app che ci regalano effetti di metamorfosi facciale (morphing), o ancora di visi inesistenti generati dall’I.A., il punto non è allora restituire al volto la sua immagine ‘naturale’, libera dagli artifici della tecnica. Tutto al contrario: se l’umano ha accesso alla faccia solo tramite la mediazione di un oggetto – specchio, fotografia, schermo – anche il volto naturale va ripensato in relazione ai suoi artefatti. Marion Zilio (in Faceworld, 2018) dice nell’interfaccia con le sue ‘protesi’, nel senso letterale di ciò che è posto di fronte a noi (prothesis) e serve a colmare la nostra mancanza, ricordandoci che la faccia, come vuole l’etimo da facio, è sempre qualcosa che si fa.
In un volume da poco uscito in libreria, Visus. Storie del volto dall’antichità ai selfie (Einaudi, 2024), Riccardo Falcinelli mette alla prova questa nuova prospettiva con un libro che sollecita il nostro visus, termine che nel linguaggio medico indica anche la capacità dell’occhio di percepire i dettagli. Lungo le 514 pagine del libro scorrono oltre 600 immagini di facce, collocate per lo più in testa al foglio e prive di margine superiore. Sono dettagli di volti che arrivano dal culto, dalle arti, dalla scienza e dalla medicina, dalla fotografia, dal cinema e dai fumetti, dai videogiochi, dalla pubblicità, dagli schedari di polizia, dai sistemi di sorveglianza. Sono prive di didascalie (che ritroviamo in fondo al volume insieme a una vasta bibliografia che raccoglie più saperi) perché ciò che conta di queste immagini non è tanto l’artefice o il soggetto raffigurato – il ritratto o il volto di … – quanto la maniera in cui le facce si comportano come oggetti visuali. Conta come sono costruite, inquadrate e messe in posa, come si atteggiano o orientano lo sguardo, di che materiale sono fatte, quali tipi umani mettono in vista e quali cancellano. O ancora se hanno una vita sociale e possono agire, prendere corpo in un medium ed essere trasportate come in un quadro, circolare come mass media su una moneta, essere tenute in una scatoletta come una fotografia, oppure condivise con gli amici come le prime foto-tessera da cartolina di Disdéri, le antenate dei selfie sui social. Falcinelli libera insomma i ritratti dalle cornici, materiali e di senso, in cui siamo soliti inquadrarli e li rimette in moto come immagini di faccialità, testimonianze visive del nostro millenario rapporto con i volti artificiali. Nati non per essere contemplati, come accade quando andiamo a una mostra o a un museo, ma indossati, “utilizzati, consumati, al pari di qualsiasi altro oggetto materiale”.
Ne nasce un volume molto originale, e a più entrate. Visus è un Odradek mobilissimo e per certi versi difficile da catturare tanti sono i fili che lo compongono e vi s’intrecciano. E, soprattutto, è un libro che fa molte cose con le facce. Esplora ad esempio un territorio immenso ed eterogeneo di artefatti, dai ritratti affissi millenni fa sulle mummie ai selfie di oggi, analizzando i meccanismi figurativi che presiedono all’invenzione delle facce, che cosa rende un volto più o meno realistico, pensoso o idealizzato, l’effigie di un tipo o la traduzione mimetica di una persona. Spesso è un piccolo artificio tecnico a fare la differenza, un riflesso dell’occhio o una minima rotazione del volto, sufficiente però a dare l’impressione che l’immagine ci stia guardando. Migrando di epoca in epoca e di supporto in supporto, le immagini delle facce possono cambiare aspetto e funzione, diventando talvolta oggetti politici, come i ritratti di Stato, oppure incarnandosi su supporti sempre più mobili. Accade per esempio con la tela introdotta in pittura alla fine del XIV secolo, che presta alla faccia un corpo per muoversi più facilmente e assolvere ai suoi compiti performativi, sostituendo la persona in caso di “pratiche contrattuali” come una successione dinastica o un matrimonio. Qui si comprende meglio perché, scrive Falcinelli, è l’uso che fa il ritratto, e “che un volto artificiale è una ‘cosa’ concreta che può essere usata in un certo modo”. Persino magico: strappereste mai la foto di vostra madre? si chiedeva già Edgar Morin in Il cinema o l’uomo immaginario (1956), suggerendo che gli incantesimi delle facce non hanno mai smesso di funzionare neanche per noi.
Di dettaglio in dettaglio, dalla tela alla fototessera allo schermo filmico o digitale, e ragionando insieme agli artefici che le hanno ideate, Visus smonta un’infinità di facce d’invenzione, e da una prospettiva ravvicinatissima le osserva come dispositivi tecnici, estetici, politico-sociali, mediali o antropologici. Certo, Falcinelli organizza il suo materiale prismatico per categorie – la somiglianza, le rappresentazioni, le espressioni, l’uso delle immagini, i canoni … – da osservare ogni volta sotto la lente di discipline plurime, fra cultura visuale, psicologia della percezione, semiologia o (neuro)scienze. Ma parte del fascino di questo volume consiste nell’esercizio dello sguardo, lento e profondo, sulle singole immagini, sulle loro storie e sugli echi visivi che spesso le correlano nel tempo. Dagli accostamenti un po’ warburghiani dei visi sulle pagine del volume, vediamo infatti che esistono formule antichissime e mai dimenticate che connettono la grande arte ai fumetti o alle icone della cultura di massa. Un piccolo ritaglio dell’occhio, che finge un’interiorità insondabile, apparenta un busto romano a Betty Boop, mentre il volto-logo dell’imperatore Augusto, progettato ad hoc con tanto di caratteristico taglio di capelli, prefigura già i volti iconici e ‘brandizzati’ del nostro panorama mediatico. Anche le tecnologie analogiche o digitali assorbono e riformulano le pratiche ritrattistiche del passato. Il volto inquadrato dalla pittura migra nel cinema, che a sua volta lo ritaglia e lo reinventa con la tecnica del primo piano. I ritratti fotografici compositi, creati nell’Ottocento da Francis Galton sovrapponendo visi reali fino a farne un (inesistente) volto-tipo – l’ebreo, lo studente medio americano, ecc. – preparano i volti deep fake generati dall’I.A. Che tanto ci sconcertano pur ricordando le immagini ‘acheropite’, ossia letteramente ‘non fatte da mano umana’, a cui da secoli attribuiamo un’origine miracolosa, pari a quella del volto di Cristo impresso su un sudario. Falcinelli mostra insomma che il volto artificiale è cosa antica, e persino i nostri visi stilizzati dai filtri digitali replicano ancora il gesto immemore dell’artefice che allungava il collo di Nefertiti, idealizzandone il volto.
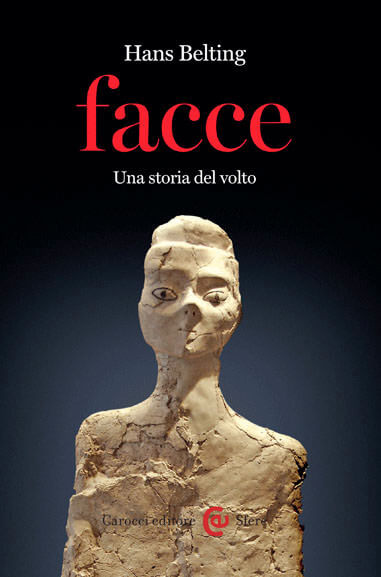
Muovendoci a zig zag attraverso i secoli e i media come fa questo atlante, il confine tra volti naturali e artificiali sfuma però continuamente, e la naturalezza o meno di un viso appare sempre più come qualcosa che si fa, l’effetto di particolari tecniche figurative e mediali che plasmano e riplasmano l’immagine della faccia. Certi volti, scrive Falcinelli, “possono nascere solo in certe epoche, proprio per ragioni ‘materiali’”: la diffusione degli specchi a partire dal Seicento regala a tutti l’immagine della propria faccia; con la fotografia ciascuno scopre di possederne una anche da mettere in vetrina; e il cinema te la fa vedere per la prima volta con una mobilità così scioccante che i primi film sono puri spettacoli di facce, nati dal piacere di scoprire che un gioco di muscoli e smorfie può formarti e deformarti il viso, proprio come accade oggi con i selfie modificati dai filtri. Ma ogni artificio o tecnica promette, a modo suo, una trasparenza sul volto naturale che in realtà non si realizza mai, cambia solo il tipo di mediazione. Così il cinema, col trucco del close up, porta la faccia così vicina che sembra di potervi cogliere l’essenza stessa dell’umano, scatenando tra i filosofi una mistica del volto. La fisignomica, invece, spezzetta graficamente l’immagine della faccia in tanti piccoli indizi dell’anima, nella convinzione che l’interiorità invisibile parli senza filtri nei micromovimenti delle sopracciglia o nella curva di un naso. Un paradigma che la chirurgia estetica contemporanea non abolisce ma semplicemente rovescia e trasferisce sul corpo, visto che adesso ognuno può ricrearsi l’immagine della faccia che più sembra corrispondere al suo interno, magari quello percepito nella propria foto sullo smartphone, ossia tramite la mediazione informatica. Oggi che psicologi come l’americano Paul Ekman hanno rinverdito gli studi di Darwin sull’espressione delle emozioni, fornendo materiale tanto alle faccine delle emoticon (icone, appunto, delle emozioni) quanto agli algoritmi di riconoscimento facciale, c’è da chiedersi se ad alimentare le ‘macchine che vedono’ non siano allora anche gli stereotipi facciali elaborati in secoli di testualizzazione fisognomica del volto. È passato quasi mezzo secolo da quando Deleuze e Guattari (in Millepiani) descrivevano la faccia umana come una superficie – tratti, linee, geometrie – o una carta da poter avvolgere in diversi volumi: un sistema muro bianco/buco nero con il quale produrre gli effetti di ‘viseità’ utili ai poteri o ai desideri della Storia. Al fondo del volume di Falcinelli e delle sue storie del viso c’è anche questo. Non solo le infinite permutazioni dei volti artificiali, ma i modi in cui la cultura ha costruito la natura del viso umano, le nostre stesse facce come artefatto.
Dagli studi delle neuroscienze e dell’antropologia evolutiva, oggi sappiamo che per gli umani le facce sono un oggetto particolare e saliente, che siamo ‘precablati’ per riconoscerne la configurazione: bastano due pallini neri affiancati in orizzontale su una forma qualsiasi che subito essa si anima e sembra guardarci, tanto che rispondiamo a oggetti facciomorfi artificiali – una bambola, un viso di fantasia – come fossero reali, o addirittura proiettiamo volti anche là dove non ci sono, nelle nuvole, nelle macchie sui muri, sulla faccia di Marte e persino nel cibo. È il fenomeno dei pareidolia, le immagini illusorie che ritroviamo anche nella cosiddetta ‘arte dei folli’ che disegnano “come se il foglio di carta fosse già impregnato di visi” (Michel Thévoz); e forse persino al cuore della retorica antica nella figura della prosopopea, l’arte di fare una faccia – un prosōpōn, appunto – da attribuire ai defunti o agli esseri non umani. Falcinelli spiega che non si tratta di “un tipo di illusione ottica, ma di una condizione strutturale della visione, il frutto di una precisa predisposizione biologica”. Eppure cosa vedo in una faccia non è mai solo una questione di neuroni. Non solo un viso è mediato dai miei affetti o pregiudizi sociali, da come decifro le sue intenzioni o emozioni, ma il volto che abbiamo è sempre, inevitabilmente, quello che facciamo, un’immagine artefatta da tecniche facciali anche banalissime come regolare la lunghezza di una barba o mettersi un rossetto, al punto che persino la neutralità arriva a funzionare come segno della neutralità. Dipingersi il volto è stato, probabilmente, il primo gesto artistico dell’umanità, e da allora l’interfaccia con le nostre protesi non è mai cessata: “la fisionomia che ci ha donato la biologia si intreccia sempre a dei lineamenti culturali”.
Continuiamo perciò a metterci in posa in una fototessera adottando l’antica solennità del viso frontale, il typos hierós un tempo riservato ai ritratti di dei e sovrani, che insieme al profilo abbiamo ereditato dalle primissime ‘tecniche’ di riproduzione dell’immagine corporea, il riflesso e l’ombra, e dai loro miti, Narciso e Cora. È con questa frontalità rigida, ufficiale e senza tempo che la fotografia ottocentesca fa entrare le nostre facce nell’archivio della moderna burocrazia, il panopticon che non a caso riunisce la coppia frontalità-profilo nella foto segnaletica, quella della faccia da ‘profilare’ e schedare. È lì che le nostre facce iniziano a trasformarsi in ‘dati’ da immettere nel flusso della contemporanea “società facciale”, per dirla con Thomas Macho, nella quale domina la pratica del self-design e il volto si è fatto merce di scambio e nodo della comunicazione. Oggi che la foto segnaletica di Trump – con posa frontale e faccia torva fatta aggrottando, come da copione, le sopracciglia – si è convertita nell’immagine ufficiale del Presidente sovrano, si avvera la profezia di Warhol sugli ‘uomini più ricercati’ (Thirteen Most Wanted Men, 1964), sulla faccia che infine ha assunto il desiderio del corpo sociale. C’è una strana circolarità in queste forme che sopravvivono attraverso continuità e fratture, risignificandosi continuamente. La stessa che Falcinelli nota nella mania esplosa in rete di ricostruire col digitale le sembianze dei propri cari scomparsi, o riportare in vita con l’intelligenza artificiale attori morti da tempo: “l’umanità ha iniziato a produrre facce artificiali per mantenere un legame con chi non c’era e, in un certo senso, è come se l’inconscio tecnologico volesse tornare lì”. Visus è allora anche questo, un teatro della memoria dal quale ripartire per provare a darci un’altra faccia.