Dizionario Manganelli 3. Fantastico
Parlare di ‘fantastico’ in rapporto all’opera letteraria di Manganelli ha quasi il sapore di un’operazione tautologica, pleonastica, non tanto perché le sue pagine siano piene di voci dall’inferno, ombre, fantasmi, ‘nonluoghi’ o perché con la morte intrattengano un’intrinseca frequentazione ma, come emerge dai suoi numerosi autocommenti, perché ‘fantastico’ e letteratura per l’autore di Hilarotragoedia esprimono concetti in buona parte sovrapponibili, avendo molto in comune: l’ombra, il rovesciamento semantico, l’invenzione, il ‘nonessere’, nel senso naturalmente che Manganelli dà a tale condizione di non vita che è, appunto, la speciale natura del discorso letterario. La letteratura, quella vera infatti, per Manganelli inizia laddove la vita compie il suo passaggio al nulla, inteso come squisito regno dell’impossibile, della coincidentia oppositorum, del sogno e delle visioni. Ed è da queste parole indiziarie che è bene partire, inseguendo i percorsi labirintici, le traiettorie sghembe, le divagazioni caotiche sì ma non prive di concatenato ragionamento del felice discorrere manganelliano sulla letteratura.
Con una battuta potremmo liquidare la questione dicendo che il ‘fantastico’ in Manganelli non esiste. Ma sarebbe come affermarne per capovolgimento di senso l’esistenza, dal momento che la letteratura è fantastica tutta. Lo afferma lui stesso recensendo sul «Corriere della Sera» nel 1985 due antologie: Racconti fantastici dell’Ottocento, a cura di Enrico Ghidetti e Notturno italiano. Racconti italiani del Novecento, a cura di Ghidetti e Lattarulo: «Mi sbaglierò, ma la mia impressione è che la letteratura sia naturalmente fantastica; la letteratura che si fantastica realistica, che crede di misurarsi con una realtà che attende solo di essere interpretata, questa è l’eccezione, lo scandalo» (p. 268).
Come arriva Manganelli a una conclusione del genere? All’epoca di questo articolo sono passati vent’anni da Hilarotragoedia (1964), dai saggi raccolti in Letteratura come menzogna (1967) e da Nuovo Commento (1969), cioè dalla fervida stagione di scrittura inventiva – all’incrocio tra favola allegorica, trattato, antiromanzo – e di intensa collaborazione con editori (Garzanti, Adelphi, Einaudi) e giornali (“Il Giorno”, “Il Mondo”). A ciò va aggiunta l’attività di traduttore che affonda le sue radici nella preistoria dello scrittore, agli anni 1945, quando appena laureato Manganelli traduce i classici inglesi e americani, Blake, Pater, Keats, Yeats, Poe, e anche Thomas De Quincey (1785-1859), alle cui Confessioni di un mangiatore di oppio lavorò con furore e passione nel 1947, approdando a una traduzione che però non fu mai pubblicata e, sfortunatamente, come ricordano Viola Papetti (2000) e Salvatore S. Nigro (2011), andò perduta.
Ne resta il risvolto, eloquente riflesso delle idee che Manganelli andava maturando sulla natura e la vocazione del linguaggio letterario come «salda struttura capace di dare organizzazione intellettuale a ciò che per sua natura vorrebbe restare nel limbo psicologico della pura allucinazione» (pp. 355-356). Nell’autore dell’Assassinio come una delle belle arti Manganelli ritrovava la «prosa artefatta, intellettuale, lavorata, piena di ambagi, di indugi, deliziosamente articolata, di una complessità intellettuale quale non si conosceva più dal seicento» (p. 355). Nella scrittura come retorica di De Quincey Manganelli riconosceva la propria idea stessa di letteratura come mirabile congegno di suoni, di metamorfosi semantiche, di callide torsioni sintattiche, di innaturalità della costruzione: «Riconosciamo lo scrittore delle Confessioni, che concepiva i suoi racconti come orazioni pronunciate di fronte a una folla di fantasmi» (pp. 5-15).
Come ricorda Federico Francucci (2018), i quaderni critici recano traccia il 3 luglio 1953 di un lungo appunto derivato dalla lettura dell’Assassinio, che può considerarsi un vero e proprio incunabolo del saggio del 1977, nel quale emerge già perfettamente espressa la prospettiva estetizzante dell’amateur. Quello che più ci interessa è la concezione della parola o della proposizione scritta come procedimento enigmatico e fantasmatico. De Quincey, scrive Manganelli nell’Introduzione del 1977, «fu “scrittore” nel senso più assolutamente letterale: era un essere fondamentalmente umano che sapeva “scrivere” – non raccontare, non pensare, non argomentare, non concludere, ma “scrivere”, disporre e articolare proposizioni in modo che esse esistessero, fossero quel fantasma drammatico ed enigmatico che è una proposizione “scritta”, da due a trenta parole che hanno il marchio di Caino, il segno della “letteratura”» (pp. 5-6).
Se a tale altezza di anni l’idea di letteratura in Manganelli è già quella a noi nota dalle opere maggiori, non c’è da stupirsi che venga ribadita con forza trent’anni dopo a proposito delle due antologie, sopra citate, di racconti fantastici di scrittori italiani, «una razza – scrive – che in Italia non ha mai avuto vita generosa» (p. 265). Qui il ragionamento si fa critico e teorico al tempo stesso. Per avere un racconto ‘fantastico’ non bastano i fantasmi, i vampiri e il corredo di apparizioni di spettri, come avviene nei racconti del ‘del mistero’ del ‘corrivo poligrafo’ Capuana. Serve piuttosto un perfetto e stravagante sistema di gioco verbale, come avviene per esempio in alcuni racconti di Arrigo Boito, Faldella o Ambrogio Bazzero, nei quali l’effetto fantastico risulta da una «generale, pervasiva, diffusa unheimlichkeit, una perturbazione dell’anima, inconfondibile» (p. 267).
E se tanta letteratura dell’Ottocento in Italia soggiace all’ipoteca crociana secondo la quale: «L’anima italiana tende, naturalmente, al definito e all’armonico» (p. 266), non così si può dire del Novecento che ha avuto scrittori quali Landolfi, Calvino, Bontempelli, Savinio che hanno scritto «libri stupendi per lievità e giocosa fantasticaggine» (p. 268). Tra i nomi ricordati, quello di Bontempelli non va trascurato perché da Manganelli è associato sì a un racconto di rara grazia come La vita intensa ma soprattutto alla traduzione di quel libro «totale, da cui non si esce», «esempio perfetto di un sistema che per semplicità diremo fantastico» (ibidem) che è L’Asino d’oro di Apuleio. Fantastico, fantasticaggine, filastrocca, chiacchera svagata rischiano, a questo punto, di confondersi nell’unica salda radice che le tiene insieme: la loro esistenza esclusivamente verbale. Il ‘fantastico’ è per Manganelli struttura linguistica, artificio retorico del rito della parola, una cerimonia rigorosamente esatta quasi come la letteratura, al punto da concludere tautologicamente che non c’è letteratura che non sia naturalmente fantastica.
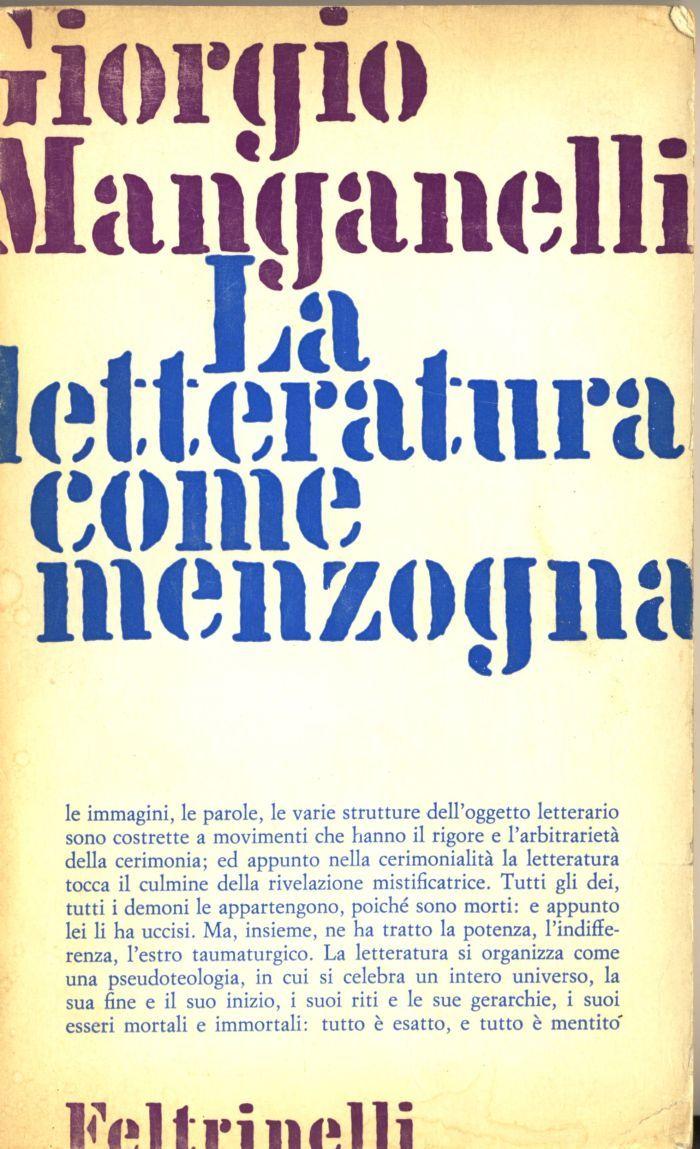
Raccolti nel 1967 sotto il titolo La letteratura come menzogna, i saggi composti tra il 1961 e il 1966 rappresentano un itinerario eccentrico nella biblioteca di classici inglesi di Manganelli e nella sua personale inclinazione estetica. Il viaggio inizia con lo squisito ritratto del maestro dell’errore esatto e della deviazione, Ronald Firbank (1886-1926), e si conclude con il saggio eponimo del 1967, che suggella la raccolta con un’indelebile impronta teorica. Al centro, per lo più datati tra il 1965 e il 1966 e suddivisi in due parti, gli scritti dedicati a E.T.A. Hoffmann, L. Carroll, S. Beckett, C. Dickens, E.A. Abbott, H.G. Lovecraft, R.L. Stevenson, W.B. Yeats, E. Wilson a cui Manganelli ne dedica due di cui uno risalente al 1958, e a T.L. Peacock, il più antico della serie (1954).
Non c’è pagina in cui l’opera dello scrittore analizzato non sia ammirata per la precisione di incastro e il disegno araldico, per la naturale vocazione al falso e all’artificio. In particolare, nel saggio intitolato Letteratura fantastica e dedicato al Vaso d’oro di Hoffmann, Manganelli pronuncia la teoria che «Il fantastico, intento a pronunciare l’universo, è il creatore di segni, il raccoglitore di esorcismi, il trascrittore delle formule efficaci, il lessicografo che diligentemente elenca le cose inesistenti» (p. 57). Suo contrassegno formale è la sua natura essenzialmente linguistica, fatta di aditi segreti, camminamenti sotterranei, precipizi del senso, sdoppiamenti, riflessi. C’è solo un modo per percorrere e descrivere il mondo fatto di labirinti del nulla, ed è tradurlo in speculari mappe di segni. Il regno del ‘fantastico’, scrive ancora Manganelli, è la dimora di ciò che nel mondo ‘reale’ è bandito: la diserzione, la menzogna, la morte, la formula cerimoniale, lo specchio ustorio e indecifrabile cui si oppone il nostro sguardo mortale.
Si capisce benissimo, allora, la predilezione di Manganelli per quella «favola ctonia e vittoriana» che è Alice nel paese delle meraviglie e Alice attraverso lo specchio (p. 86). L’opera di Lewis Carroll è la quintessenza del linguaggio come infinito gioco combinatorio di possibili, come universo di creazioni speculari, scatole ribaltabili, dove la coscienza del carattere arbitrario del linguaggio permette di sperimentare: «nuove leggi combinatorie, destinate a celebrare totalmente quel rigore e quell’arbitrio […] Carroll ci mostra di quali sconcertanti cunicoli, di quali arguti labirinti e insidiose macchinazioni sia capace il linguaggio» (p. 89).
Rigore nell’arbitrio, combinatoria dei possibili e coesione strutturale sono tre ingredienti ricorrenti nella letteratura che per Manganelli può meglio definirsi ‘fantastica’. Sistemi formali di perfetta coesione, opere come universi da cui non si esce, ‘nonluoghi’ verso cui il movimento affabulatorio del narratore corre vorticosamente, felice di cadere nella macchina retorica di storie che si duplicano e si biforcano secondo un calcolato artificio.
Radicalmente allergico alla trama, a qualunque forma di storia utile, necessaria, moralmente orientata, Manganelli rivendica alla letteratura lo spazio dell’infinita affabulazione, del felice vanverare con parola onomatopeicamente eloquente, dell’oscurità delle tenebre infere dove il Grande Mentitore ha sede e regno. La letteratura, infatti, è quell’infinito disegno araldico dominato dalla parola stemma, un universo di impossibili, coeso e impeccabilmente compatto e organizzato.
Attività immorale e cinica, dissacrante e perversa, la letteratura è scandalo inesauribile. Adunaton, come la definisce nel saggio eponimo del 1967, un impossibile, la letteratura, asociale e anarchica sfiora l’utopia e come il fantastico svela la natura radicalmente eversiva del linguaggio che la fa esistere. Lo scrittore non ha estro o fantasia. Ubbidisce fanaticamente alle regole che sottendono alla creazione letteraria come gioco di illusionismi e magmatici vortici di senso. La sola letteratura che possa vantare questo nome è quella che abita nel sottosuolo del mondo; quella labirintica fatta delle parole ‘botole’ quelle parole, cioè, che ne schiudono altre, che aprono a un ‘precipizio di altre invenzioni’ (p. 61), così che «per leggere questo infinitamente riscritto palinsesto universale, dobbiamo farci talpa, rettile, formicaleone, e scovare tane, scavare cunicoli, finché tutta la creazione sia un prezioso e fragile termitaio di parole» (ibidem).
Se le cose stanno così, non ci stupisce che a generare Pinocchio: un libro parallelo sia stata la fiaba del pezzo di legno diventato bambino, ossia il racconto, come in tutte le fiabe che si rispettano, di una metamorfosi, di un passaggio di soglia, l’allegoria della vicenda umana dal punto di vista dell’errore, della morte necessaria alla nascita, prolifico ordigno inventivo. Un capolavoro di creazione affabulatoria che scaturisce dal seno stesso alla parola narrativa, un caso perfetto di letteratura al quadrato, fiorita per gemmazione di folgoranti concatenazioni verbali ma, al contempo, un discorso metaletterario in cui, come avviene in tanti altri casi, lo scrittore si fa teorico e trattatista.
Alla fiaba, infatti, l’opera di Manganelli e il suo infero mondo di letture e di immaginazione, è visceralmente legata. Lo è per ragioni autobiografiche e per gusti e affiliazioni di scrittore. Nella breve ma illuminante prefazione al capolavoro di J.M. Barrie, Peter Pan nei giardini di Kensigton (uscito la prima volta sull’“Europeo” del 28 dicembre 1981 come recensione del libro di Barrie edito lo stesso anno per Rizzoli con il titolo Peter Pan amore mio) cogliamo con luminosa vividezza i legami profondi che Manganelli intrattiene con la storia del ragazzino che non vuole crescere: «J.M. Barrie, come Lewis Carroll, era un uomo solitario, un emarginato psicologico, e non è un caso che i loro libri “per l’infanzia” abbiano solidi fondamenti nell’angoscia, nel mito puerile di “essere perduti”, perduti una volta per tutte all’atto della nascita, segnati di una perdizione che la madre potrebbe stornare, ma non lo farà. […] Alice e Peter Pan non sono solo due classici dell’angoscia dopo il parto, ma sono due testi diversamente ma intensamente funerei» (pp. V-VI).
Le radici della fiaba sprofondano nell’oscurità del ‘mondo di sotto’, dove si azzerano i contorni netti delle cose, i territori sconfinano gli uni negli altri in perturbanti ibridismi e dove la morte non è un fantasma pauroso ma una possibilità dell’esistenza. Non aveva del resto teorizzato il trattatista anonimo di Hilarotragoedia che l’uomo, ‘adediretto’, ha naturale vocazione discenditiva e che nell’abisso si precipita ignari se vivi o morti? Nel suo esuberante universo verbale convivono, intrecciati singolarmente, il fantastico e il fiabesco come esperienze linguistiche prima ancora che immaginative e narrative.
Manganelli attinge infatti alla memoria archetipica dove si sedimentano immagini ancestrali quali il buio, la caduta, il labirinto, il bosco, e recupera un’autentica verità, e cioè che esiste il mondo oltre lo specchio, dove l’eterno fanciullo Peter Pan vive la vita di un fantasma privo di memoria della vita che ha disertato, un fantasma pietoso che sperimenta l’ambivalente vita delle creature che abitano territori inconciliabili. Sul filo di queste riflessioni, allora si comprende ancora meglio l’interesse di Manganelli per il fiabesco, il notturno, l’infero, l’inquietante mondo infantile e per la teoria junghiana dell’inconscio, per i miti e le cosmogonie, la magia e le metamorfosi che lo avevano appassionato al romanzo di Apuleio almeno quanto ai Racconti di Hoffmann.
Frequentatore dell’Ade, convinto sostenitore della natura discenditiva dell’uomo, Manganelli si serve del fantastico come figura della letteratura, pseudoteologia che inventa cerimonie, finge inesauribili universi, possiede e governa il nulla, lo ordina e ce ne restituisce l’unica forma possibile, «la distratta ironia di uno stemma» (p. 223).
Per saperne di più
G. Manganelli - La letteratura come menzogna, Adelphi 1985.
G. Manganelli - Laboriose inezie, Garzanti 1986.
G. Manganelli - Introduzione a T. De Quincey, L’assassinio come una delle belle arti, TEA, 1990.
G. Manganelli - Peter Pan amore mio, Prefazione a J.M. Barrie, Peter Pan nei giardini di Kensigton, con uno scritto di Manganelli e intr. di L. Scarlini, Einaudi, 2008.
F. Francucci, Tutta la gioia possibile. Saggi su Giorgio Manganelli, Mimesis, 2018.
S.S. Nigro, Il laboratorio di Giorgio Manganelli, in G. Manganelli, Ti ucciderò, mia capitale, Adelphi, 2011.
V. Papetti, Manganelli e gli inglesi, in Le foglie messaggere. Scritti in onore di Giorgio Manganelli, a cura di Viola Papetti, Editori Riuniti, Roma, 2000.
Leggi anche:
Filippo Milani | Dizionario Manganelli 1. Dissimulazione
Chiara Portesine | Dizionario Manganelli 2. Arte









