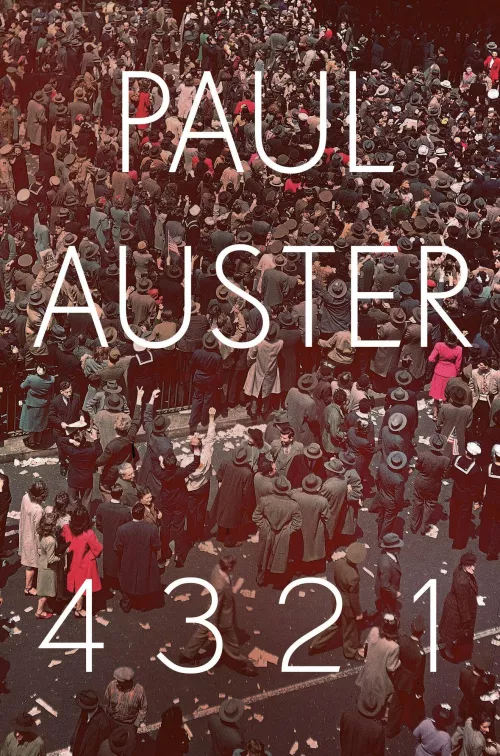Solo un altro romanzo famigliare americano? / Paul Auster, 4 3 2 1
Quando all’età di settant’anni uno scrittore newyorchese (affermato e di talento) pubblica un romanzo atteso (da sette anni almeno) che supera le novecento pagine (ottocentosessanta in lingua originale), è inevitabile che ci si figuri l’avvento di un mastodontico testamento letterario. Eccola, la summa di una carriera quasi cinquantennale, costellata di successi, esperimenti e cambi di direzione anche coraggiosi. (S)fortunatamente, non va sempre così. Di fronte a qualche novità letteraria di alcuni ‘mostri sacri’ della letteratura contemporanea, il lettore si ritrova come Gatsby, barca controcorrente, incessantemente risospinto nel passato; nel passato dell’autore, è chiaro, verso le prime luci di opere meno ambiziose, meno roboanti, forse; ma nel cui ricordo e nelle cui pagine è ancora dolce il naufragare.
Così, durante la lettura di 4 3 2 1 (Einaudi, 2017), non può non venire in mente per ossimoro lo sfrontato sperimentalismo del Paul Auster della Trilogia di New York, l’antipatia felice di quella scrittura anticomunicativa che resisteva ai gusti canonici del pubblico, alle convenzioni del genere spy, alle tentazioni e alle trappole del linguaggio quotidiano, alle utopie della chiarezza e della comprensibilità a ogni costo. Stile limpido, inconfondibile; tuttavia impenetrabile. Primo paradosso. Scrittura che si impose, trovò la propria collocazione, scavò la propria nicchia, a voler minimizzare la sua influenza. Scrittura che ha esaurito la sua carica vitale, che non parla più alla contemporaneità, che si rivelerebbe improponibile nel 2017? Forse, non è detto; certo è che la Trilogia resta ancora insuperata, se messa a confronto con la produzione successiva dell’autore. Scrittura superata, ma insuperata: secondo paradosso.
Di Auster, tutto si può dire tranne che non abbia scritto abbastanza, o non si sia cimentato nei generi più diversi. Per lo scrittore americano, però, la scrittura non è in fondo altro che una forma di autoterapia, una cura necessaria per la vita con cui sanare delusioni e amarezze; strumento sul quale occorre fare cieco affidamento, se si ha a cuore la propria sopravvivenza terrena. L’idea (che proprio gli anglosassoni hanno provveduto a istituzionalizzare persino nell’ingessato mondo dell’accademia) delle humanities come farmaco ha una sua gloriosa tradizione e Auster ne è certamente un esemplare emblematico. Egli è innanzitutto questo: uno scrittore esistenziale, che ha fatto dell’esistenza e dei suoi paradossi la materia prima della propria letteratura; per lenire innanzitutto le proprie ferite, prima che quelle del lettore.
Difficile, difficilissimo tratteggiare i passaggi fondamentali della produzione narrativa di Auster. Una mole enorme di libri, una folla sterminata di personaggi; tonnellate di pagine che ricordano la bulimia creativa degli scrittori di feuilletons ottocenteschi. E oltre alla narrativa c’è molto di più: poesie, saggi, epistolari, sceneggiature. Mi limito a ricordare alcuni elementi che mi paiono fondamentali, anche se spesso tralasciati, della sua lunga, inesausta battaglia corpo a corpo con il mondo della parola.
C’è stato l’Auster del cinema, esperienza sulla quale manca ancora un’indagine all’altezza, benché il confronto molteplice con la macchina da presa, nelle vesti di sceneggiatore, attore e regista, sia sorprendente quantomeno a livello quantitativo. Il valore e l’impatto sul piano esistenziale e creativo di ciò non devono certo esser stati nulli, anche se è complesso, allo stato attuale dell’arte, valutarne l’effettiva rilevanza. Giunse poi l’Auster introspettivo ma ‘impegnato’, post-9/11, del Libro delle illusioni, delle Follie di Brooklyn, dell’Uomo nel buio; carico anche di tematiche sociali e risvolti politici, il suo stile si è man mano ‘depurato’, si è fatto meno oscuro e decisamente più permeabile a un linguaggio semplice, quotidiano, limpido. Rigettati definitivamente gli eccessi e il presunto elitarismo della metanarrazione postmoderna, Auster è ormai divenuto uno scrittore ‘per tutti’. Con meno ambiguità del passato si è concentrato, tout court, sulla realtà del suo Paese e dei suoi simili, sulle orme di un percorso che mi pare essere molto simile a quello intrapreso da Don DeLillo a partire almeno da Underworld.
Frutto diretto di questa ‘democratizzazione’ e di questa svolta realistica nella scrittura di Auster è lo stesso 4 3 2 1. Romanzo famigliare e Bildungsroman al tempo stesso, presenta una trama strutturata attraverso l’accostamento di quattro sliding doors aventi per protagonista Archie Ferguson e le peripezie dei suoi famigliari. Figlio di Stanley e Rose e nipote di emigrati ebrei, Archie vive quattro possibili vite, le cui reciproche differenze dipendono in prima istanza dal successo lavorativo del padre. Novello Highlander, anche degli Archie(s) ne rimarrà in piedi solo uno, come il titolo suggerisce fin dall’inizio. I quattro Archie(s) sono fortemente diversi fra di loro e avranno destini assai divergenti; alcune somiglianze e costanti (come la presenza e l’influenza ossessiva, pur in vesti diverse, del doppio femminile Amy Schneidermann, l’amore per la parola e la scrittura, la rilevanza della figura materna) costituiscono il trait d’union delle diverse identità e il banco di prova delle loro scelte.
Il romanzo non rinuncia a un tocco metanarrativo (il cui effetto si intensifica in chiusura di libro, in conclusione della vicenda di Archie4): Auster gioca con la forma-libro e con la sua materialità, oltre che con le possibilità formali del genere. 4 3 2 1 presenta al suo interno quattro trame parallele, nonché cinque differenti possibilità di lettura. Una lettura lineare dell’opera restituisce le quattro esperienze del protagonista per blocchi cronologici sostanzialmente paralleli; è tuttavia anche possibile leggere singolarmente le quattro storie dei vari Archie(s), procedendo a balzi in avanti nella consultazione del libro.
(Breve nota per gli addetti ai lavori: in 4 3 2 1 si parla molto di letteratura ed è forse uno degli aspetti più interessanti dell’opera, insieme con la sua numerosissima serie di riferimenti intertestuali. Lunghi elenchi di scrittori preferiti e di brani tratti da opere del passato vengono riportati nelle pagine di Auster, mentre gli Archie(s) divorano grandi classici e si ispirano al nouveau roman francese. Per chi fosse interessato a una lista piuttosto esaustiva delle influenze e dei maestri di Auster, 4 3 2 1 si rivela una lettura fondamentale e molto, molto esplicita.)

Auster ammicca spesso al lettore con effetti di mise en abyme e di storie nelle storie; nel corso della vicenda di Archie2 scrive per esempio:
Il fascino dei giornali era del tutto diverso dal fascino dei libri. I libri erano solidi e permanenti, i giornali fragili ed effimeri, prodotti usa e getta che venivano buttati via non appena erano stati letti, per essere sostituiti la mattina dopo, ogni mattina un giornale fresco per il giorno dopo. I libri procedevano dall’inizio alla fine in linea retta, mentre i giornali erano sempre in vari posti contemporaneamente, un guazzabuglio di simultaneità e contraddizione, storie multiple che convivevano sulla stessa pagina, ognuna specchio di una faccia diversa del mondo, ognuna espressione di un’idea o di un fatto completamente slegato da quello accanto, una guerra a destra, una corsa coi sacchi a sinistra […], il giornale del mattino contava inevitabilmente ciascuno di questi fatti tra le sue colonne di inchiostro nero sbaffato, e ogni mattina Ferguson esultava davanti a quel calderone, perché il mondo era così, secondo lui, ribolliva come un calderone, con dentro milioni di cose diverse che succedevano nello stesso momento. (pp. 167-168)
Non molto diversa è anche una riflessione successiva di Archie3:
Ferguson si era sempre sentito dire da tutti che la vita somigliava a un libro, una storia che cominciava a pagina 1 e andava avanti finché l’eroe non moriva a pagina 204 o 926, ma ora che il futuro immaginato per se stesso stava cambiando, stava cambiando anche la sua percezione del tempo. Il tempo, si rese conto, andava sia avanti sia indietro, e siccome nei libri le storie potevano solo andare avanti, la metafora del libro non stava in piedi. Al limite, la vita era più simile alla struttura di un rotocalco, con i fatti salienti, come per esempio lo scoppio di una guerra o una strage di malavitosi in prima pagina, e le notizie meno importanti nelle pagine successive, […]. Il tempo si muoveva in due direzioni perché ogni passo nel futuro si portava dietro un ricordo del passato, e anche se non aveva ancora compiuto quindici anni, Ferguson aveva accumulato abbastanza ricordi per sapere che il mondo intorno a lui veniva plasmato di continuo dal suo mondo interiore, così come ogni altra persona plasmava con i ricordi la propria esperienza del mondo, e anche se tutte le persone erano collegate dallo spazio comune che occupavano, i loro viaggi nel tempo erano tutti diversi, ragion per cui ognuno viveva in un mondo diverso. La domanda era: Qual era il mondo abitato da Ferguson in quel momento, e in che modo era cambiato quel mondo? (pp. 378-379)
In 4 3 2 1, infatti, più o meno come in un quotidiano, osserviamo dal buco della serratura tutte le crisi e i momenti fondamentali della storia recente statunitense: dall’omicidio Kennedy al Vietnam, dalle questioni razziali alla caccia alle streghe, Auster passa in rassegna più di mezzo secolo della storia americana attraverso le avventure di una famiglia di emigrati. Viene in mente in prima battuta la Pastorale americana di Philip Roth (o anche il Tamburo di latta di Günther Grass, volendo); ma in 4 3 2 1 non potremmo essere più lontani da quel genere di scrittura romanzesca in cui la storia si fa carne viva e deflagra nella pagina, mentre la letteratura spazzola la storia contropelo e la rende oggetto di critica. La scrittura di Auster in 4 3 2 1 è al limite esornativa, mai critica. Gli eventi storici più dirimenti della storia americana e mondiale restano senza eccezione alcuna sullo sfondo; vengono riportati, quasi per dovere di cronaca o per mera occasione di spunto tematico (è questo il caso dell’omicidio Kennedy per Archie1), ma non fanno mai un reale ingresso nel racconto. Quando si parla di storia, il lettore di 4 3 2 1 ha l’impressione di scorrere un bollettino o un atlante cronologico del secondo novecento americano, piuttosto che di leggere un romanzo. La storia non è protagonista e nemmeno comparsa, in 4 3 2 1; è pura tappezzeria.
Amore, amicizia, passioni, famiglia, storia, letteratura, scrittura, esordio nella metropoli: 4 3 2 1 è un minestrone in cui si rimesta ogni tipo di tematica e di topos letterario, tradizionale e non; insieme con molte delle ossessioni tematiche tipiche di Auster: il caso, il destino, le coincidenze, l’ironia della sorte. Omosessualità, impegno politico, esperienze accademiche di altissimo livello: l’insieme degli Archie(s) quasi esaurisce l’intero spettro delle emozioni umane e delle avventure esistenziali sostenibili in una vita standard di un membro della middle class bianca statunitense. La trama suscita qualche curiosità, è vero. Eppure: in 939 pagine assai raramente si sonda la profondità delle questioni che affiorano. Tutto resta in superficie: traumi psichici, scoperta della sessualità, formazione intellettuale, vengono spesso presentati nella maniera più trita e stereotipata. Emergono e svaniscono quasi senza lasciare traccia. In 4 3 2 1 traspare una vertigine dell’infinito, la smania di voler esaurire il mondo e le sue infinite possibilità attraverso la narrazione; ma anche l’effettiva irrealizzabilità di tale utopia, insieme con tutti i difetti di un racconto che non sembra essere del tutto consapevole di tale meravigliosa limitatezza.
4 3 2 1, in poche parole, annoia; ed è questo uno dei suoi difetti principali (la narrazione onnisciente in terza persona, tradizionale, tradizionalissima, non aiuta affatto da questo punto di vista). È troppo, in tutti i sensi: troppo lungo, troppo ricco di troppi argomenti; spesso, troppo banale. Difetta di pulizia, esattezza, concisione. Non richiede granché sforzo da parte del lettore, ma d’altro canto non lo intrattiene nemmeno. È insipido, ridondante, verboso. Non mancano, certo, lampi di bellezza limpida, del tutto austeriani, come il meraviglioso apologo del paio di scarpe (pp. 276-289) o dettagli come il seguente:
[…] notò che Amy non aveva la risata stridula e inconsulta da bambina, ma emetteva una serie di sghignazzi sonori dal profondo – guaiti allegri, certo, ma al contempo pensierosi, come se capisse perché stava ridendo, e questo rendeva la sua risata intelligente, una risata che rideva di se stessa proprio mentre rideva di ciò di cui stava ridendo. (p. 251)
Ma sono bagliori brevi, rari, nascosti. Allora mega biblìon, mega kakòn? Troppo facile, appellarsi al motto neoterico. Per Auster, mi auguro e sono certo, in primis come suo lettore affezionato, che ci saranno altre opportunità; la lunghezza di un libro non è certo il metro più esatto per misurare un capolavoro. Callimaco docet.
In un’intervista, Auster ha metaforicamente definito 4 3 2 1 uno “sprinting elephant”, intendendo così ironizzare sulla ponderosità del volume e sul suo stile autoriale che consente di dare ritmo e velocità alla lettura del libro; operazione che in effetti non risulta affatto difficile o eccessivamente lunga (in termini strettamente temporali), come ci si potrebbe attendere a prima vista. 4 3 2 1 è una sorta di ‘mattone di gommapiuma’, o qualcosa del genere.
Auster ha pienamente ragione: sulle pagine di 4 3 2 1 si viaggia alla velocità della luce. Le parole si sorvolano elegantemente, senza eccessive esitazioni, senza perdite di tempo; tutto è apparentemente semplice, il linguaggio è a dir poco scorrevole. Auster è un maestro della parola e riesce perfettamente nel difficile compito di ‘motorizzare’ il suo elefante per farlo correre quantomeno alla velocità di un ghepardo. Non è poco: solo un grande artigiano della téchne letteraria potrebbe essere in grado di riuscire in cotanto obbiettivo. Eppure, ciò che dovrebbe rivelarsi un punto di forza del libro si dimostra l’opposto. Terzo e ultimo paradosso.
Un elefante che corre travolge tutto quello che incontra e al suo passaggio non restano che le macerie di un paesaggio devastato. Per qualche modesto lettore (non è solo una posa), assai più importante di correre è indugiare sulle parole. Per fare jogging sul linguaggio esistono già i social-network, i memes e le chiacchiere da ascensore o da bar. È l’opportunità di una tregua, simultaneamente da e con le parole, che si richiede a un buon romanzo; una pausa per riflettere, per osservare da vicino o da lontano questi compagni di viaggio spesso traditori e sconosciuti che ci ostiniamo ad appellare parole. In definitiva, è questo che davvero manca a 4 3 2 1: uno spiraglio per quel ‘surplus che non è consumato dall’istante dell’azione’ e che l’Adorno di uno dei più esatti paragrafi di Minima Moralia riteneva essere il nocciolo dell’esperienza. Anche letteraria, è lecito aggiungere.