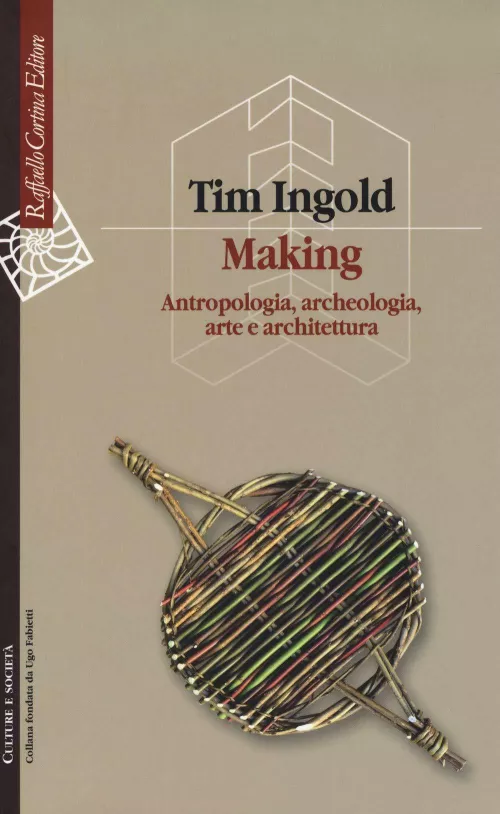Making di Tim Ingold / Pensare con il produrre
Abbiamo ancora negli occhi le immagini tremende del rogo di Parigi, Nôtre-Dame avvolta dalle fiamme. Il fuoco consuma la foresta di travi che sosteneva il tetto, la guglia ottocentesca crolla, la forma della cattedrale viene stravolta davanti ai nostri occhi. Questo ci costringe a considerare l’edificio monumentale non più come un oggetto immutabile e compiuto, ma come una cosa, fatta di materiali la cui storia non si è mai in realtà arrestata in una forma definita. Il fuoco innesca il cambiamento della forma, lasciandoci di fronte allo scandalo di una Nôtre-Dame diversa, non più congruente con l’immagine in cui l’avevamo cristallizzata.
“Le forme delle cose” ci ricorda Tim Ingold nel capitolo dedicato all’analisi della materialità degli oggetti del suo testo Making, sono “generate nei campi di forze e nelle circolazioni dei materiali, i quali trascendono ogni confine che potremmo tracciare tra artefici, materiali e ambiente circostante”. Così, il rogo sciagurato ha portato il nostro “flusso della coscienza”, come lo definisce Ingold, ovvero la nostra comprensione della forma della cattedrale come oggetto finito, a corrispondere forzatamente con il “flusso del materiale”, cioè la dinamica ecologica che ha una traiettoria sottoposta al campo di forze che lo attraversano. Con il fuoco, ci siamo accorti che anche una grande opera architettonica, uno dei modelli prototipici del genere “cattedrali”, è costituita da materiali e, come noi esseri umani, è soggetto e oggetto di un continuo movimento dal quale emerge senza posa una forma.
Se la cattedrale di Nôtre-Dame stava di fronte a noi come oggetto, durante il rogo essa è con noi, conducendoci a un pensiero costruito con il materiale di cui è fatta la cattedrale e non attraverso la sua materialità di oggetto dato. Proprio all’attività del pensiero attraverso la produzione e la dimensione materiale delle cose è dedicato il libro Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura di Tim Ingold, tradotto da Gesualdo Busacca per l’editore Raffaello Cortina. Ingold è professore di antropologia sociale all’Università di Aberdeen e da tempo conduce un’idiosincratica e affascinante riflessione attorno all’edificazione di una “scienza senza nome” – come, in altri tempi e modi, Agamben definì l’impresa intellettuale di Aby Warburg. Ingold propone un pensiero “anti disciplinare” che attraversi le “quattro A” – antropologia, arte, architettura, archeologia – impegnandosi in una riflessione non tanto su queste discipline, ma con queste discipline, felicemente accomunate dall’allitterazione della lettera ‘a’. Il testo nasce da un corso che l’autore ha tenuto a partire dal 2003-2004 presso l’università di Aberdeen e attinge alle esperienze pratiche condotte durante le lezioni come scheggiare una pietra, “incorniciare” un paesaggio, costruire un tumulo, entrare in contatto con un materiale, per costruire – è il caso di usare questo termine – un pensiero attraverso il produrre, attività che accomuna per l’antropologo le “4A”.
Non si tratta però di un manuale, di un libro di testo di supporto al corso, ma è una diretta esemplificazione di ciò che sostiene, un manifesto della sua “filosofia personale” come afferma Ingold nella premessa. La tesi fondamentale viene enunciata in modo chiaro: “produrre significa stabilire una corrispondenza tra l’artefice e il materiale”. Ovvero, la necessità di uscire dalla concezione ilomorfica, l’idea che produrre significhi imporre una forma sul mondo materiale, per ripensare il “fare cose” (making) come un “processo di crescita”, un processo morfogenetico nato dalla corrispondenza tra artefice e materiale.
“In assenza di un concetto a priori di forma, […] stabilire se una cosa sia finita o meno non solo è impossibile, ma è anche una domanda priva di senso”, sostiene Ingold. Quali sono, dunque, le “domande sensate” che si possono porre circa la produzione di cose e circa il “pensare attraverso le cose”?
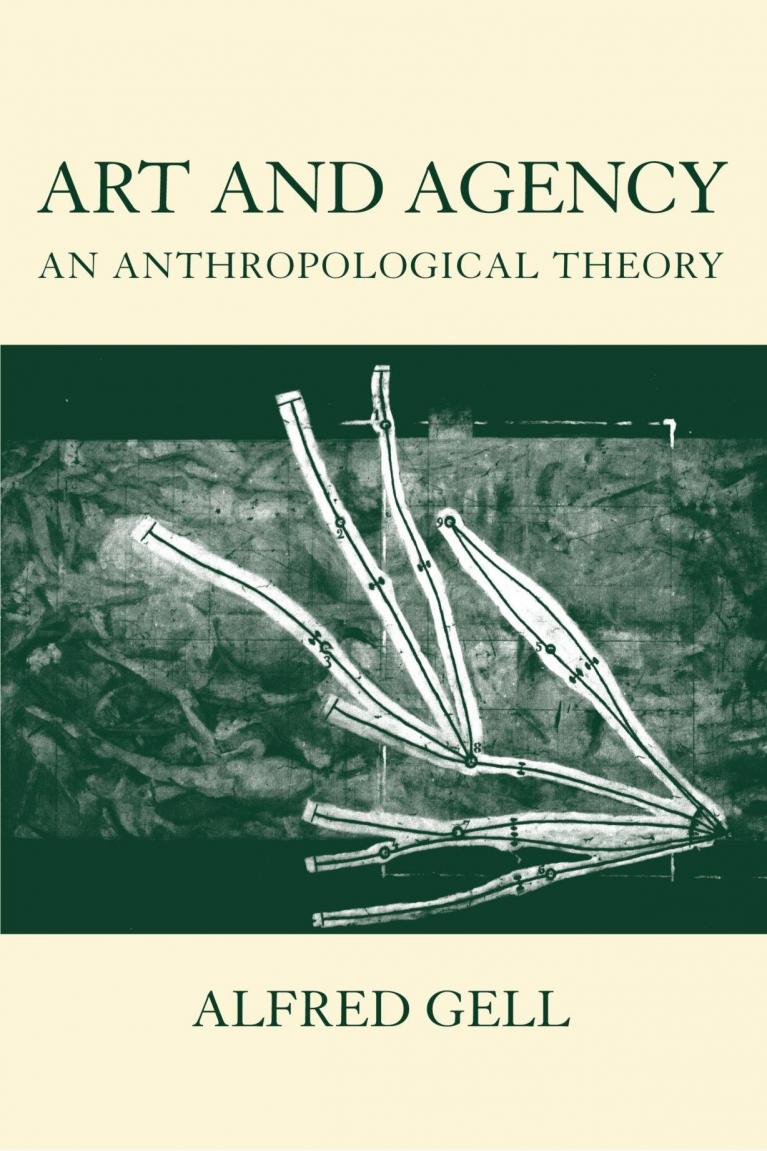
Innanzitutto, occorre “imparare ad imparare”, un processo di deuteroapprendimento, come lo definirebbe Gregory Bateson, che non deve prendere le mosse dalla descrizione a posteriori di qualche pratica, ma dall’applicazione del metodo di ricerca principe dell’antropologia, l’osservazione partecipante, in un coinvolgimento diretto con il mondo. Lungi dall’essere un paradosso, l’osservazione partecipante non è, per Ingold, una tecnica di raccolta dati su qualcosa, ma un “impegno ontologico” con qualcosa. Come l’apprendista artigiano si reca a bottega dal maestro per imparare da lui e non su di lui, l’antropologo apprende dalle situazioni in cui si trova, invece di guardare retrospettivamente a una conoscenza su qualcosa. Nella controversa proposta di Ingold, l’antropologia è contrapposta all’etnografia intesa come studio documentario, uno sforzo descrittivo finalizzato alla produzione di resoconti su qualche fenomeno. L’antropologia è vista come un processo vitale orientato verso un desiderio trasformativo, un movimento dinamico di apprendimento dai contesti attraverso un impegno pratico con il mondo per condurre ad un cambiamento. Il suo fine non è quello di proporre generalizzazioni teoriche, ma di “aprire spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulle condizioni e sulle possibilità della vita” finalizzata a “costruirci il nostro futuro”.
Nel testo si attraversano diverse pratiche, diversi modi in cui l’artefice “corrisponde” con i materiali. Teoria e pratica, in Ingold, non sono momenti differenti: l’atto di pensare avviene nel coinvolgimento diretto con le pratiche situate nel proprio contesto ecologico fatto di materiali, di natura, di flussi, di forze. Dalla constatazione del carattere fluido dei materiali, opposto alla solidità della materialità, si passa all’intreccio di cesti di vimini conficcati sulla spiaggia di Aberdeen, in cui l’intenzionalità dell’artefice si amalgama con la resistenza del materiale e la forza del vento che imprimono una direzione differente alla forma del cesto “seguendo e assecondando le forze e i flussi che porteranno il lavoro a compimento”. La stabilità nei millenni e in luoghi disparati della forma delle “asce di pietra paleolitiche”, le amigdale acheuleane, solleva interrogativi ancora irrisolti definitivamente. Per Ingold, nelle riflessioni attorno alla produzione di questi oggetti si riscontra la fallacia del prodotto finito, ovvero la concezione che l’oggetto ritrovato sia corrispondente a un preesistente schema mentale. Entrando nel processo costruttivo, invece, la forma ottenuta emerge nell’itinerario portato avanti dalla complessa interazione tra la struttura della pietra, la configurazione anatomica dei palmi delle mani e i ritmi della percussione che creano, come già segnalava André Leroi-Gourhan, quella peculiare forma.
La costruzione di case o di cattedrali e il design di oggetti, nella prospettiva di Ingold, lasciano la dimensione del progetto a priori e diventano processi creativi di risoluzione di problemi pratici, condotti attraverso tecniche concrete, nel costante e artigianale far fronte alle questioni poste dall’interazione tra il materiale, gli strumenti, l’ambiente e l’artefice. L’edificazione di una cattedrale, osservata attraverso la serie di procedure condotte usando corde e pali, evidenzia la geometria concreta messa in opera dagli artigiani, scartando l’idea dell’applicazione pedissequa di un disegno architettonico. La cristallina langue saussuriana del design lascia il passo alla materialità di una competenza pratica fatta dell’attualizzazione di una serie di pratiche tradizionali imparate attraverso la produzione stessa.
Il concetto di agency, della capacità di azione individuale, esce malconcio dall’antropologia di Ingold. Il dibattito sull’attribuzione di un certo grado di agency agli artefatti può essere fatto risalire al seminale lavoro di Alfred Gell, Art and Agency che sottolineava come negli oggetti d’arte si cristallizzino le intenzioni di coloro che si trovano imbricati nelle reti di relazioni attorno ad essi. Per l’antropologia contemporanea è centrale la consapevolezza che oggetto dell’analisi non siano collettivi fatti solo di individui, ma collettivi ibridi composti da persone, cose, animali, enti non umani a cui sono attribuite proprietà differenti. Nella visione di Philippe Descola si propongono differenti proprietà ontologiche attribuite in modo contrastivo a umani e non umani. Per Eduardo Viveiros de Castro, è la molteplicità dei punti di vista, delle prospettive, a creare mondi plurali nei quali gli enti hanno proprietà e possibilità differenti. Ingold risolve il dibattito non già attribuendo agency o differenti ontologie agli oggetti, ma privandone gli esseri umani stessi. Per esempio, nel volo di un aquilone, prodotto dall’interazione di forma, aria e azione umana, si vede chiaramente come non si tratta di un’agency del conduttore imposta all’artefatto, ma di un’animacy, un’animazione, dalla quale nasce la forma del volo, una danza dell’animacy che comprende allo stesso modo l’aquilone e il suo pilota.
Ingold riporta al centro della pratica antropologica la consapevolezza che gli esseri umani vivono immersi in un ambiente caratterizzato da forze e movimenti nei quali sono presi ineluttabilmente, e l’unico modo che abbiamo per conoscere questo mondo è impegnarsi direttamente con esso, facendo crescere il nostro apprendimento dall’interno delle pratiche. Ciò che rimane, parafrasando Bateson, è come questo tentativo di Ingold appaia una “metafora per qualcos’altro”, di cui ancora non intuiamo che le fondamenta – o, per non contraddirlo, il flusso.