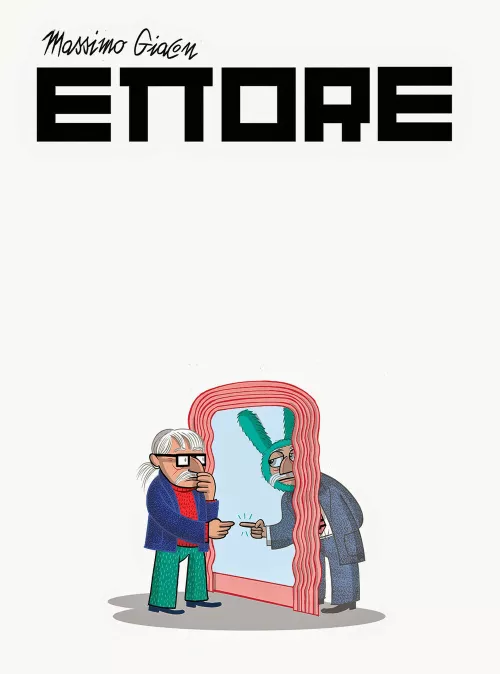Sottsass a fumetti
Quando hai annunciato di lavorare a un fumetto su Ettore Sottsass, ho pensato che questa relazione tra fumetto e design era una storia tutta italiana, nel senso che in questi modi si è manifestata solo qui. Il tuo caso è esemplare perché sei fumettista e anche designer. Ad ogni modo mi è venuto in mente un precedente. Ricordavo che Alessandro Mendini ti aveva chiesto di disegnare un fumetto quando aveva saputo che tu e Maurizio Cattelan eravate stati compagni di scuola e che avevate condiviso buona parte dei vostri pomeriggi padovani di giovani adolescenti. Tu però avevi spostato la scena a Milano per raccontare di Cattelan e le sue incursioni nel design degli anni Ottanta. Il racconto si avvia mentre si dirige verso l'Atelier Mendini con i suoi progetti sotto braccio per sottoporli al giudizio del maestro (una lampada che cammina e un armadio a forma di bara). Quanto c’è di vero in questa storia?
Dal punto di vista strettamente storico non sono neanche sicuro che al tempo raccontato dalla storia ci fosse già un Atelier Mendini perché nella metà degli anni Ottanta c’era lo Studio Alchimia. Se vogliamo entrare nel merito della corrispondenza ‘storica’ va detto anche che l’armadio a forma di bara era un lavoro che Cattelan aveva progettato quando accarezzava l’idea del mondo del design, prima di venire a Milano. Mendini non c’entrava ancora. Ho il sospetto piuttosto che la vicenda di questi armadi fu la molla che proiettò Cattelan in direzione dell’arte perché il suo epilogo, e tutto quello che ne scaturì, ebbe più risonanza del progetto stesso dei mobili. La cosa andò più o meno così: a Padova esisteva la galleria TOT fondata e diretta da Ennio Chiggio, esponente del gruppo N, storico collettivo dell’arte cinetica e programmata. Quando Maurizio si presentò in galleria per mostrargli il suo progetto di mobili a forma di bara, Chiggio mostrò un certo interesse e lo incoraggiò tanto che, insieme a un amico falegname, Cattelan si mise a costruire i pezzi. Quando tornarono con i mobili finiti però, Chiggio disse che il lavoro non lo convinceva, che c’era un problema proprio dal punto di vista semantico e addusse tutta una serie di ragioni per cui glieli rifiutò. Maurizio si arrabbiò a tal punto che progettò la sua prima opera “alla Cattelan”: fece stampare delle finte banconote del valore di trenta denari con al centro il ritratto di Chiggio e tappezzò tutta Padova con il volto di Chiggio-Giuda. Qui si sfiora la leggenda però perché a essere onesto sentii parlare di quel volantino da Chiggio, ma io personalmente non l’ho mai visto. La lampada che cammina, invece, ricordo di averla vista, sempre in quegli stessi anni, a una collettiva d’arte in cui Cattelan aveva esposto questo strano oggetto con gli scarponi che emetteva luce. Devo dire che sono sempre stato incuriosito da questo suo interesse per la produzione di oggetti. Ricordo per esempio alcuni pezzi per Dilmos tra cui il tavolo Rocchetto che ritengo uno dei suoi pezzi migliori e, infatti, non mi ha sorpreso vederlo nella selezione di Mendini per il Museo del design in Triennale.
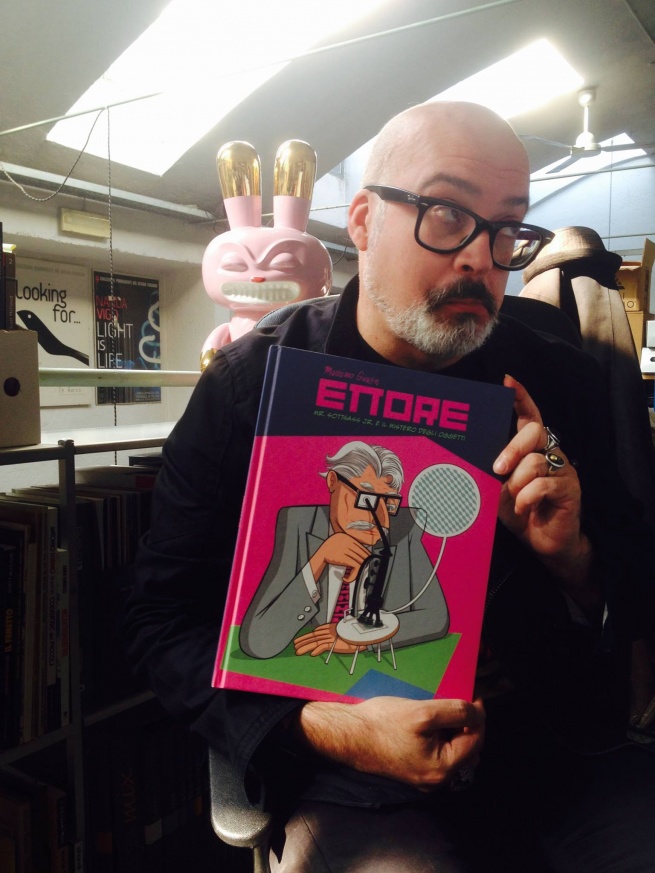
Questa storia racconta lo stesso periodo che affronti nel fumetto su Sottsass: la Milano post-Memphis. Un’epoca in cui il design era capace di mettere in moto una grande energia, anche caotica, eccessiva, a cui tutti volevano partecipare e che si esprimeva in forme e direzioni che, pur nella diversità, si cercavano e si mescolavano insieme.
In quegli anni il design catalizzava molta curiosità e in un certo senso lo Studio Sottsass, come anche L’Atelier Mendini, erano un po’ gli epicentri di questa grande energia. È vero che negli anni Ottanta sembrava che il design interessante si concentrasse tutto a Milano. In realtà, da noi provinciali, Milano era anche vista con molto sospetto perché le idee che circolavano in provincia una volta entrate in contatto con la città tendevano a normalizzarsi per entrare in un circuito commerciale che tendeva a banalizzare ogni cosa e a ridurla a oggetto di consumo. Bisogna anche dire però che Milano è sempre stata una stella polare per il mondo dell’editoria e del design. A questa città sono legate figure come quella di Bonelli – forse l’editore di fumetti più importante al mondo – e naturalmente a personaggi come Mendini e Sottsass, per non parlare degli altri maestri, da Mari ai Castiglioni. E comunque Milano ha sempre espresso una vocazione a rompere le convenzioni e a incrociarle. Fin dal dopoguerra si è sempre praticata una curiosa trasversalità tra mondi apparentemente distanti. Basta pensare a una figura come Dino Buzzati che si occupava di fumetti, lavorava per il Corriere dei Piccoli e nello stesso tempo scriveva romanzi e dipingeva. In questo senso Sottsass e Mendini hanno sempre mostrato quello stesso tipo di curiosità che li spingeva a lavorare con persone provenienti da mondi diversi, anche molto lontani fra loro. Se devo parlare della mia esperienza personale, posso dire che è stato Ettore ad avvicinarmi a Milano. Con lui ho lavorato, ho disegnato, mi sono fatto dare consigli: l’ho ascoltato, l’ho frequentato, mi ha accolto. È stata la prima persona che mi ha spinto a dipingere. E, poi, va detto che in quegli anni allo studio Sottsass passava il mondo intero.
Mi piacerebbe capire che ruolo hanno i luoghi nelle tue storie sul design a fumetti proprio dal punto di vista della funzione narrativa. Sia lo studio Sottsass, sia l’Atelier Mendini a me paiono centrali per lo sviluppo delle tue storie in quanto si concentrano molte aspettative e da lì si mettono in moto le vicende.
Direi che in parte è una convenzione del fumetto. Come accade con il deposito di Paperon de Paperoni. Paperino si incammina verso la collina di Paperopoli per visitare lo zio, quando succede qualcosa ed ecco che parte l’avventura. L’Atelier Mendini o lo studio Sottsass in un certo senso sono il mio deposito di Paperon de’ Paperoni, il mio rifugio di Diabolik, ossia il luogo-contenitore da cui inizia a girare la storia. Lo studio Sottsass però è un punto di partenza speciale perché è stato il “mio” punto di partenza. Lì ho conosciuto per la prima volta Ettore. E sempre lì sono venuto in contatto con tutta una serie di personaggi che hanno generato mille altre storie. Lo Studio era un luogo espanso nel senso che tendeva a generare ramificazioni in molte direzioni diverse. C’era molta gente che faceva capo allo Studio o si rivolgeva a Ettore perché aveva qualche nuova idea e cercava un partner per metterla in pratica. Ricordo per esempio il corso che prese l’incontro con Romeo Gigli, in qualche modo legato al primo marito di Carla Sozzani che era stato amministratore di Sottsass. Da questo groviglio di relazioni si generò un’appendice molto divertente. Ricordo inoltre la propaggine Zeus che proveniva invece da Mendini e dal suo entourage. Insomma lo Studio a suo modo è stato un generatore di storie e, non a caso, non è la prima volta che me ne occupo. Alla fine degli anni Ottanta avevo già scritto delle storie per una rivista fondata da Gino e Michele che si chiamava Tic e che voleva raccontare la realtà milanese. Gino e Michele erano riusciti a riunire un gruppo di giovani autori che oggi sarebbe inimmaginabile rimettere insieme perché sono tutti diventati personaggi famosi. A me in particolare chiesero di disegnare delle storie brevi, così proposi il fumetto dello Studio Compass che aveva come protagonista Achille Compass. Naturalmente i personaggi rappresentati erano abbastanza riconoscibili malgrado i nomi cambiati. Io disegnavo queste storie di quattro pagine che ruotavano attorno ad avvenimenti reali e progetti che lo studio aveva effettivamente avviato. Partivo da un fatto reale e lo trasformavo in qualcosa di paradossale.
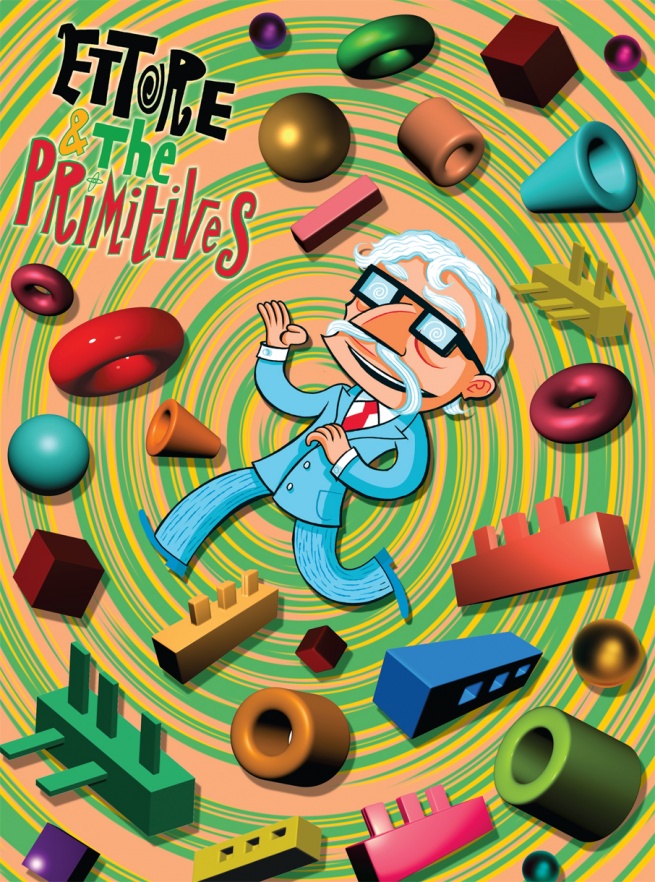
Mi ha sempre colpito come gli studi di architettura, o di design, siano mondo a sé dove accadono cose un po’ speciali. Credo che sia dovuto al fatto che la maggior parte dei pensieri che si generano per arrivare alla sintesi del progetto si perdono per strada quindi gli studi sono pieni di storie di scarti o fallimenti che in genere rimangono all’interno dello stretto circolo di persone che ne hanno fatto parte.
Come dicevo lo studio per me era un generatore di storie, succedevano cose esilaranti e su questi si costruivano dei racconti che poi sentivi e risentivi fino a farli diventare mitici, almeno per noi. Ricordo, per esempio, il racconto del primo meeting di James Irvine con gli ingegneri dell’Olivetti. L’avrò sentito e raccontato centinaia di volte e non ero nemmeno presente! Era successo più o meno questo, (dico più o meno perché ogni volta la storia era un po’ diversa): James era appena arrivato in Italia per cui parlava un italiano stentatissimo e durante un incontro molto formale organizzato allo scopo di presentare un progetto, era stato incaricato di descrivere la distribuzione dello spazio attorno a grandi colonne. James incominciò a spiegare col suo italiano alla Stanlio e Ollio: «Al centri di questi stanzi abbiamo messo due grandi coglioni… e nell’angolo altri coglioni ancora…». Per tutto il tempo della presentazione James continuò a descrivere spazi riempiti di grandi «coglioni» invece che di «colonne». Nessuno si azzardò a dire nulla. Gli ingegneri torinesi però erano allibiti. Ecco, James, per esempio, all’epoca era responsabile dell’industrial design e sapeva raccontare storie che facevano morire dal ridere. Te l’ha mai raccontato dell’orecchio di suo padre? È una storia talmente assurda che probabilmente è vera: sarebbe troppo difficile inventarla. Dunque andò più o meno così: il padre di James era un architetto che si occupava di allestimenti di musei e aveva commesse pubbliche di alto livello. Incaricato di disegnare un progetto per la National Gallery aveva voluto che i pilastri di una sala avessero spigoli affilatissimi, quasi tagliati a fil di rasoio. Per il giorno dell’inaugurazione aveva chiesto che il pavimento di marmo fosse tirato a lucido, ma non semplicemente lucido proprio lucido lucidissimo. Quando il papà di James arrivò all’inaugurazione, un po’ trafelato, scivolò sul pavimento di marmo, si fece dieci metri di culo fino a beccare uno dei pilatri che con l’angolo a spigolo gli tagliò un orecchio di netto. Da vero inglese si alzò in piedi, tamponò la ferita con un fazzoletto, si mise l’orecchio in tasca per farselo ricucire non appena la cerimonia d’inaugurazione si chiuse.
Sono storie che sembrano scritte appositamente per un fumetto. Quest’anno si celebrano i cinquant’anni della rivista Linus che ha avuto il merito di sdoganare il fumetto dandogli una dignità culturale che non aveva mai avuto (almeno in Italia), grazie soprattutto a Umberto Eco. Casualmente Eco insegnava a Bologna negli anni in cui esplose il fenomeno di rinnovamento del linguaggio del fumetto di cui tu hai fatto parte. Proprio per capire meglio questo strano scambio tra fumetto e design vorrei che parlassi dei tuoi inizi, di quando gravitavi intorno al Dams a Bologna...
Pur stando a Padova conoscevo molto bene il gruppo di fumettisti che disegnava per la rivista Valvoline anche se non ne ho mai fatto parte. Erano un gruppo molto unito di cui facevano parte Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, Igort, Marcello Jori, Kramsky, Lorenzo Mattotti (in seguito, si aggiunsero anche Massimo Mattioli e Charles Burns). In un certo senso con il gruppo di Bologna, eravamo colleghi ma anche rivali. Certamente condividevamo un’energia comune e la propensione a sovvertire i generi perché il nostro lavoro dialogava con arte, musica, moda, pubblicità... Da parte mia, io avevo già cominciato a pubblicare, a Milano, su Alter, su Linus, e in seguito sono passato a lavorare per Frigidaire. Anche se ero fuori dal gruppo esisteva però tra noi una forma di riconoscimento reciproco. Eravamo dentro la stessa corrente di pensiero che gravitava attorno al fumetto. L’arte, la conoscevamo ma non ce la portavamo dentro così nel profondo. Per quanto sia molto difficile ripercorrere la genesi dei segni, io non posso che dire che la nostra cultura fosse tutta dentro la storia del fumento. Si è parlato molto di influenza futurista quale riferimento per il nostro lavoro ma quello che è stato determinante per cambiare il modo di disegnare, è stato piuttosto l’ascolto della musica. Il passaggio dai Pink Floyd ai Sex Pistols, per esempio, fu un cambiamento talmente radicale da portarci a un tipo di approccio al disegno completamente diverso. Eravamo giovanissimi: la mutazione dei segni è avvenuta nell’arco di pochissimo tempo. E a vent’anni si fanno cambiamenti pazzeschi nella maniera di pensare e di disegnare in modo del tutto naturale.

A vent’anni dunque eri immerso in quel movimento che, per quanto incisivo, è stato poco sotto i riflettori.
Il problema è che noi disegnavamo storie ma non personaggi. Questa è una cosa che nel fumetto penalizza molto. Me ne rendo conto quando parlo con chi che non è dentro il mondo del fumetto e mi chiede cosa faccio. La prima domanda di solito è: “Chi disegni?”. Perché Il fumetto di solito è legato a un personaggio.
Non aver creato personaggi lo ritieni un fatto generazionale?
Mah! Non direi. Se penso a Rank Xerox, Zanardi, Joe Galaxy, Primo Carnera... Ecco, quelli sono personaggi. Stefano Tamburini, Tanino Liberatore o Andrea Pazienza hanno avuto l’intelligenza di creare dei personaggi.
Non avevi questo interesse?
Credo che per molti autori della nostra generazione non fosse tanto interessante lavorare a un personaggio. Per noi era importante la storia. Il motivo potrebbe essere che avevamo come riferimento alcune esperienze francesi in cui le storie iniziavano e finivano senza ricorrere a personaggi seriali, proprio come accade nel romanzo. E questo molto prima che si iniziasse a parlare di Graphic Novel.
Forse sei tu stesso il tuo personaggio. Ti disegni spesso dentro le tue storie?
A volte. È un espediente narrativo che aiuta la storia. Comunque è vero che tendenzialmente gli autori hanno una maniera di essere che in un certo senso li rende personaggi da fumetto. Sicuramente Robert Crumb è uno dei suoi personaggi. Igort, per esempio, è un personaggio. All’epoca anche Iosa Ghini lo era. E anche nel mio caso, forse, cogli anni si può dire che mio “io” fumetto stia prendendo il sopravvento.
Che relazione hai instaurato con il tuo gemello fumetto?
Lo uso, a volte, come espediente narrativo. Non avendo un personaggio fisso, appunto, mi metto dentro le storie. In genere lo adotto come trucchetto per sollecitare un meccanismo di identificazione da parte del lettore. Non è una forma di auto-celebrazione perché di solito mi ritraggo come uno a cui capitano cose da sfigato oppure mi descrivo come un esserino maligno che dice cose che il mio doppio nella vita non ha il coraggio di dire in maniera esplicita.
Ti disegni più coraggioso di quanto tu non sia nella realtà?
Non saprei. Ultimamente i due livelli si stanno un po’ confondendo. Comunque pur avendo utilizzato l’espediente autobiografico in molti fumetti brevi, è qualcosa che non ho mai sperimentato in una storia lunga.
Nel fumetto di Sottsass però ci sei.
Ci sono, ma il protagonista è Ettore. Esserci mi è servito per aggirare il problema del fatto che Ettore ha raccontato moltissimo di se stesso e lo ha scritto molto meglio di quanto avrei mai potuto scrivere io su di lui. Quando mi hanno chiesto di fare un libro su di Sottsass non avrei saputo cosa raccontare di più di quello che aveva già raccontato lui, per cui ho scelto questo espediente. Parlando con molte persone ho notato che molto di quanto ho vissuto insieme a Ettore era pressoché sconosciuto. Questo fatto mi ha convinto a lavorare su un segmento della vita di Ettore mai raccontato. Un po’ come succede nelle biografia di personaggi famosi in cui si racconta, che so: «I 3 giorni segreti di Agata Christie». Ecco, il mio è un po’ un romanzetto di questo tipo.
Insomma quando tu a vent’anni arrivi a Milano, e lo incontri per la prima volta, a metà degli anni Ottanta di trovi di fronte un uomo che non era più un ragazzino, perché va detto che, quando ha fondato Memphis, Sottsass era già un uomo di 60 anni. A me sembra di capire che sentisse la necessità di essere immerso dentro le cose per trovarsi al loro centro proprio nell’istante in cui succedono, anzi forse anche un momento prima. Soprattutto aveva bisogno degli altri. È così?
Ettore aveva bisogno delle persone che gli stavano intorno, come aveva bisogno di prendere energie, idee e suggestioni da persone che passavano dallo studio. Lui, però, in cambio dava moltissimo: ero uno scambio reciproco. La cosa bella di quel periodo è che Milano era il crocevia di persone con culture diverse, che venivano da posti diversi e tutto questo minestrone ha creato uno stile milanese con tutto quello di positivo e negativo che questa cosa ha generato.
Si può dire che, quando arrivi a Milano, Memphis fosse un’esperienza a suo modo conclusa, o almeno lo era per Sottsass. Penso che per lui il problema fosse capire cosa fare dopo.
In modo molto indiretto ero entrato in contatto con Memphis quando ancora muovevo i primi passi nel mondo del fumetto, prima di arrivare a Milano. Era un periodo in cui mi davo un gran da fare per portare in giro la mia roba e farla conoscere. In questo girovagare ero capitato in un’agenzia di pubblicità di Padova dove, per la prima volta, mi parlarono di Memphis: dissero di riconoscere una certa affinità tra il mio lavoro e il loro. Si può dire che fosse la stessa affinità che si era generata con il gruppo di Valvoline perché era un momento in cui tutti, magicamente, eravamo sintonizzati su determinate tematiche. Potevano essere la musica, l’ispirazione pop, un certo grafismo, l’uso di texture, e nello stesso tempo il recupero del futurismo italiano… Queste cose ci univano e ci spingevano tutti insieme in una direzione comune. In un certo senso eravamo portati a riconoscerci sulla base di uno stesso interesse.

Sapresti ricostruirne il motivo?
Ma perché ci eravamo rotti i coglioni degli anni Settanta! Tutto era in trasformazione. Ogni cosa stava cambiando. Anche le droghe erano diverse. Finita l’epoca della psichedelia, dopo l’LSD era arrivata l’eroina, per cui anche l’immagine della città, della vita e delle cose aveva perso molto dei suoi colori sgargianti. Non era più tempo della “crudità” degli anni Sessanta e Settanta. Noi per esempio avevamo preso ad andare giù dritti con le righe. Non disegnavamo più linee curve forse perché avevamo capito che il futuro sarebbe stato molto più duro di quanto ci avevano fatto immaginare. Sicuramente non sarebbe stato l’idillio di pace, amore, fiorellini che aveva descritto la cultura hippy-flower power. Noi lo sentivamo con la stessa lucidità con cui lo sentiva la musica. Era apparso il punk, la sua provocazione ed energia propulsiva “rendeva omaggio al lato ‘minore’ di noi stessi, al lato idiota e mostruoso che noi tutti ci portiamo dentro” come diceva Igort. Non era più il tempo degli assoli di chitarra del Rock, sentivamo che era importante sentire di far parte di un gruppo e, insieme, condividere le stesse idiosincrasie e passioni o, se vuoi, anche ossessioni. Insomma mentre ancora ventenne mi trovavo immerso dentro questi pensieri, accadde che Ettore avesse avuto modo di vedere il mio primo album di fumetti pubblicato per Frigidaire e durante una cena con Massimo Iosa Ghini gli disse che gli sarebbe piaciuto conoscermi.
Così andai a Milano per incontrarlo. Ettore mi disse: «Ho letto il tuo libro a fumetti pubblicato da Frigidaire. Mi piacerebbe che facessimo delle cose insieme. Non so bene cosa, però ho avuto un’idea. Come studio stiamo progettando un grande ristorante in California che nelle intenzioni vorrebbe esprimere concetti diversi dal solito ristorante. Ho pensato che possa essere un luogo che offre cucine di tanti paesi diversi, che funziona anche da discoteca e che la notte trasforma tutto in un grande party. L’ho pensato come luogo dove la gente si incontra, si innamora e magari, alla fine, fa anche all’amore…». Insomma era un progetto “alla Ettore”: un ristorante concepito come una specie di comune nel deserto californiano.
Mi disse anche che avevano fatto il plastico e tutte le cose che gli architetti normalmente fanno per raccontare un progetto al cliente, però non gli andava di fare una presentazione classica. Ci aveva pensato su e gli ero venuto in mente io. Mi chiese: «Faresti una storia fumetti con questo ristorante? Lo racconteresti a modo tuo?». Uscii dallo studio carico di fogli, foglietti, disegni. Raccolsi tutte le informazioni possibili, mi misi a disegnare come un pazzo e gli consegnai il mio fumetto a tempo di record. Poi, aspettai. Passò qualche tempo, però non stavo nella pelle e volevo sapere come fosse andata. Cercai di pazientare un po’ ma alla fine mi decisi a chiamarlo. Ettore mi disse: «Ah, beh! Non se ne fa più niente perché il cliente ha trovato il progetto orribile e soprattutto ha trovato orrendi i tuoi disegni. Non ti preoccupare però, quello non capisce un cazzo e noi continueremo a lavorare insieme».
Giusto per inquadrare la cosa, il committente era Doug Tompkins, il proprietario di ESPRIT che in seguito diede molto lavoro allo studio, commissionando uffici e negozi in tutto il mondo.
Il fatto che un architetto usasse il fumetto per raccontare i progetti non credo che fosse una cosa tanto usuale.
Era una cosa che io personalmente feci diverse volte per lo studio Sottsass. Ricordo di un’altra occasione per cui lo Studio era stato incaricato di disegnare nuovi oggetti tecnologici per un’azienda tedesca e siccome si trattava di tecnologie all’avanguardia, tutti insieme studiammo una presentazione futuribile. C’erano degli oggetti che a guardarli con gli occhi di oggi appaiono la versione ante-litteram dell’iPhone. Eravamo molto in anticipo sui tempi.
Per lo Studio Sottsass ti occupavi quindi di raccontare i progetti?
Mmmh sì, ma ero impegnato anche su altri fronti. Facevo cose molto diverse, potevano essere illustrazioni, disegni per laminati, o anche comporre musica come accadde quella volta che per il Museo de la Villette di Parigi lavorammo a un grosso progetto con una forte componente interattiva che comprendeva la musica. Tra le altre cose ebbi anche il privilegio di far cantare Ettore in una mia canzone che registrai in una demo, ma questa è un’altra storia.
Nel racconto del progetto sembrerebbe che Sottsass vedesse i limiti del disegno di architettura rispetto alle sue potenzialità narrative.
Beh, lo studio non lavorò solo con me. Erano costantemente alla ricerca di collaboratori tra fumettisti e illustratori. Sia Barbara che Ettore non erano lettori di fumetti ma erano molto interessati a quel tipo di linguaggio. Se ci pensi la buona parte delle texture di Memphis provenivano dal mondo del fumetto. E comunque a un certo punto per mi commissionarono alcuni murales per alcuni interni di Ettore che poi avrebbero fotografato e pubblicato all’interno della rivista Terrazzo. Nel libro parlo di quello che realizzai per Jean Pigozzi a Cap d’Antibes. Ne disegnai anche altri. Uno lo feci per il soffitto della cucina di Ambrogio Borsani e un altro per la casa di Christoph Radl che poi passò ad Aldo Cibic dove rimase fino a che i nuovi proprietari non decisero di imbiancare tutto dato che il soggetto pornografico non risultò di loro gradimento. La signora delle pulizie quando aveva visto il murale aveva detto: «I don’t understand the meaning», per cui decidemmo che fosse quello il titolo dell’opera.

Nel tuo fumetto su Sottsass in un certo senso hai fatto un lavoro di ricostruzione storica.
Nel lavoro per questo libro ho trovato molte difficoltà non tanto nel trovare i materiali per la storia quanto proprio nel trovare gli elementi per rappresentare i personaggi, i loro volti, le loro figure. Ho dovuto inventarmi molte cose. Un episodio della sua vita di cui parlava spesso perché che lo ha molto segnato, per esempio, era quando frequentava il pittore Spazzapan. Mi sono documentato quindi sulla pittura di Spazzapan ma quanto a lui come persona non riuscivo a trovare immagini. L’unico reperto che sono riuscito a trovare è stato un vecchio filmato di una trasmissione RAI in cui s’intravede una figura quasi scheletrica, appoggiata a un bastone con la faccia lunga e un’aria scettica. Non ho ben capito se fosse proprio lui comunque l’ho presa per buona e l’ho interpretata perché comunque l’immagine è molto sfuocata.
Si può dire che sia una biografia di Sottsass?
No, ne contiene però alcuni episodi. Per farti un esempio, a un certo punto, Ettore racconta di come certe cose si possono fare solo nel momento in cui si è raggiunta la vecchiaia. È una cosa che riguarda proprio il periodo in cui, da giovane, frequentava Spazzapan. Mi aveva raccontato di aver aveva visto nell’atelier la riproduzione di un’opera di Matisse al cui centro campeggiava un color giallo limone. «Un giallo pazzesco», mi disse. Così quando tornò a casa si mise a fare dei disegni gialli, ma proprio gialli, gialli, gialli. Quando Spazzapan li vide, disse: «Eh, ma per fare un giallo come quello di Matisse bisogna avere almeno settant’anni». Era una cosa che mi aveva molto colpito e ci tenevo che ci fosse nella mia storia malgrado fosse successa molto prima di conoscerci.
Qual è l’inquadramento temporale del tuo racconto.
La storia si sviluppa in un arco di tempo che va dal mio ingresso in studio fino al termine del mio rapporto lavorativo fisso. Inizia nel 1984 e termina nel 1989 e coincide con l’intervista che ebbi modo di fare a Ettore per una rivista di fumetti che si chiamava Dolce Vita e oggi non esiste più. All’interno del racconto ho introdotto alcuni salti temporali. Ho fatto in modo che Ettore si abbandonasse a dissertazioni filosofiche sul proprio lavoro per inserire episodi del passato insieme a progetti che appartengono a periodi successivi alla mia fuoriuscita dallo Studio.
Quali sono i caratteri che ti hanno permesso di renderlo un personaggio da fumetto?
Nella mia storia l’ho disegnato in tanti modi diversi: con il corpo piccolo e la testa grossa come un manga o in altri casi con un corpo più muscoloso e in altri, invece, stilizzato. C’è Ettore giovane. C’è l’Ettore che ho conosciuto io e quello anziano, con la treccina. In realtà nella mia memoria, come nella memoria di tutti, non esiste un’unica versione di Ettore. Ognuno ne possiede un po’ una propria.
Domenica 25 ottobre in occasione di Bookcity Milano, Massimo Giacon presenta al Mudec di Milano alle h 17.30 la graphic novel, pubblicate da 24 ORE Cultura, ETTORE. Mr Sottsass Jr. e il mistero degli oggetti.