Thomas Piketty, un amaro american dream
Sono passati due mesi dalla pubblicazione dell’edizione inglese del Capitale nel XXI secolo e in America il trattato economico di Thomas Piketty (696 pagine) può considerarsi senza dubbio il fenomeno editoriale e politico dell’anno. Il volume — dall’intenzionale assonanza col Kapital di Marx — è volato in testa alle classifiche delle vendite e da settimane viene dato «temporaneamente esaurito» da Amazon, nelle librerie non ce n’è traccia e nelle biblioteche pubbliche figura «in ordinazione».
Il lavoro è stato acclamato da economisti illustri come Paul Krugman, il quale ha dichiarato che l’opera dell’economista francese già consigliere di Segolène Royale, rappresenta una ricerca di portata «epocale». Il New York Times lo ha affiancato a Susan Sontag e ad Allan Bloom e lo ha definito un «fenomeno raro»: un autorevole trattato accademico capace di inquadrare la macrotendenza di un’era e, allo stesso tempo, di catturare l’ineffabile tendenza del momento culturale. Piketty ha preso residenza nel circuito americano dei talk show, facendo spola fissa fra interviste, inviti a convegni e ricevimenti con premi nobel. Nel complesso, una risonanza che l’edizione originale francese certo non aveva avuto.
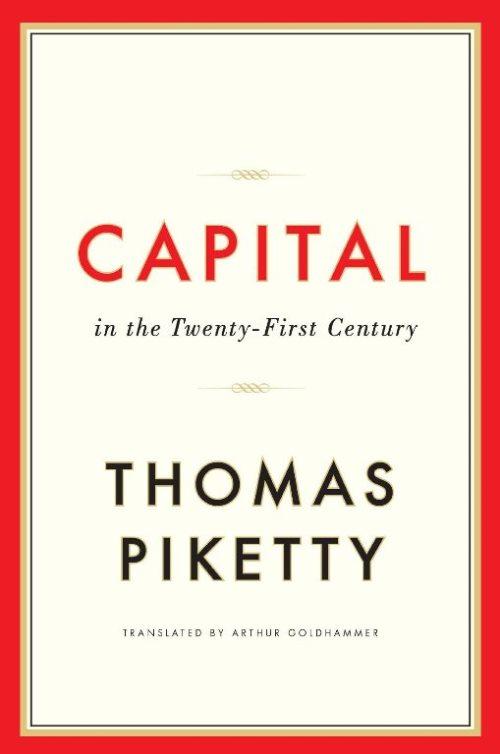
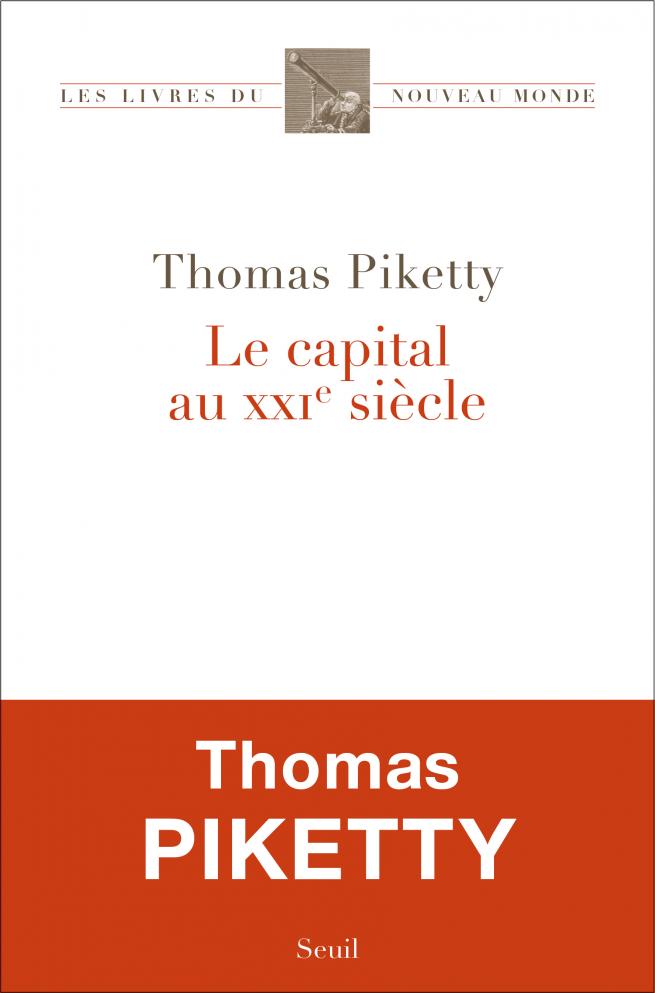
In parte, si tratta del risultato di un singolare tempismo. L’edizione americana è stata pubblicata dalla Harvard Press, poche settimane dopo il discorso nel quale — a dicembre — Obama aveva indicato la diseguaglianza come la sfida fondamentale del nostro tempo («the defining challenge of our time»). Durante quell’intervento, in un community center di Anacostia, uno dei quartieri più poveri di Washington, il presidente aveva dichiarato che «il patto fondamentale alla base della nostra società si è eroso. L’effetto combinato di una crescente diseguaglianza e una diminuita mobilità costituisce una grave minaccia per il sogno americano, il nostro stile di vita e gli stessi valori che rappresentiamo nel mondo».
Benessere d'élite
Obama è poi tornato sull’argomento nello State of the Union e la divisione sempre maggiore fra i pochi ricchissimi e il resto della popolazione è diventata una tematica centrale e ricorrente dei suoi discorsi, in ultimo — senza apparente ironia — del fundraiser tenuto la settimana scorsa nella villa hollywoodiana dell’amministratore delegato dei Walt Disney Studios, Alan Horn, al cospetto di Barbra Streisand e Steven Spielberg (costo dei biglietti, dai 32mila dollari ai 64mila).
La tesi centrale di Piketty, supportata da una mole enorme di dati empirici, sostiene che il concentramento del capitale in poche mani sia la dinamica storica e naturale del capitalismo stesso. Si tratta di uno studio scientifico, il più esaustivo finora intrapreso, sulla diseguaglianza singolarmente adatto a un momento in cui questa sta emergendo (negli interventi di Obama ma anche, ad esempio, in quelli di papa Francesco) come fenomeno socialmente deleterio. Piketty ha sottolineato, inoltre, la forza politicamente destabilizzante del dislivello economico, dichiarando che «in Usa il divario sta producendo un concentramento del benessere simile a quello che prevalse in Europa attorno al 1900-10.
La storia suggerisce che questi livelli di diseguaglianza non solo siano inutili per incentivare la crescita, ma possono portare all’esproprio del processo politico da parte di una minuscola élite con redditi e patrimoni fuori misura. Ciò può costituire un pericolo concreto per i valori e le istituzioni democratiche» Le sue conclusioni si basano su dati dati relativi a un periodo di trecento anni, dal 1700 ad oggi, un «data mining» di cui Marx non disponeva: Piketty stima un ritorno medio sugli investimenti del 4–5% l’anno, maggiore rispetto alla crescita «reale», con l’effetto di una costante concentrazione di ricchezza nelle mani di chi ce l’ha già. Una constatazione che, nell’Europa della secolare egemonia della borghesia mercantile, potrebbe sembrare la scoperta dell’acqua calda.

Perché allora tanto rumore in America? Intanto perché senza il beneficio degli ammortizzatori sociali delle socialdemocrazie europee — con gli homeless ammassati sui marciapiedi vicini ai grattacieli in cui i manager incassano assegni che nel 2000 erano giunti a valere fino a cinquecento volte quelli dei propri dipendenti — la tesi ha un’immediatezza empirica maggiore che altrove. Soprattutto, la «teoria unificata del capitale», proposta da Piketty, giunge in un momento di inedita crisi «identitaria» riguardo alcuni precetti fondamentali dell’«esperimento americano», fondato in gran parte sul rifiuto delle rigide gerarchie economiche del vecchio continente.
«L’innovazione americana» presuppone la mobilità economica e sociale, ossia la possibilità di emergere e guadagnare in base alle proprie abilità. Come ha scritto Paul Krugman, «la vera novità di Capital in the 21st Century, è il modo in cui demolisce quel mito così caro ai conservatori, (quello di) una meritocrazia in cui le grandi ricchezze sono guadagnate e meritate». Qualcuno ha scritto che Piketty è un caso perché costringe gli americani ad ammettere che la loro rivoluzione è fallita. Di certo la crisi ha indotto una specie di psicosi del sorpasso, scandita da incalzanti classifiche negative: il sorpasso cinese, la fine del primato geopolitico, il declassamento della middle class da più ricca al mondo a seconda, dietro la controparte canadese…
Quest’ultima statistica, annunciata da uno studio Pew, è significativa. Nella mitopoietica Usa, la classe media non è la borghesia bensì la working class assurta a un benessere «consumista» attraverso i frutti del proprio sudore ed è questo ceto ora – quello emerso nel dopoguerra dalle fabbriche della Gm, dagli stabilimenti Coca Cola e negli uffici della Ibm — a maggior rischio di inghiottimento da parte della voragine che si è spalancata fra i super ricchi e i «working poor», la massa post-lumpen che, anche lavorando a livelli record di «produttività» non riesce a tenere il passo.
Dopo i grandi monopoli
Piketty esprime «scientificamente» questa diffusa sensazione e lo fa sostenendo che la grande espansione della middle class nella società del benessere prodotta nel dopoguerra non sia stata tanto espressione di operosità virtuosa e protestante etica del lavoro, ma un’anomalia temporanea, dovuta a circostanze verificatesi all’inizio del ventesimo secolo (e ai meccanismi sociali predisposti in seguito alle guerre e la Grande Depressione). L’attuale contingenza sarebbe dunque un ritorno alla norma macroeconomica e alle dinamiche che prima dei sussulti moderni e del New Deal avevano prodotto le oligarchie della «Belle Epoque».
In America, i decenni dal 1870–1914 sono noti come Gilded Age un’«età dell’oro» in cui i metalli preziosi, e vasti patrimoni in generale, erano concentrati nelle mani di poche famiglie protocapitaliste: i Rockfeller, Vanderbilt, Astor, Schwab, JP Morgan e gli altri «robber baron» fautori dei monopoli capitalisti di inizio secolo fondati sullo sfruttamento delle risorse e del lavoro. Nell’analisi di Piketty si profila oggi un ritorno ai dislivelli calcificati di quell’epoca.
Si tratta di un vero e proprio anatema contro il vangelo della ricchezza «self-made» e spiega la reazione dei liberisti di area conservatrice che si sono scagliati compatti contro Piketty. David Brooks ha definito il suo libro un capriccio della borghesia intellettuale motivato dalla gelosia verso le élite cui aspira. Il Wall Street Journal ha deplorato «l’ostilità medievale verso gli investimenti di capitali». Il Financial Times ha bollato il fenomeno come una moda stagionale dei salotti buoni di Manhattan e dei cocktail party, dove per fare buona figura è obbligatorio snocciolare l’occasionale citazione, pur non avendo letto il libro. Gli scritti anti-Piketty sono ormai quasi un sottogenere a se stante del giornalismo conservatore: New Republic, National review, Forbes, hanno un desk fisso dedicato al rifiuto delle sue tesi e metodologie a cui replicano col mantra della crescita illimitata e della moltiplicazione dei mercati.
Ma si tratta di una battaglia di retroguardia: la diseguaglianza è di fatto assurta a oggetto centrale del dibattito politico. Nella contrazione globale, la forbice sociale sempre più divaricata si è andata imponendo come paradigma predominante di un sistema economico inceppato. Lo stesso crac dei subprime all’origine della crisi, coi suoi pacchetti di mutui venduti ai poveri e riciclati dalla finanza degli hedge fund è emblematico di un sistema economico disperatamente disequilibrato. Uno studio di FiveThirtyEight, il «datalab»demoscopico di Nate Silver rilevava, qualche giorno fa, come le menzioni del termine «inequality» sul canale Msnbc siano passate da 14 volte dell’intero 2008 alle 647 nei soli primi quattro mesi del 2014, e un simile aumento si è registrato anche nei programmi all-news della Fox News.
Antagonisti «inglobati»
La «nuova iniquità» è, insomma, una ineluttabile realtà. Nel fare della diseguaglianza un tema programmatico centrale della sua policy, Obama ha in parte cooptato l’argomento che era stato la base della critica di Occupy. Il movimento antagonista è stato riassorbito, ma la dialettica del 99% e dell’1% è entrata a far parte del lessico economico e politico mainstream ed economisti progressisti del calibro di Krugman e Robert Reich articolano la loro critica proprio in base al pericoloso disequilibrio interno dei capitalismi maturi occidentali.
È un tema che promette di dominare le prossime elezioni midterm di novembre sia per le iniziative di Obama sull’aumento del minimo sindacale e la parità dei salari, sia per il crescente numero di politici democratici che hanno fatto della diseguaglianza un cavallo di battaglia elettorale. Esponenti emergenti come Elisabeth Warren (che prima di diventare senatrice democratica aveva presieduto l’authority sulle pratiche bancarie e per la protezione dei consumatori) deve la sua popolarità all’ampio spazio che ha dedicato all’argomento. Fatto sta che anche i repubblicani, dopo aver accusato i democratici di «fomentare la guerra di classe» sono stati costretti ad affrontare il problema.

Paul Rayan
Nel Growth and Opportunity Project, il programma del comitato centrale repubblicano stilato l’anno scorso, si legge che «se vogliamo crescere come partito non possiamo ignorare che la middle class ha sofferto molto e che troppi dei nostri cittadini vivono in povertà». Esponenti di spicco del Gop, come Lamar Alexander, Paul Ryan e Marco Rubio, hanno tentato di formulare iniziative sull’inconsueto terreno dell’«assistenza alla classe media» (fermo restando l’appoggio incondizionato alle corporation e la resistenza a oltranza alle tasse sui capital gains).
La verità di una classe media in pericolo di estinzione è mascherata dalla diffusione di un «benessere dei consumi» alimentato da beni (in particolare, tecnologici) i cui prezzi sono contenuti dalla globalizzazione mentre i veri strumenti di mobilità sociale, in primo luogo l’educazione, sono alla portata di una parte sempre più esigua della popolazione. La tendenza è esplicitata in una statistica rilevata ancora una volta dalla Pew research: negli ultimi dieci anni in America il costo dell’università è salito del 40%, nello stesso periodo il prezzo dei televisori è diminuito del 110%.
A questo riguardo, Piketty sostiene che una delle maggiori forze per l’equiparazione sociale «è stata storicamente la diffusione di sapere e di perizie, un meccanismo che può funzionare solo con continui investimenti pubblici per garantire l’accesso all’educazione». Sarà una delle grandi sfide per molti paesi alle prese con una pericolosa e crescente diseguaglianza.
Questo articolo è uscito in precedenza su il manifesto









