Insegnare / In che scuola vogliamo tornare?
In autunno, sul banco delle novità della biblioteca del liceo in cui insegno, c'era un libro adesso famosissimo, Spillover di David Quammen. L'ho tenuto in mano a lungo, sfogliandolo e leggiucchiandolo; l'amico bibliotecario mi ha chiesto se volevo prenderlo in prestito (mi conosce, e sa che di solito se tengo in mano un libro per un tot poi me lo porto a casa); ci ho pensato su, e poi gli ho risposto: magari in estate, adesso non ho il tempo di leggerlo. E poi, mi sono anche detto: una volta letto, dove trovo il modo di parlarne in classe, io che insegno storia e filosofia? Fatto è che il tempo di leggerlo (è un librone, anche se divulgativo), fra lezioni da preparare, compiti da correggere, e un mare di impegni burocratici da sbrigare, forse non lo avevano neanche le/i collegh@ di scienze.
Poi è arrivata la pandemia, il manifesto ha intervistato Quammen, e di colpo tutto il mondo dell'informazione ha "scoperto" Spillover: e a me è rimasto l'amaro in bocca per non averlo letto e non averne parlato, che sarebbe stato utile, eccome. Potrebbero obiettarmi: ma se l'aggiornamento è un obbligo, leggere un libro per farne argomento didattico non è ottemperare a un obbligo di servizio? La risposta è: no, non lo è. Se leggo un libro e imparo qualcosa, non è riconosciuto come aggiornamento. Se invece (com'è accaduto) c'è una "giornata di studio" nella quale la star dell'evento è una funzionaria del ministero la cui unica referenza è stata per anni l'aver co-firmato (ma col proprio cognome in piccolo) un libro assieme all'ex ministro Berlinguer – ma che, a dispetto di ciò, ha incarichi su incarichi: beh, quello sarebbe aggiornamento. Perché, un po' come le banane, quel convegno aveva il bollino: quello della piattaforma SOFIA. Per la cronaca: non ci sono andato (e questo mi ha causato qualche problema). Ci fossi andato, avrei sentito magnificare un'idea di "insegnamento della filosofia nell'età della conoscenza" che riduce la disciplina a sola tecnica dell'argomentazione, attuando uno spezzettamento della complessità disciplinare in tanti segmenti omogenei suscettibili di valutazione quantitativa, prefigurato dalla proposta di istituzione di un "Sillabo di filosofa per competenze": una filosofia, insomma, che cede davanti al proprio desiderio e si adatta a un ruolo di counseling filosofico.
Sono cose che avremmo dovuto rimeditare in altre sedi e in altri incontri. Poi è arrivato il coronavirus, a sovvertire le gerarchie di ciò che è o non è rilevante, importante, indispensabile – vitale, per troppe e troppi. E a porci un problema: in che tipo di scuola vogliamo tornare a insegnare? Che cosa vogliamo insegnare, a una generazione che ha patito il trauma della rottura del confine del corpo come illusorio scudo di sicurezza, che ha avuto l'esperienza della morte, esperita nei propri cari o prefigurata e temuta? Che, insomma, ha avuto una sorta di esperienza di una Alterità irriducibile al di là del pensabile – o quantomeno ne ha visto baluginare una luce oltre lo schermo? Potrei obiettare a me stesso: a parte la quotidiana tragicità della vita "ordinaria" – non hai avuto student@ che hanno attraversato la violenza domestica, conosciuto la guerra da quella Bosnia dalla quale sono fuggiti, lasciando lì i propri cari – quando non ne sono stati testimoni dell'assassinio, attraversato l'Africa e il Mediterraneo per arrivare fin da te? Ma, appunto: di questa ordinaria tragicità, ne facciamo scuola? La insegniamo? Ci poniamo il problema di costruire orizzonti di senso che ne tengano conto?
Nulla sarà come prima, è stato detto. Almeno in un senso è vero: a settembre torneremo a insegnare non davanti a testimoni della tragicità della condizione umana globale, ma davanti e dentro un'intera generazione: nessu@ esclus@. E questo, nessuno potrà modificarlo: il fiume nel quale ci bagneremo non sarà lo stesso fiume. O meglio: non potremo, anche volendo, illuderci che lo sia mai stato.
Quello pandemico è stato un evento; guardandolo dall'interno, anche se limitatamente all'indagine su quali possibilità per la scuola del domani, possiamo trovare segni di un potenziale contro-evento: a condizione di essere davvero convinti che quella "normalità" alla quale si vorrebbe ritornare era in realtà il problema al quale non si dovrà ritornare.
Il primo segno di una scuola possibile è una constatazione: sono stat@ le/gli insegnant@ a tenere in piedi e all'opera il sistema educativo. Non la burocrazia amministrativa, quella tempesta di adempimenti, regolamenti, carte fisiche e virtuali che a volte sembrano crescere fino al cielo, sottraendo tempo prezioso alla didattica – e che, incredibile a dirsi, nessun ministro o viceministro o sottosegretario o dirigente o commissario straordinario ha pensato di mitigare in ragione dell'emergenza; non i dirigenti, con buona pace della loro frangia estremista, vale a dire l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici della Scuola (ANP), che si arroga questo merito, reclamando pieni poteri e mano libera; non il MIUR, apparso ai più come una navicella che mutava rotta a seconda del vento. Quelle e quegli insegnanti che si sono fatti carico della didattica a distanza (DaD) – raccogliendo elogi dalla comunità scolastica, e qualche commento fuori luogo da chi della scuola poco o nulla sa, ma ne parla comunque: come il popolo dei bar che, avendo tirato due calci al pallone qualche volta nella vita, si reputa in grado di dettare la formazione della nazionale. L'attività a distanza ha dimostrato tre cose fondamentali. In primo luogo, che le/i docenti sono in grado di autoaggiornarsi e di acquisire le "competenze digitali" (detto più terra terra: di sapere e di saper fare), senza bisogno di piattaforme SOFIA, corsi di aggiornamento farlocchi (e a pagamento). Com'è stato possibile? Con l'aiuto reciproco, il supportarsi l'un l'altro, il fare comune e comunità: a conferma che quella familiare non è né l'unica né la principale delle reti di socialità, solidarietà, supporto che si sono attivate nell'emergenza.
In secondo luogo, che la DaD, una volta messa in opera ed esperita, sta alla didattica reale, fatta di interazione, fisicità, emozioni, come i cinepanettoni stanno a Kubrick e Antonioni. Nel corso delle settimane di lockdown sono via via scemate, fino al silenzio, quelle voci che si erano levate inneggianti alla rivoluzione digitale: esperita e subita in concreto da docenti, studentesse e studenti, famiglie, si è rivelata, se posso rubare la battuta, una cagata pazzesca (ma davvero, in questo caso). Non è un caso che persino il Comitato Tecnico ha dovuto riconoscere che la DaD non può essere un'alternativa alla didattica in presenza: a difendere la DaD sono rimasti solo i dirigenti dell'ANP, non a caso persone che la DaD non l'hanno praticata.
In terzo luogo, che quello scolastico non è semplice trasmissione di informazioni – il sostrato culturale che accomunava le due controriforme di Gelmini e Renzi (l'antifrastica "Buona Scuola"), ma lavoro di cura. Lo scrivevo dieci anni fa nel mio La scuola è di tutti: la scuola è lo specchio di una società impazzita nella quale, come in una crema che non si è amalgamata, i singoli elementi galleggiano separati qua e là. Al tempo stesso, la scuola è un'istituzione del comune che si oppone a questa broda disgustosa: le è stato dato questo compito, e volente o nolente se ne deve fare carico, così come le comunità migranti si prendono cura dei nostri anziani e dei nostri campi e vigneti, così come le donne si prendono cura, garantendo la riproduzione sociale, di settori sempre più ampi di un contesto sociale attraversato da barriere e fratture.
Tutto questo deve, come un vortice, attirare gli elementi positivi della scuola di ieri, e rilanciarli in quella del futuro.
Ma la scuola non è una torre d'avorio isolata dal mondo nel quale esiste e col quale intrattiene relazioni. E quindi non è possibile parlare della scuola nell'emergenza pandemica senza chiedersi cos'è stata questa emergenza. Una crisi di carattere sanitario, in prima battuta; le cui cause vanno però cercate non solo internamente, con un approccio limitato alla medicina e alla biologia, e ai nuovi esperti immunologi e virologi (a loro volta in conflitto), la cui expertise è stata ben raffigurata da Donatella Di Cesare con la figura del timoniere di Agamennone, esperto nell'arte della navigazione, ma ignaro del destino di morte cui conduce il suo sovrano portandolo a casa attraverso i mari in tempesta. L'attuazione della zoonosi, che di per sé non è una novità, è incomprensibile senza la consapevolezza dei processi che portano ecosistemi fino a ieri distinti a mescolarsi; processi che coinvolgono le migrazioni di viventi tanto umani quanto non umani, e che si intersecano in un feedback perverso con gli effetti del mutamento climatico. Processi che a loro volta coinvolgono le modalità sia corporali che mentali di abitare la condizione umana nella quale siamo gettati: non è casuale che lo stigma di questa condizione sia un sintagma che è anche il titolo di un felice libro che apriva gli Anno Zero, L'epoca delle passioni tristi. Ed è emblematico che persino un dirigente scolastico regionale (quello dell'Emilia-Romagna), in una lettera alle studentesse e studenti in quarantena, lo abbia citato.
Questa semplice ricognizione pone una questione: quante discipline sono necessarie per comprendere questi processi? In altri termini, è plausibile che un sapere spezzettato in discipline divise da compartimenti stagni, all'interno dei quali ogni singola disciplina è ulteriormente suddivisa in "competenze", "saperi minimi", "parole-chiave", mentre nuove gerarchie di saperi vengono prefigurate (ad esempio, in quel documento ministeriale che citavo in apertura) – è plausibile che un sapere così strutturato possa dar conto di una crisi che rimarrà come un orizzonte di possibilità per nuovi virus?
In tutta evidenza, no: non è pensabile che la scuola si chiami fuori da questo orizzonte, che si alieni da questa condizione umana che ci tocca abitare.
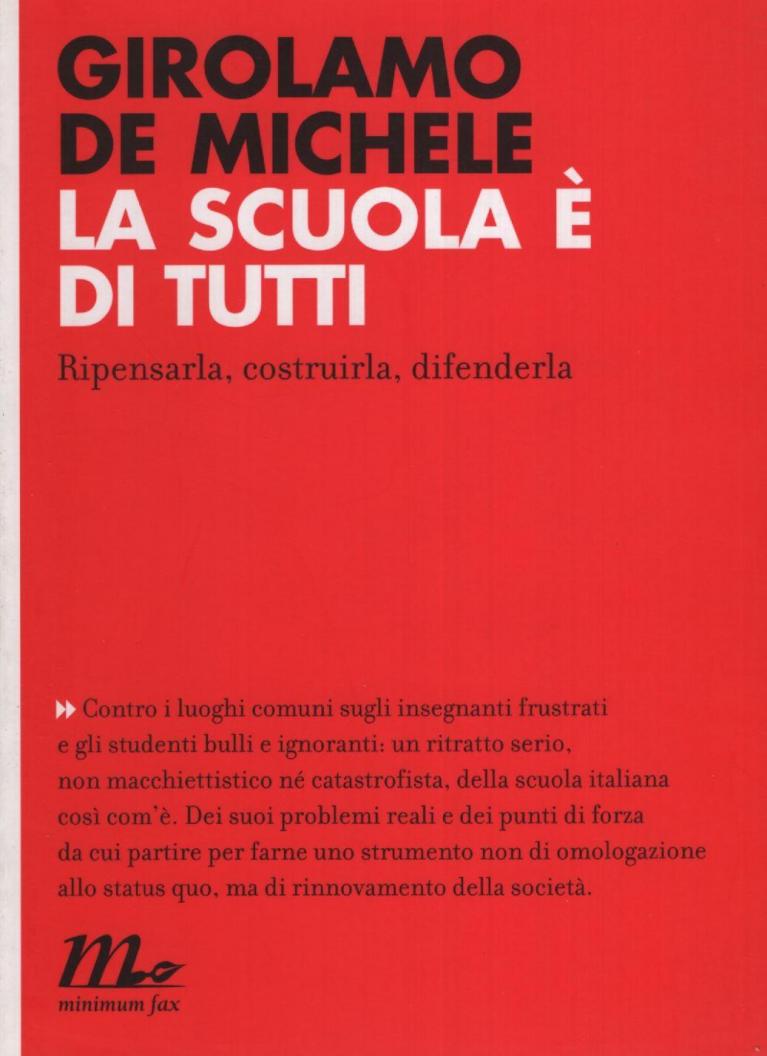
L'epistemologo Gregory Bateson chiamava questo sapere che connette invece di disperdersi e sfrangiarsi "ecologia della mente": e già nel 1969 parlava di crisi nell'ecologia della mente. Il filosofo Félix Guattari, agli inizi dei Novanta, parlava della crisi ecologica come uno dei corni di una crisi molteplice: ecologica, sociale, psichica. E chiamava questo sapere che tenesse insieme i tre corni "ecosofia". Lo storico bangladese Dipesh Chakrabarty chiama Antropocene l'epoca nella quale l'essere umano è diventato un fattore determinante del clima, e la studia con lo sguardo strabico di chi sa bene che se la crisi climatica ci chiama in causa come specie, al tempo stesso manifesta i suoi effetti secondo differenze e gerarchie di classe, genere, luogo: proprio come il coronavirus.
Quando mi viene chiesto che scuola vorrei, io penso che la fonderei su questi tre pensatori.
Ma c'è un altro nodo che il coronavirus, come un pettine, ha portato alla luce: una profonda crisi culturale e cognitiva, a tutti i livelli. Una crisi di cui sospettavamo l'esistenza, nella convinzione che l'evidenza mondo delle fake news, delle argomentazioni senza logica e senza costrutto, dei complottismi, fosse la punta di un iceberg del quale intuivamo la consistenza: quell'iceberg che Calvino (concludendo una discussione ventennale con Pasolini e Sciascia) aveva denominato "la peste del linguaggio"; una peste che «colpisce la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende tutte le storie informi, casuali, senza principio né fine». Un iceberg che Tullio De Mauro aveva cercato di descrivere attraverso la prima rilevazione degli apprendimenti, negli Anni Zero, sottolineando che «soltanto il 20% della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea», mentre per la restante parte, a diversi livelli di analfabetismo funzionale, «un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è un'icona incomprensibile».
E chiedendo a gran voce, invano, che ogni fondata riflessione sulla scuola e sul fare scuola partisse da qui. La crisi ha mostrato quanto grave sia questo diffuso analfabetismo funzionale. L'incapacità di costruire, leggere, interpretare una statistica; di saper connettere i dati; di saper leggere una comunicazione scientifica in lingua inglese senza l'ausilio di maldestri traduttori on line; la capacità di connettere causa ed effetto, di costruire un'affermazione sensata a partire da due premesse ben fondate: tutto questo si è mostrato in tutta la sua gravità non nel mondo social dove tutto vale tutto, ma anche nelle testate giornalistiche di livello: i peggiori negazionismi, complottismi hanno potuto sguazzare in queste pozzanghere. Un bravo divulgatore scientifico come Piero Angela appare, a fronte di quello che è stato narrato a partire da malcomprese pubblicazioni mediche e scientifiche, un gigante. In molti hanno scoperto che, per contro, bravi ricercatori dai loro spazi social, con tabelle e grafici interpretati in autonomia, erano più attendibili di quelli presenti sulla stampa mainstream. Al tempo stesso, abbiamo toccato con mano come l'immagine dello scienziato sia percepita dall'opinione pubblica in termini ante-galileiani e newtoniani: al conflitto delle facoltà fra biologi, immunologi e virologi si è aggiunto quello generato dal consenso della pubblica opinione verso guru sedicenti esperti, persino in ambienti che si credevano temprati dal pensiero critico. Il punto più basso è stato toccato, sperando che sia davvero il fondo, quando un redivivo don Ferrante è comparso ad annunciare che l'epidemia era inventata, ovvero esistente ma esagerata, con evidenze prodotte taroccando i numeri e ritagliando col metodo dei morceaux choisis parole altrui: è stato creduto, difeso, assunto a vate da una parte, per fortuna piccola ma significativa, della pubblica opinione, ma anche delle istituzioni filosofiche, a riprova che resta ancora grande «l'autorità di un dotto, quando vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi». E che la peste del linguaggio ha avvelenato pozzi e falde in profondità.
È da tutto questo che la scuola deve ripartire. Nella consapevolezza che ogni istituzione scolastica è presa fra due contemporanee esigenze e funzioni: assoggettare le/i discenti al sapere esistente, incatenando il presente al passato; o favorire la formazione di soggetti liberi, perché autonomi e creativi rispetto all'esistente, proiettando le soggettività verso il futuro. È in questa compresenza fra assoggettamento e processi di soggettivazione, che la scuola svolge la sua funzione: chiedersi qual è la scuola del futuro significa fare una scelta di campo fra i due poli di questa ellisse.
La scuola che verrà, dunque. Le politiche scolastiche dell'ultimo ventennio hanno consapevolmente guidato la scuola verso scenari che oscillano fra la conservazione che apre alle dinamiche di mercato, e la privatizzazione di ampi settori dell'educazione attraverso la dismissione e l'esternalizzazione verso il privato, o l'ingresso del privato nel pubblico. Per contrastare questa deriva, che appare trasversale fra le diverse coloriture delle forze politiche e le divers@ persone che hanno ricoperto il ruolo di ministro dell'istruzione, occorre essere consapevoli della direzione verso cui si vuole guidare la nave della scuola, per orientarne le vele. La direzione delle politiche di conservazione o di descolarizzazione va invertita verso uno scenario di riscolarizzazione, centrato sul riconoscimento dell'educazione come bene del comune, e sulla ricerca di alti livelli di motivazione (anche salariale) del corpo docente con massicci investimenti pubblici, e politiche che incentivano la fiducia nell’istruzione pubblica. La scuola deve tornare al centro delle attività comunitarie o di una pluralità di istituzioni educanti, all'interno di un processo di formazione permanente governato da politiche che favoriscono la coesione sociale e contrastano la formazione delle disuguaglianze, attraverso un reciproco scambio di processi formativi ed educativi fra scuola e società.
Al centro della scuola del futuro, che è una scuola che comincia già oggi, c'è tanto la sua funzione, quanto la sfida della complessità e della globalizzazione. Si tratta di chiedersi quale sapere, in quali forme strutturato, attraverso quale scaffalatura del sistema educativo organizzato, possa fornire i requisiti minimi, sia in termini di sapere che di saper fare, sia di contenuti che di capacità (mi si perdoni il lessico antiquato con cui sostituisco la terminologia à la page fra i nemici della scuola). La riforma della scuola media unica, all'inizio degli anni Sessanta, era fondata sul presupposto che, in quel tipo di società, la licenza media garantisse a tutt@ il sapere necessario per orientarsi in un mondo tutto sommato lento e locale. Si tratta di essere all'altezza di quella scommessa, e chiedersi oggi quale è il livello di sapere minimo necessario per orientarsi nella globalizzazione e nelle sue crisi sistemiche, e quali saperi specifici – ad esempio, logica e semiotica, di fatto assenti dai curricoli scolastici, se non per spizzichi e bocconi – possano fungere da raccordo fra le diverse aree e i diversi sitemi di apprendimento, dentro e fuori la scuola.
È inutile negarcelo: il prossimo anno sarà un anno di crisi, indipendentemente dalla riproposizione della pandemia. Una crisi che può essere bypassata, limitandosi a registrare il lascito di quest'anno in ulteriori moduli, piani, carte – il Piano Integrativo degli Apprendimenti, e il Piano di Apprendimento Individualizzato, il PIA e il PAI, che come le due gemelline di Shining appaiono davanti alle/ai docenti tenuti a compilarli prima ancora di sapere dove, come, quando faranno scuola il prossimo anno. Oppure cogliendo nella necessaria emergenzialità l'occasione per cominciare a ridisegnare il sistema di istruzione, a partire dalle esigenze che la crisi ha portato alla luce, e pretendendo che fondi, organici, istituti siano adeguati alle esigenze educative, piuttosto che adeguare queste nelle scarpe troppo strette delle risorse octroyées. Dopo tutto dovremo pur parlare di quel che è accaduto a studentesse e studenti di ritorno dalla quarantena.
L'emergenzialità permanente ha già mostrato il suo aspetto giuridico-legislativo, sotto forma di decreti e norme che di fatto hanno derogato e derogano dall'esistente: prendiamone atto, e chiediamo che questi stessi strumenti vengano utilizzati per più alte finalità. Ad esempio, restituendo collegialità al governo della scuola, ripristinando quelle istituzioni abrogate da Berlinguer, Moratti, Gelmini, Renzi. Ad esempio, sovvertendo l'attuale definizione degli organici e riportando in vita la promessa mai realizzata degli organici funzionali. Ad esempio, dando alle istituzioni collegiali – a partire dai collegi docenti – il potere costituente di riunirsi in assemblea per redigere dei Quaderni di lagnanze che dal basso porti alla elezione di Stati Generali dell'istruzione e della Conoscenza con potere costituente di ridisegnare l'edificio abitato dalla comunità educante, con porte aperte in entrata e in uscita verso la società – non verso i rapaci avvoltoi di Confindustria, ma in relazione con le mille forme di socialità e solidarietà che si sono manifestate in questa emergenza.
Non è un programma ministeriale: se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, recita uno dei miei breviari. È il programma della scuola che riparte, che vuole ripartire: ripartire le ricchezze privatizzate, gli edifici sfitti, il denaro accumulato con lo sfruttamento del lavoro e dei lavoratori. Ripartire gli spazi vuoti per ampliare quelli scolastici, ripartire le destinazioni dei terreni edificabili per ripartire le comunità scolastiche in nuove scuole, più grandi e più belle, perché oltre al pane e ai devices vogliamo anche le rose, vogliamo il diritto a tutte le cose belle; ripartire il potere gestionale dei dirigenti scolastici e dei servizi amministrativi nella collegialità del comune; ripartire i ruoli sociali definiti dalla rigidità sociale abbattendo pareti e soffitti di vetro, ma anche sciogliendo la colla che fissa le scarpe ai pavimenti, perché il mondo che verrà sia davvero una terra delle pari opportunità; ripartire i piani dell’ascensore sociale nell’orizzontalità di una costruzione senza piani; ripartire le ricchezze dell’1% nel 99%.
Ripartire, per davvero.









