Il rischio minimo dell'utopia
C’è un episodio, che Arjun Appadurai riprende due volte nel corso del testo Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale (trad. di M. Moneta e M. P. Ottieri, Milano, Raffaello Cortina), da cui vale la pena iniziarne la presentazione. La circostanza è quella di un importante incontro internazionale organizzato presso la sede delle Nazioni Unite a New York sull’abitare urbano. Un evento ufficiale, nel cuore della città più sofisticata del mondo e sostanzialmente egemonizzato dalle grandi organizzazioni nazionali. In tale contesto, le associazioni e le organizzazioni di abitanti degli slum delle grandi metropoli del mondo (con cui Appadurai stesso collabora a Mumbai), piegata la resistenza ufficiale dell’Onu, riescono ad allestire “uno straordinario episodio di teatro-guerriglia”.

Con le proprie mani e con materiali di fortuna, con la competenza maturata come abitanti di aree urbane segnate dal massimo degrado, dall’estrema deprivazione materiale e umiliazione morale, costruiscono proprio nell’atrio d’ingresso del palazzo Onu un piccolo modello di casa e altri di gabinetti per bambini. Non sembri bizzarra la scelta di questi oggetti di dimostrazione: queste associazioni lavorano con persone la cui vita quotidiana è caratterizzata dall’essere senza abitazione e quindi privi di accesso ai servizi indispensabili, continuamente esposti all’insicurezza, al rischio di malattia, all’umiliazione (a partire dalla costrizione a defecare in pubblico). I rappresentanti di agenzie internazionali, l’allora segretario Onu Kofi Annan, si trovarono a dover attraversare quella mostra informale, circondati da canti e da balli di donne e attivisti dell’India e del Sudafrica, nonché dai delegati ufficiali e dai visitatori, trasformati in pubblico di questa rappresentazione.
Fuori da ogni cerimoniale vennero tenuti brevi discorsi e in un temporaneo sovvertimento dell’ordine costituito di questo genere di meeting, tutti “compresero che si trattava di un momento magico”. Il significato di quell’evento va colto riconducendolo a quella che Appadurai definisce la politica della merda. “Quando un funzionario della Banca Mondiale – scrive l’antropologo – deve esaminare le virtù di un gabinetto pubblico e discutere con gli abitanti degli slum i meriti di questa forma di gestione della merda, la loro condizione di povertà cessa di presentarsi come abiezione per trasformarsi in soggettivazione”. Una politica del riconoscimento dal basso, una politica cioè che cambia i termini di riconoscimento e attraverso la quale anche coloro che sono destinati ai ruoli e alle condizioni più umili – gli intoccabili, che hanno il compito di liberare le caste elevate dei loro escrementi, i senza casa privi di servizi igienici essenziali, etc. – accedono alla condizione di soggetto competente ad esprimersi ed avere voce sulla definizione dei problemi che li riguardano e sulle decisioni collettive che quei problemi intendono affrontare.
I capitoli del volume sono suddivisi in tre parti. La prima, Geografie in movimento, si apre con la ripresa di un’ampia e approfondita discussione, sui vari terreni delle scienze sociali, della vita sociale delle cose e del modo in cui esse, in qualsiasi contesto, divengono merci: “il punto importante è che la merce non è un certo tipo di oggetto piuttosto che un altro, ma una fase nella vita di alcuni oggetti”. Visto da Mumbai, la seconda parte, tratteggia una riconcettualizzazione dell’idea di cultura e del rapporto che essa intrattiene con la possibilità di divenire soggetti di autodeterminazione degli individui, anche dei più marginali, di estrema importanza e di profonda passione civile e intellettuale. Una riconcettualizzazione tessuta attraverso un continuo andirivieni tra archivio scientifico e partecipazione diretta a progetti ispirati alla “politica della possibilità” (contrapposta alla “politica della probabilità”). Nella terza, Fare il futuro, vengono esplorati diversi temi – la modernizzazione, il design, la finanza –nel tentativo di delineare una prospettiva di “cosmopolitismo dal basso”.
Il filo del ragionamento di fondo con cui vengono rielaborati materiali derivanti da decenni di lavoro è ben poco disciplinare. Esso è rinvenibile nell’obbiettivo, indicato dallo stesso Appadurai, di dare corpo ad una “etnografia dell’aspirazione” alimentata da una rilettura della strumentazione delle scienze sociali attraverso l’esperienza diretta di due progetti, in cui la dimensione cognitiva della ricerca si combina con quella dell’impegno civile e politico in senso lato. Da un lato, la collaborazione con le associazioni di abitanti degli slum cui già accennavo. Dall’altro, l’esperienza di lavoro – che Appadurai stesso ha contribuito a fondare – con Partners per la conoscenza, l’azione e la ricerca urbana: un’organizzazione attraverso la quale giovani di Mumbai ai margini del sistema educativo collaborano con ricercatori, architetti, ma anche operatori cinematografici, giornalisti, allo scopo di realizzare indagini e proposte sul contesto urbano in cui quei giovani vivono.
Un progetto che pratica l’idea della ricerca come “diritto umano (...) agli strumenti tramite i quali qualsiasi cittadino possa incrementare in modo sistematico” la conoscenza (nell’originale, Appadurai non usa l’espressione “capitale conoscitivo” che si trova purtroppo nella traduzione italiana) per migliorare la propria vita. È dunque il tema della “capacità di aspirare” come capacità culturale, non equamente distribuita nella società, di immaginare e argomentare (anche attraverso la protesta) una vita migliore, la polarità che orienta questo profondo lavoro di rielaborazione. Un tema che inizia finalmente a ricevere qualche attenzione anche nel nostro paese (vd. Il futuro nel quotidiano: studi sociologici sulla capacità di aspirare, a cura di O. de Leonardis e M. Deriu, Egea, 2012).
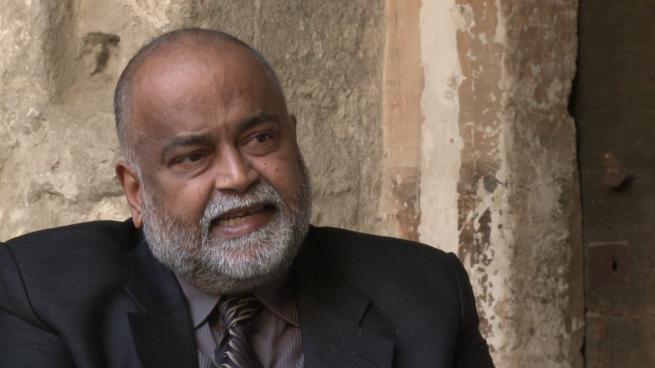
Il volume, discusso sul numero in corso di pubblicazione della Rassegna italiana di Sociologia, compie nella parte finale un’ampia esplorazione di cosa voglia dire declinare su scala globale un approccio che parte dalla “politica della merda” e dalla “democrazia profonda”, cioè da una democrazia che trova espressione nella “trasformazione degli ideali borghesi costituzionali in quotidiane forme di consapevolezza e di comportamento (…) in cui le voci del debole, del molto povero e delle donne in particolare trovino pieno ascolto”. La modernizzazione, imposta al resto del mondo attraverso il cosmopolitismo europeo, ha praticato un rapporto tra conoscenza e costruzione del mondo intrappolato nel “traiettorismo”, cioè nell’idea “che la freccia del tempo abbia un telos e che in questo telos vadano rintracciati tutti i significativi modelli di cambiamento, di processo e di storia”. Una visione il cui esito finale si trova nella “fortezza Europa”.
La proposta di un “cosmopolitismo dal basso” delineata da Appadurai si configura appunto come un’alternativa progettuale che riguarda direttamente l’Europa e che esige di correre due rischi: quello di “individuare sorgenti alternative del sé europeo, sempre in evoluzione, sorgenti che, in quanto strategie mondiali, potrebbero rivelarsi più congeniali al dialogo che al dominio”; quello di “sforzarsi di esplorare con maggiore empatia i modi alternativi in cui altre società e civiltà hanno immaginato la cosmopoli”.
Scrivo questa recensione durante un periodo di lavoro presso l’Istituto di Studi Avanzati (Nantes, Francia). Inaugurata pochi anni fa con grande lungimiranza, questa preziosa struttura è finalizzata a ospitare e far lavorare insieme studiosi del Nord e del Sud del mondo su molti dei temi affrontati da Appadurai. Le elaborazioni che qui arrivano da molte e diverse parti del mondo restituiscono tutta l’attenzione, ma anche tutta l’impazienza con cui al progetto europeo, ormai, si guarda nel mondo: i rischi che indica Appadurai non solo vanno corsi, ma sono dunque da intraprendere con estrema urgenza.
Questo articolo è apparso su il manifesto









